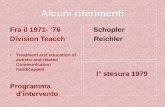Social Network Analysis applied to co-citation network ... Tur… · Web viewEsiste un nucleo...
Transcript of Social Network Analysis applied to co-citation network ... Tur… · Web viewEsiste un nucleo...
LE MOLTEPLICI INTERPRETAZIONI DELLA REALTÀ ORGANIZZATIVA:
GUERRE DI PARADIGMI E CONTRAPPOSIZIONE TRA TEORIE
IN 9 ANNI DI CITAZIONI TRA EUROPA E STATI UNITI *.
Alessandro UsaiUniversità Bocconi di Milano
Carlo TuratiUniversità di Lecce
* Questo lavoro è stato reso possibile dal progetto di ricerca di base dal titolo “L’evoluzione delle teorie organizztaive e dei paradigmi manageriali nel pensiero nord-americano ed europeo”, finanziata dall’Università Bocconi di Milano. Gli autori ringraziano inoltre Francesca Ramponi, Arianna Rossi e Giorgia Retrosi per il supporto fornito durante la ricerca, Giuseppe Soda per gli spunti di riflessione forniti nella fase iniziale del lavoro ed infine Howard Aldrich e Joe Galaskiewicz per gli utili commenti apportati in sede di presentazione del lavoro presso l’International Sunbelt Network Conference, 13-16 aprile 2000, Vancouver (Canada).
ABSTRACT
L’interpretazione della realtà organizzativa si fonda sullo sviluppo e sull’utilizzo di
teorie volte a spiegare il comportamento degli individui ed i fenomeni organizzativi più
in generale. La disciplina organizzativa tuttavia si caratterizza per la mancanza di teorie
dominanti e per la molteplicità delle spiegazioni e dei riferimenti teorici fondamentali.
Durante il decennio passato gli studi organizzativi sono stati attraversati da un vivace
dibattito riguardante la commensurabilità dei paradigmi organizzativi e gli spazi di
integrazione esistenti tra la scuola organizzativa europea e la scuola statunitense. Il
dibattito ha raggiunto punte di contrapposizione molto forte su alcune delle più
importanti riviste organizzative mondiali, al punto da essere soprannominato la “guerra
dei paradigmi”. Tuttavia, poco sforzo è stato dedicato ad analizzare empiricamente la
reale vicinanza dei paradigmi e delle due scuole continentali.
Il presente lavoro intende fornire una risposta empirica al dibattito riguardante la
molteplicità delle spiegazioni organizzative. Ispirato da un precedente lavoro di Usdiken
e Pasadeos (1995), l’articolo presenta i risultati di un’analisi delle citazioni e delle reti
di co-citazioni , utilizzando come fonte le bibliografie degli articoli apparsi sulle riviste
Administrative Science Quarterly e Organization Studies nel periodo 1990-1998. Le
due riviste sono state scelte a rappresentanza delle due scuole continentali. Attraverso
l’utilizzo di tradizionali tecniche bibliometriche e con il supporto della Social Network
Analysis, lo studio utilizza una prospettiva longitudinale comparando le strutture di co-
citazione nelle due riviste in tre trienni consecutivi (1990-1992; 1993-1995; 1996-
1998).
2
I risultati mostrano come esistano ancora importanti differenze tra il contesto europeo e
statunitense ma anche come la base di riferimenti condivisi sia in espansione. Alcune
teorie sembrano inoltre caratterizzarsi per una minore dipendenza culturale, costituendo
di fatto il terreno di intesa della disciplina a livello mondiale. Le stesse teorie
rappresentano anche il punto di riferimento stabile durante il passare delle “ere”
disciplinari.
D’altro lato, lo studio mostra anche come gli sforzi di convergenza non siano del tutto
bilanciati, dal momento che quasi tutti i riferimenti teorici che fungono da “ponte” tra i
due continenti sono di origine statunitense. Al contrario, gli studiosi europei sembrano
ancora assenti dalla base intellettuale della disciplina organizzativa negli Stati Uniti. Lo
studio infine suggerisce un possibile ciclo di vita relazionale delle “mode” teoriche
principali.
Una riflessione finale riguardo al significato della molteplicità teorica nella disciplina
organizzativa ed alle possibilità di analisi empirica dei paradigmi, adottando un
approccio relazionale allo studio delle citazioni, concludono il lavoro.
3
1. LA MOLTEPLICITÀ DELLE TEORIE ORGANIZZATIVE
Gli studi organizzativi costituiscono una disciplina relativamente recente all’interno
della famiglia delle scienze sociali. Tuttavia, la disciplina ha assistito negli ultimi
decenni ad una vera e propria proliferazione di contributi teorici ed empirici tra loro
molto eterogenei e talvolta inconciliabili. Da un certo punto di vista questa
proliferazione è stata considerata come il sintomo di una elevata vitalità disciplinare, al
contrario altri studiosi hanno visto in questa caratteristica una pericolosa debolezza.
Questa contrapposizione ha spesso avuto ragioni di tipo epistemologico, opponendo la
visione di una disciplina in cui possono e devono coesistere tante possibili spiegazioni
del reale, ad una visione più determinista e prescrittiva che vorrebbe la disciplina
organizzativa capace di fornire chiare e univoche spiegazioni e di conseguenza
indicazioni di comportamento per le organizzazioni e gli individui che in esse agiscono.
In questo senso ad esempio può essere letto il duello avvenuto tra Pfeffer (1993; 1995) e
Van Maanen (1995a; 1995b) nella metà degli anni novanta. Pfeffer da un lato auspica
l’affermazione di pochi paradigmi dominanti all’interno della disciplina organizzativa,
come presupposto perchè questa esca dalla confusione e abbia la possibilità di essere
considerata maggiormente “scientifica”, sull’esempio dell’Economia. Van Maanen al
contrario aberra la proposta di una scelta “maggioritaria” in tema di paradigmi, che oltre
ad essere guidata da ragioni di “politica” accademica, causerebbe l’emarginazione
scientifica della prospettiva non-reificante e fenomenologica allo studio dei fenomeni
sociali (Van Maanen, 1995a). Senza entrare nella complessa questione epistemologica
che questo dibattito comporta, è evidente che la disciplina organizzativa costituisce un
mare molto variegato (per approfondimenti si vedano tra gli altri: Astley e Van de Ven,
1983; Donaldson, 1988; Burrell e Morgan, 1979; Gioia e Pitre, 1990; Aldrich, 1988;
4
Wilmott, 1993; Jackson e Carter, 1991).
Hofstede (1996) ha di recente ricordato come la teoria della Gerarchia Generale dei
Sistemi (Boulding, 1956; Von Bertalanffy, 1968) ci dia una buona spiegazione del
perché nelle scienze sociali è difficile immaginare paradigmi dominanti e
successivamente sostituiti in modo rivoluzionario, come Khun aveva ipotizzato nel caso
delle scienze naturali. Il ragionamento è suggestivo e merita di essere richiamato. La
gerarchia dei sistemi è composta di nove livelli ed ogni livello successivo aggiunge una
dimensione di complessità. Le dimensioni sono le seguenti, in ordine di crescente
complessità: 1 - Framework (statico), 2 - Clockwork (meccanico), 3 - Control
(cybernetic) (controllo), 4 - Cell (homeostatic) (cellulare), 5 - Plant (vegetale), 6 -
Animal (animale), 7 - Man (umano), 8 - Social (sociale), 9 - Supernatural
(soprannaturale).
In questo schema della realtà, gli oggetti di studio delle discipline scientifiche
appartengono quindi a livelli di complessità differenti. Il mondo sociale è al livello 8, la
medicina a livello 7, la biologia ai livelli 4-6, la fisica ai livelli 1-4. E’ possibile notare
come le scienze sociali siano le sole scienze in cui lo scienziato (al livello 7) è meno
complesso del proprio oggetto di studio (al livello 8). Da questa notazione Hofstede trae
spunto per sottolineare come le scienze sociali siano quindi per definizione soggettive e
parziali, e come la ricerca di un consenso assoluto intorno ad un paradigma, così come
accade nelle scienze naturali, sia una mera illusione.
Coerentemente con queste posizioni alcuni studiosi hanno sottolineato come la teoria
organizzativa non si limiti a riflettere la realtà ma contribuisca alla creazione di questa
(Astley and Van de Ven, 1983). Astley (1985) successivamente è arrivato a sostenere
che le verità della teoria organizzativa siano puramente il frutto di una costruzione
5
sociale. A testimonianza di quanto questa ipotesi sia verosimile è sufficiente ricordare
quanto l’evoluzione delle teorie organizzative abbia apparentemente risentito delle
differenze culturali tra gli studiosi appartenenti ad ambiti geografici diversi.
Il presente studio prende spunto da queste considerazioni riguardo alla natura della
disciplina organizzativa e cerca di analizzare in maniera empirica l’effettiva evoluzione
della disciplina nel corso dell’ultimo decennio in particolare, cercando le radici della
differenziazione teorica tra i due più importanti contesti geografici in cui le teorie
organizzative sono state sviluppate: gli Stati Uniti e l’Europa.
2. LA MOLTEPLICITÀ DELLE TEORIE IN EUROPA E STATI UNITI: CONVERGENZA O
DIVERGENZA?
Più di vent’anni or sono Kassem diede origine ad una diatriba destinata a durare nei
decenni, comparando i quindici contributi di autori europei, apparsi sul volume
“Europeans Contributions to Organization Theory”, con quella che egli riteneva essere
la teoria organizzativa dominante all’epoca negli Stati Uniti. Il risultato del confronto è
una lista di dimensioni sulla base delle quali le due tradizioni sembravano differire. Tra
le principali conclusioni dell’autore possiamo ricordare le differenze riscontrare
riguardo a: il livello di analisi (micro in USA e macro in Europa); la disciplina
dominante (organizational psychology negli USA e organizational sociology in
Europa); l’ideologia di fondo (basata sull’armonia negli USA e basata sul conflitto in
Europa); l’obiettivo principale degli autori più influenti (pragmatico e orientato alla
risoluzione dei problemi in Nord America, più teorico ed astratto nel contesto europeo);
la metodologia ed il metodo (positivista e supportato dall’uso di esperimenti di
6
laboratorio e di questionari negli USA, più fenomenologico e basato sullo studio
comparativo di casi in Europa).
Negli anni successivi (si veda Usdiken e Pasadeos, 1995, per una sintesi) la disciplina
sulle due sponde dell’oceano vive una fase di convergenza. Questo cambiamento è
causato principalmente dall’emergere di un filone di ricerca di origine britannica,
l’approccio delle contingenze strutturali, come paradigma dominante tanto in Europa
quanto negli USA. D’altro lato la separazione avvenuta in Nord America tra
Organization Theory e Organizational Behavior porta le due tradizioni continentali a
convergere maggiormente anche sul livello di analisi più macro. Alla fine degli anni
settanta tuttavia ancora una volta l’ondata convergente sembra invertire il suo corso.
Hinings (1988) ha sostenuto che le differenze tra Stati uniti ed Europa esistono e che
sono dovute principalmente al fatto che mentre nel contesto nordamericano la teoria
organizzativa è nata come disciplina relativamente autonoma avendo come sedi
principali di genesi ed elaborazione le Business Schools, in Europa essa è cresciuta
nell’ambito della sociologia delle organizzazioni, avendo come punti di riferimento
accademico i dipartimenti di sociologia. L’argomento dell’autore, di stampo
marcatamente ma non dichiaratamente neo-istituzionalista (Powell e DiMaggio, 1991),
è che i due contesti istituzionali in cui è avvenuta la gestazione della disciplina abbiano
comportato una differenza negli obiettivi di chi ha studiato l’organizzazione, portando i
nordamericani a sviluppare interessi più pratici e normativi e gli europei a preferire un
approccio più astratto. In questa visione non sarebbe una differenza di tipo culturale a
causare le distanze disciplinari tra i continenti ma piuttosto la diversa collocazione
istituzionale degli studiosi nei due contesti a comportare una divergenza tanto nei temi
affrontati quanto nella metodologia preferita. Tuttavia, in uno dei pochi studi di tipo
7
empirico, Aldrich (1988) avendo studiato le citazioni a cominciare dai primi anni
ottanta, sembra invece preferire l’argomento della convergenza. Sebbene riconosca che
esistano diversi paradigmi in lotta all’interno della disciplina, egli suggerisce che le
diversità non abbiano in realtà una spiegazione di tipo geografico. Negli anni successivi
Lammers (1990) ha apportato ulteriore supporto alla teoria della convergenza, che nella
visione dell’autore sarebbe il risultato di una dominanza nordamericana affermatasi
nella recente evoluzione della disciplina e testimoniata dalla capacità dei contributi
teorici d’oltreoceano di costituire paradigmi di riferimento a livello mondiale. Questa
percezione del problema sembra in quel periodo condivisa anche nel contesto
nordamericano e non senza spunti polemici. Boyacigiller e Adler (1991) arrivano a
definire l’approccio dominante di matrice anglosassone come un “dinosauro
campanilista” e denunciano come i valori culturali degli Stati Uniti abbiano pervaso tutti
gli studi manageriali (e tra questi le teorie organizzative) portando con sé un
universalismo tanto implicito quanto inopportuno.
Altri autori, principalmente europei, contrastano la visione convergente ed americo-
centrica dell’evoluzione disciplinare e ricercano piuttosto le basi della differenza,
cercando di riprendere ed approfondire lo spunto originario di Kassem. Nel capitolo
finale del volume “Research in the sociology of organization: studies of organization in
the European tradition”, Bacharch, Gagliardi e Mundell (1995) propongono quattro
criteri che sembrano caratterizzare l’approccio europeo: 1) eclettismo e
multidisciplinarietà, 2) tendenza a contestualizzare socialmente le organizzazioni
studiate, 3) sofisticazione ma anche ambiguità riguardo alla questione epistemologica,
4) particolarismo piuttosto che non universalismo. Questa proposta tuttavia viene
immediatamente contrastata sulle pagine di Administrative Science Quarterly da
8
Lammers (1998) che sostiene come l’eclettismo, la multidisciplinarietà ed il
particolarismo abbondino non soltanto in Europa ma anche in Canada e negli Stati
Uniti, e critica il metodo seguito dagli autori nel formulare le proprie affermazioni
sostenendo che queste dovrebbero essere testate esaminando un insieme ampio di dati
ed osservazioni e non pochi articoli inclusi in una raccolta.
Nei medesimi anni Koza e Thoenig (1995) curano un numero speciale di Organization
Science dedicato ad accogliere alcuni contributi di ricerca europei che “gli studiosi
americani potrebbero non avere l’opportunità di leggere altrimenti”. Questa motivazione
per il volume denuncia un’asimmetria sistematica nella conoscenza e nel
riconoscimento reciproco tra i due continenti. Nella visione degli autori la ricerca
europea, malgrado la sua frammentazione, è caratterizzata da alcuni temi comuni di
discussione: la questione epistemologica; l’utilità dei modelli organizzativi; l’approccio
post-modernista; la contestualizzazione culturale dei modelli organizzativi; l’approccio
simbolico; la concezione politica dell’organizzazione; l’importanza di variabili
organizzative “implicite” quali il tempo, le emozioni, l’estetica, nella spiegazione dei
fenomeni organizzativi. Alcune di queste tematiche stanno emergendo anche negli Stati
Uniti ma gli autori sottolineano come questo fenomeno sia tuttora marginale nel
dibattito. Oltre alle tematiche, gli autori individuano differenze anche nella metodologia
accettata e diffusa nei due contesti: meno deterministica la prospettiva europea, più
positivista quella americana dove le teorie causali, il ragionamento deduttivo, la
misurazione, e l’analisi quantitativa di campioni rappresentativi di popolazioni domina
lo scenario. Koza e Thoenig infine sottolineano come alcune aree comuni si siano
comunque affermate, partendo però da una produzione di origine nordamericana, quali
ad esempio le teorie dei costi di transazione, la visione ecologica, il neo-
9
istituzionalismo. Le ragioni di una mancata maggiore convergenza vengono attribuite
dai due autori d’oltralpe a motivi quali le differenze tra i percorsi di carriera accademica
e di pubblicazione esistenti nei diversi sistemi-paese, le differenze linguistiche ed il
pregiudizio reciproco esistente sulle due sponde dell’oceano.
Un ulteriore modo di cogliere le differenze tra i due sistemi consiste nell’analisi dei
manuali di organizzazione pubblicati nei due continenti. In questo senso, recentemeente
Clegg e Hardy (1996) nell’introduzione all’Handbook of Organization Studies da loro
curato notano come anche l’utilizzo intellettuale del medesimo autore, nel loro esempio
Weber, filtrato attraverso diversi obiettivi disciplinari e diversi retroterra “politici”,
abbia portato gli americani a sviluppare l’approccio funzionalista agli studi di
management, mentre lo stesso autore ha condotto gli europei a focalizzarsi sulle
strutture di potere, sulle norme e sulle procedure esistenti nel mondo moderno. Nella
recensione del medesimo Handbook, che ricordiamo ospita contributi di entrambe le
sponde dell’oceano, Zamutto (1998) ricorda come agli occhi del lettore americano il
libro proponga due modi diversi di guardare alle organizzazioni, il primo concentrato
sul management e sul funzionamento delle organizzazioni (la visione dominante
americana), il secondo focalizzato sulle dinamiche sociali e di potere (la visione
europea).
Una spiegazione di tipo culturale del dibattito è invece quella proposta da Hofstede
(1996), secondo il cui approccio la teoria organizzativa, come tutte le altre costruzioni
sociali, non può essere considerata culture free. Al contrario, “le persone che
concepiscono e scrivono teorie sono nate e cresciute in Paesi, hanno imparato il modo di
parlare ma anche di pensare dello specifico paese, sono andati a scuola in quel Paese …
come avrebbero potuto le loro idee sfuggire all’influenza della cultura nazionale?”.
10
3. CONVERGENZA O DIVERGENZA? LE ANALISI EMPIRICHE
Come appare chiaramente dalle pagine precedenti il dibattito qualitativo sulle differenze
tra le due tradizioni continentali e sulla convergenza/divergenza dei paradigmi è stato
molto ricco ma talvolta anche contraddittorio. Diversi autori hanno richiamato la
necessità di affrontare la questione attraverso un’analisi più sistematica delle
proposizioni sostenute.
In questa direzione esistono alcuni contributi importanti che hanno cercato di fare un
po’ di chiarezza, a cominciare dallo studio di Usdiken e Pasadeos (1995) che ha
costituito lo spunto principale per la nostra analisi empirica.
Gli autori affrontano la convergenza come un problema empirico e applicano le tecniche
dell’analisi bibliometrica (analisi delle citazioni e delle co-citazioni) al fine di
confrontare le basi intellettuali degli autori pubblicati nel periodo 1990-1992 su una
rivista rappresentativa del dibattito organizzativo americano (Administrative Science
Quarterly) e gli autori di una importante rivista europea (Organization Studies). Usdiken
e Pasadeos tracciano un panorama molto articolato, all’interno del quale coesistono
elementi di similarità e di differenza. Soltanto tre fonti appaiono in entrambe le liste dei
contributi più citati e non c’è neanche una fonte comune tra le 10 citazioni più frequenti
nelle due riviste. Inoltre, mentre i pezzi più citati dagli americani tendono ad essere
articoli di riviste, gli europei sembrano prediligere la citazione di libri. Adottando lo
schema proposto da Jepperson (1991), gli autori osservano come le due basi intellettuali
differiscano su due dimensioni principali: il livello di analisi al quale vengono
sviluppati gli argomenti teorici ed il livello al quale i fenomeni vengono originariamente
11
concepiti come socialmente costruiti. L’analisi organizzativa americana tende ad
ascrivere le spiegazioni causali a effetti di ordine superiore o macro (sia l’Ecologia delle
popolazioni, sia il Neo-istituzionalismo accettano il fatto che l’ambiente domini le
organizzazioni) ed anche ad adottare un orientamento ontologico a basso contenuto di
costruzione sociale. D’altro lato, l’analisi delle strutture di citazione degli europei
mostra una tendenza a prediligere fonti teoriche che danno più spazio al libero arbitrio
nelle organizzazioni, con una maggiore enfasi posta sul potenziale di scelta strategica e
di cambiamento delle organizzazioni. Gli autori mettono anche in luce come in
particolare il contributo teorico di matrice britannica sembri più fortemente
caratterizzato da un visione a forte costruzione sociale e più indeterminista, rispetto al
resto dei contributi europei.
Non esistono molti altri studi empirici che abbiano analizzato l’evoluzione della
disciplina organizzativa. Tra questi Danell, Engwall e Persson (1996; 1997) hanno
studiato la base di riferimento intellettuale di ASQ facendo un’analisi delle citazioni
apparse nella rivista nel periodo 1981-1992, per un totale di 292 bibliografie
considerate. Dallo studio emerge come ASQ abbia un orientamento principalmente
nordamericano nelle citazioni di riferimento, ma anche come la stragrande maggioranza
delle fonti citate (4 su 5) riceva una sola citazione nei 12 anni considerati, come i lavori
più citati siano i “classici” dell’organizzazione e come le fonti più citate siano
relativamente stabili nel tempo.
Infine, ancora Usdiken e Pasadeos (1999) hanno concentrato la loro attenzione sulla
produzione scientifica americana (Administrative Science Quarterly e Academy of
Management). In questo secondo contributo gli autori hanno applicato la content
analysis agli articoli usciti sulle due riviste nel periodo compreso tra il 1980 ed il 1995.
12
Dallo studio emerge con chiarezza una netta diminuzione dei pezzi teorici a favore di
una prevalenza dei contributi empirici e di una diffusione capillare di disegni di ricerca
basati sul test di ipotesi su campioni di studio, parallelamente ad una diminuzione dei
contributi qualitativi e con oggetto di studio non-aziendale.
Malgrado questi sporadici sforzi empirici, molti aspetti riguardanti il dibattito sulla
convergenza o divergenza dei paradigmi nei due continenti resta insoluto. La
convergenza infatti è un fenomeno processuale e può essere analizzato compiutamente
soltanto attraverso un disegno di ricerca longitudinale. Sebbene le reti di co-citazioni
proposte da Usdiken e Pasadeos (1995) forniscano una rappresentazione utile, esse
restano due “fotografie” istantanee della struttura di citazioni di ASQ e OS e perché si
possa percepire la dinamica dei paradigmi è necessario aggiungere altre fotografie dal
cui confronto si evidenzino gli aspetti di cambiamento delle strutture intellettuali dei
due continenti.
La presente analisi ha quindi cercato di coprire questa mancanza, prendendo spunto là
dove Usdiken e Pasadeos hanno concluso il loro studio.
In particolare lo studio cerca di rispondere alle seguenti domande di ricerca:
Esiste una struttura della base intellettuale “organizzativa”? Quali ruoli svolgono
diversi tipi di citazione al interno di questa struttura?
Una volta identificata la struttura:
Quali autori costituiscono la base condivisa di riferimento tra le due tradizioni
continentali? Quali i ponti tra continenti e tra paradigmi differenti? Quanto sono simili
13
i trend evolutivi della disciplina sulle due sponde dell’oceano? Quanto sono presenti
nei due contesti paradigmi dominanti e tra loro incommensurabili? Ed infine, su quali
basi si fonderà il dialogo disciplinare nei prossimi anni?
Al fine di rispondere a queste domande abbiamo adottato tecniche di analisi
bibliometrica parallelamente a tecniche di rappresentazione grafica relazionale,
applicate allo studio delle bibliografie apparse nel decennio passato su ASQ e OS.
4. METODO
4.1. Analisi bibliometrica e analisi delle citazioni
Lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo della conoscenza in tutti i campi di studio
accademico dipendono dalla circolazione della idee attraverso pubblicazioni che
appaiono su riviste e su libri a carattere scientifico. Lo studio delle tracce visibili delle
idee ha ricevuto una crescente attenzione nella seconda metà del secolo scorso (Price,
1963; Crane, 1972; White e McCain, 1989), fino a raggiungere lo status di disciplina
autonoma all’interno delle Scienze della Comunicazione. Recentemente molti studiosi
hanno adottato la proposta di Prichard (1969, p.349) che definisce genericamente la
Bibliometria come “l’applicazione di metodi statistici e matematici ai libri ed agli altri
mezzi di comunicazione”. Da allora, tra le altre, anche la maggior parte delle discipline
appartenenti alle Scienze Sociali sono state oggetto di studio attraverso tecniche
bibliometriche e analisi delle citazioni (si vedano Romano e Ratnanunga, 1996, pp. 7-8,
per una sintesi).
Price (1986, pp. Vii-x) ha sottolineato come la bibliometria, attraverso l’analisi
14
sistematica delle “reti scientifiche” costituisce la chiave per svelare la forma e le
dinamiche dei cosiddetti “invisible colleges”, ovvero delle scuole di pensiero che non
necessariamente sono identificate con una istituzione in particolare, e lo stesso Kuhn
(1970, pp. 252-253) descrive la comunità scientifica in termini di legami tra citazioni e
riconoscimento delle idee altrui. Più di recente Lievrouw (1990) ha spiegato come la
bibliometria sia lo strumento più adatto per studiare la struttura delle comunicazioni tra
studiosi, anche quando a queste strutture bibliografiche non corrisponda
necessariamente l’esistenza di processi di comunicazione in senso stretto.
4.2. Dallo studio delle citazioni allo studio delle co-citazioni
Lo studio bibliometrico delle citazioni in generale si fonda su alcuni assunti che è
opportuno ricordare, a cominciare dal significato che le citazioni hanno per coloro che
le utilizzano. Alcuni hanno sostenuto che il valore dell’analisi delle citazioni “deriva
dall’assunzione che un articolo o un libro molto citati sono evidentemente considerati
importanti da un ampio numero di studiosi” (Usdiken e Pasadeos, 1995, p.508) e che le
citazioni fatte in un articolo scientifico ne costituiscono la base intellettuale (Danell et
al., 1996). Recentemente Baldi (1998) ha fornito ampio supporto empirico a questa
posizione, mostrando come il processo di citazione rifletta prevalentemente il
riconoscimento di un debito di tipo intellettuale, piuttosto che non un mero strumento
retorico oppure un mezzo di riconoscimento influenzato da fattori sociali quali
l’appartenenza ed i legami professionali o amicali.
In questo lavoro quindi si assume che le citazioni non siano l’effetto di un processo
casuale ma al contrario rappresentino i punti di riferimento “volontario” a partire dai
15
quali l’autore costruisce le sue argomentazioni ed i suoi sforzi di teorizzazione.
Evidentemente esistono alcune limitazioni nello studio delle citazioni e della
bibliometria in generale. Per esempio, l’analisi delle citazioni non tiene in
considerazione il contesto (citazione positiva o citazione negativa) in cui la citazione
viene fatta e in alcuni casi la citazione può essere ripresa con elevata frequenza
semplicemente perché considerata sbagliata (Usdiken e Pasadeos, 1995; Goudsmith,
1974). Tuttavia, se si scontano le necessarie precauzioni, una citazione costituisce
sempre il segno tangibile del riconoscimento del lavoro scientifico di un altro studioso.
L’analisi bibliometrica più basilare consiste nell’analisi delle semplici frequenze di
citazione. Questo primo tipo di studi fornisce una prima approssimazione di quali
tematiche e quali autori siano più centrali in una disciplina. Simili statistiche possono
poi essere aggregate a livello delle riviste per analizzare, per esempio, quanto queste
mostrano apertura multidisciplinare nei loro schemi di citazione.
Tuttavia, la semplice analisi della frequenza delle citazioni tende a trascurare la struttura
della disciplina sotto esame, concentrandosi sulle fonti o sugli autori in “isolamento”
(Hoffman e Holbrook, 1993, p. 507). La struttura costituisce invece l’oggetto delle
cosiddette analisi di co-citazione.
Concepita originariamente da Rosengren (1968) con il nome di “co-mention analysis”,
l’analisi di co-citazione procede utilizzando matrici citante*citato di dimensione m*n,
utilizzate in diversi modi a seconda delle finalità dello studio. Small (1973) ha generato
il metodo attraverso il quale un legame tra articoli viene costruito sulla base della loro
relazione di co-citazione. Due articoli (o libri) sono co-citati quando vengono citati
congiuntamente in uno o più articoli (o libri) successivamente pubblicati. Gli studiosi di
comunicazione sostengono che lo scopo dell’analisi di co-citazione è quello di studiare
16
“la struttura intellettuale di un ambito disciplinare” (White, 1990, p.84) e che “le mappe
ci autori co-citati danno una visione storica della struttura di una specifica area di
ricerca” (McCain, 1990, p.213).
A partire quindi dalle matrici m*n (citante-citato), è possibile costruire matrici di co-
citazione e a questo proposito, come per tutti gli altri dati di natura relazionale, può
essere utile adottare alcune tecniche di Social Network Analysis (SNA). Nel linguaggio
dell’analisi relazionale (Borgatti, Everett e Freeman, 1992) i lavori citati diventano
“casi” e le fonti citanti diventano “affiliazioni”. Con l’aiuto di software di elaborazione
tipici della SNA è quindi possibile (anche per dataset di dimensioni ragguardevoli)
trasformare una matrice non-quadrata citato-citante in due matrici quadrate citato-citato
(m*m) o citante-citante (n*n). Nel primo caso la matrice di co-citazione include soltanto
i contributi citati ed il legame tra questi coincide con il numero di documenti citanti
(tipicamente il numero di bibliografie) nei quali i due lavori sono entrambi
rappresentati. Nel secondo caso sono i documenti citanti a rappresentare i nodi della rete
di co-citazione ed il legame tra di loro è pari al numero di citazioni che i due autori
condividono, ovvero il numero di fonti comuni presenti nelle due bibliografie.
Da un singolo insieme di dati è quindi possibile impostare diversi tipi di analisi.
Attraverso lo studio delle matrici citati-citati è possibile analizzare l’esistenza e
l’evoluzione di “paradigmi”, dibattiti e cluster di teorie all’interno di una disciplina, così
come questa emerge dai processi di citazione e co-citazione.
L’analisi delle matrici citanti-citanti invece permette di evidenziare il livello di
sovrapposizione esistente nella base intellettuale degli autori o delle riviste e quindi
risulta utile nel delineare gli invisible colleges presenti nel mondo accademico attuale.
17
In questo lavoro ci siamo concentrati sullo studio delle reti di co-citazione del primo
tipo (citati-citati).
4.2. Dati e fonti utilizzati
Lo studio ha utilizzato come fonti i riferimenti bibliografici degli articoli pubblicati
sulle riviste Administrative Science Quarterly (in rappresentanza della disciplina
organizzativa in Nord America) e Organization Studies (in rappresentanza dell’Europa).
I dati sono stati raccolti per i trienni 1993-1995 e 1996-1998. A questi vanno poi
aggiunti i dati già raccolti e pubblicati da Usdiken e Pasadeos (1995) che avevano svolto
la medesima analisi sul triennio 1990-1992 e che sono stati inclusi nella presente analisi
in quanto le modalità di raccolta erano del tutto analoghe e quindi confrontabili.
L’analisi quindi copre complessivamente i nove anni dal 1990 al 1998, suddivisa in tre
successivi trienni.
La raccolta dei dati ha comportato la raccolta e classificazione di tutti i riferimenti
bibliografici apparsi nel periodo considerato sulle due riviste.
Data la finalità di confronto “inter-continentale” della ricerca, abbiamo considerato, in
OS, solo articoli, presentazioni di ricerche, risposte e repliche di autori europei,
considerando europeo un autore sulla base della sede della propria affiliazione
istituzionale. Nel caso di articoli scritti da più di un autore, si è considerata l’affiliazione
del primo autore (first autor). Una procedura di selezione analoga è stata mantenuta
anche per i contributi di ASQ, nel cui caso abbiamo considerato come citanti soltanto
gli autori di affiliazione nord-americana.
18
Tabella 1: Fonti “citanti” considerate
Organization Studies Administrative Science Quarterly1990-1992 42 501993-1995 65 601996-1998 56 63
Ogni fonte “citante” possiede in media circa 60 riferimenti bibliografici.
La base di dati di partenza è quindi costituita da circa 20.000 riferimenti bibliografici in
totale. Se calcoliamo la frequenza di citazioni per rivista e per triennio, tuttavia,
osserviamo come in media la percentuale maggioritaria dei contributi (con percentuali
che oscillano tra l’85% e l’87%) ha ricevuto solamente una citazione.
Questo significa che esiste soltanto una piccola “elite” di contributi citati che ricevono
due o più citazioni sulla singola rivista nel corso di un triennio, mentre il resto della
produzione scientifica risulta relativamente dispersa e poco conosciuta.
Data la vasta mole di dati e la necessità di ottenere una visualizzazione grafica
comprensibile delle reti di co-citazione caratterizzanti il dibattito nelle due riviste nei tre
successivi trienni, sono state incluse nella parte reticolare dello studio esclusivamente le
fonti più citate. E’ infatti evidente che un contributo poco citato in assoluto non potrà
essere molto co-citato.
5. RISULTATI
I risultati dell’analisi si articolano principalmente nella tradizionale analisi delle
frequenze di citazione e nella analisi delle reti di co-citazione.
19
5.1. I contributi più citati
Le tabelle 2 e 3 illustrano le liste dei contributi più citati su Organization Studies e su
Administrative Science Quarterly nei tre trienni considerati.
Tabella 2: I contributi più citati dagli autori americani su ASQ nei tre trienni considerati (il valore n. corrisponde al numero di citazioni ricevute).
Triennio 1990-1992* Triennio 1993-1995 Triennio 1996-1998Autore/i anno n. Autore/i anno n. Autore/i anno n.Thompson 1967 15 Pfeffer and Salancik 1978 19 DiMaggio and Powell 1983 19Pfeffer e Salancik 1978 13 DiMaggio and Powell 1983 15 Cyert and March 1963 13DiMaggio e Powell 1983 10 Pfeffer 1981 14 Meyer and Rowan 1977 13Hannan e Freeman 1977 10 Thompson 1967 13 Pfeffer and Salancik 1978 11Hannan e Freeman 1989 9 Cyert and March 1963 11 Hannan e Freeman 1989 8Aldrich 1979 8 Granovetter 1985 10 March and Simon 1958 8Barnett e Carroll 1987 7 Levitt and March 1988 10 Burt 1992 8Cyert e March 1963 7 Meyer and Rowan 1977 10 Miles and Snow 1984 7Hannan e Freeman 1984 7 DiMaggio and Powell 1991 9 Hambrick 1984 7Lawrence e Lorsch 1967 7 Davis 1991 8 DiMaggio and Powell 1991 7Delacroix, Swaminathan e Solt 1989 6 Eisenhardt 1989 8 Nelson and Winter 1982 7Fama 1980 6 Glaser and Strauss 1967 8 Mizruchi 1992 7Freeman, Carroll e Hannan 1983 6 Jensen and Meckling 1976 8 Glaser e Strauss 1967 6Granovetter 1985 6 March and Simon 1958 8 Scott 1995 6March e Simon 1958 6 Wade et al. 1990 8 Hirschman 1970 6Meyer e Rowan 1977 6 Hannan and Freeman 1977 7 Levitt and March 1988 6Nelson e Winter 1982 6 Stinchcombe 1965 7 Rogers 1962 6Stinchcombe 1965 6 Burt 1983 6 Simon 1947 6Tuma e Hannan 1984 6 Delacroix and Swaminathan 1991 6 Davis 1991 6
Edelman 1990 6 Oliver 1991 6Hannan and Freeman 1989 6 Pfeffer 1981 6Mace 1971 6 Tolbert e Zucker 1983 6Nelson and Winter 1982 6 Hannan e Freeman 1977 6Pfeffer 1972 6 Tushman e Romanelli 1986 6Staw et al. 1981 6 Barnard 1938 6Tolbert and Zucker 1983 6Williamson 1975 6
* Per quanto riguarda il triennio 1990-1992 sono stati utilizzati i dati riportati da Usdiken e Pasadeos (1995).
Un’analisi rapida della lista dei contributi più citati su ASQ mostra come alla vetta della
lista si posizionano due tipi di contributi: da un lato alcuni classici dell’organizzazione
(Thompson, 1967; March e Simon, 1958; Cyert e March, 1963…), dall’altro contributi
più recenti ed in qualche modo più “paradigmatici”, ovvero maggiormente identificabili
20
con un filone di studi o una teoria in particolare (DiMaggio e Powell, 1983 –
neo.istituzionalismo; Hannan e Freeman, 1977/1989 – ecologia delle popolazioni;
Granovetter, 1985 e Burt, 1992 – approccio relazionale). Tuttavia, le prospettive
rappresentate nella top-list non sono poi molte a conferma di una sostanziale maggiore
omogeneità interna delle basi intellettuali della rivista.
Tabella 3: I contributi più citati dagli autori europei su OS nei tre trienni considerati (il valore n. corrisponde al numero di citazioni ricevute).
Triennio 1990-1992* Triennio 1993-1995 Triennio 1996-1998Autore/i Anno n. Autore/i anno n. Autore/i anno n.Morgan 1986 10 Morgan 1986 15 Williamson 1975 8Weber 1968 10 Clegg 1990 14 Burns and Stalker 1961 7Peters e Waterman 1982 9 Cooper and Burrell 1988 10 Child 1972 7Smircich 1983 8 Meyer and Rowan 1977 10 Hofstede 1980 7Burrell e Morgan 1979 7 Peters and Waterman 1982 10 March and Simon 1958 7Burns e Stalker 1961 6 Burrell and Morgan 1979 9 Pfeffer and Salancik 1978 7Chandler 1962 6 Pfeffer and Salancik 1978 8 Weick 1969 7Clegg 1989 6 Schein 1985 8 Burrell and Morgan 1979 6Cyert e March 1963 6 Weick 1969 8 Chandler 1962 6Hofstede 1980 6 Cyert and March 1963 7 Peters 1982 6Kanter 1977 6 Geertz 1973 7 Porter 1980 6Silverman 1970 6 Granovetter 1985 7 Thompson 1967 6Berger e Luckmann 1966 5 Argyris and Schon 1978 6 Barnard 1968 5Chandler 1977 5 Braverman 1974 6 Foucault 1979 5Child 1972 5 Cooper 1989 6 Giddens 1984 5Clegg e Dunkerley 1980 5 Gergen 1992 6 Kuhn 1962 5March e Simon 1958 5 Giddens 1979 6 Porter 1990 5Pettigrew 1979 5 Parker 1992 6 Scott 1995 5Pfeffer e Salancik 1978 5 Burawoy 1979 5 Williamson 1985 5Porter 1980 5 Burrell 1988 5 Woodward 1965 5Weick 1969 5 Foucault 1980 5Williamson 1975 5 Giddens 1991 5Williamson 1985 5 Harvey 1989 5
Knights and Morgan 1991 5Lash 1990 5Lyotard 1984 5March and Olsen 1976 5March and Simon 1958 5Pettigrew 1985 5Pfeffer 1981 5Thompson and McHugh 1990 5Williamson 1975 5Williamson 1985 5
* Per quanto riguarda il triennio 1990-1992 sono stati utilizzati i dati riportati da Usdiken e Pasadeos (1995).
21
La seconda informazione che emerge con chiarezza è la quasi completa assenza di
contributi non americani.
Infine, si può notare come l’età media dei contributi più citati sia abbastanza stabile
(1978 nel 90-92; 1979 nel 93-95; 1978 nel 95-98), gli americani tendono in maniera più
stabile a citare contributi comparsi tra i 15 ed 20 anni prima della pubblicazione
dell’articolo. E’ piuttosto curioso che la media non subisca spostamenti nel passaggio
dal primo al secondo triennio, come che al passare del tempo i punti di riferimento
restino sostanzialmente invariati.
Per quanto riguarda la situazione dei contributi più citati dagli autori europei su OS la
situazione appare piuttosto diversa rispetto al caso americano.
Sicuramente la differenziazione interna alla lista è in questo caso piuttosto elevata.
Troviamo nella stessa contributi di stampo prescrittivo-manageriale (Porter, Peters,
Peters e Waterman), contributi teorici “paradigmatici” (Wiliamson), contributi di tipo
epistemologico (Burrell e Morgan). In generale comunque le prospettive non-positiviste
sembrano trovare, contrariamente al caso statunitense, ampio spazio all’interno del
dibattito europeo (Giddens; Morgan; Clegg; Weick; Hofstede).
La seconda differenza rilevante rispetto alla lista di ASQ riguarda la presenza
equilibrata di contributi provenienti da entrambe le sponde dell’oceano.
Infine, riguardo all’età media delle citazioni più frequenti in due trienni su tre gli autori
di OS mostrano una più marcata “memoria” a lungo termine (1975 nel 90-92; 1982 nel
93-95; 1975 nel 96-98) e soltanto nel triennio centrale (dominato dal dibattito recente
sul “post-modernismo”) la data media dei contributi più citati è più recente che non nel
caso americano.
22
5.2. Reti di co-citazioni
Le reti di co-citazione sono state elaborate utilizzando i software di analisi relazionale
Ucinet V (Borgatti, Everett e Freeman, 1999) per quanto concerne la fase di trattazione
dei dati in forma di matrice e del software Krackplot 3.0 (Krackhardt D., Blythe J. e
Mc.Grath C., 1995) per quanto riguarda l’elaborazione grafica delle reti.
Per ottenere una visualizzazione grafica comprensibile cono stati considerati soltanto
quei nodi della rete (le citazioni) che mostravano i più elevati valori di citazione e co-
citazione. Il valore minimo di co-citazioni considerato è indicato in ogni figura con il
termine di cut-off. Ad esempio, un valore di cut-off pari a 3 significa che nella figura è
rappresentato un legame quando le fonti sono state citate assieme almeno 4 volte
(esistono almeno 4 bibliografie nelle quali i due autori sono entrambi presenti). Di
seguito sono riportate le sette figure rappresentanti le reti di co-citazione sulle due
riviste nei tre trienni oggetto dell’analisi. Queste rappresentazioni grafiche (riportate in
appendice) costituiscono la base della discussione finale e delle conclusioni1 2.
(v. Figura 1: La rete di co-citazione di ASQ nel periodo 1990-1992 in all.)
(v. Figura 2: La rete di co-citazione di ASQ nel periodo 1993-1995 in all.)
(v. Figura 3: La rete di co-citazione di ASQ nel periodo 1996-1998 in all.)
(v- Figura 4: La rete di co-citazione di ASQ nel periodo 1996-1998 in all)
(Figura 5: La rete di co-citazione di OS nel periodo 1990-1992 in all.)1 nota 1: per motivi di rappresentazione grafica, i nodi delle reti, ovvero le fonti citate, vengono indicate esclusivamente con il nome del primo autore dei contributi. Ad es. Pfeffer, 1978 sta a significare Pfeffer e Salancik, 1978, ecc. 2 nota 2: per motivi di brevità non abbiamo allegato al presente lavoro la lista con la descrizione completa delle fonti incluse nella presente analisi di citazioni e co-citazioni. Essa può essere richiesta dagli interessati direttamente agli autori.
23
(v. Figura 6: La rete di co-citazione di OS nel periodo 1993-1995 in all.)
(v. Figura 7: La rete di co-citazione di OS nel periodo 1996-1998 in all.)
6 – DISCUSSIONE: CO-CITAZIONI, EVOLUZIONE DEI PARADIGMI E META-AUTORI
Le prime quattro figure (fig. 1-4) mostrano l’evoluzione della rete di co-citazione
“prodotta” dagli autori americani su ASQ nel periodo 1990-1998. La prima figura
mostra una base intellettuale fortemente dominata da una prospettiva teorica particolare,
l’Ecologia delle Popolazioni. Esternamente al “core” teorico principale restano
fortemente presenti alcuni classici dell’organizzazione (Cyert e March, 1963, e
soprattutto Thompson, 1967) ed una teoria emergente, ovvero il neo-istituzionalismo
(Meyer e Rowan, 1977; DiMaggio e Powell, 1983), ancora fortemente marginale. La
figura 2 (1993-1995) mostra invece una situazione diversa e decisamente più articolata.
E’ possibile infatti evidenziare tre “paradigmi” teorici principali (Ecologia delle
Popolazioni; Neo-istituzionalismo; teoria dell’Agenzia) nettamente distinti nei pattern di
citazione degli autori e tuttavia non completamente isolati tra di loro. Esistono infatti
alcuni contributi teorici che mostrano caratteristiche meno paradigmatiche e che in
qualche modo sembrano tenere unita la struttura intellettuale della disciplina (Pfeffer e
Salancik, 1978; Pfeffer, 1981; Cyert e March, 1963). Il terzo triennio su ASQ è invece
caratterizzato da una situazione ancora più articolata, come se la base intellettuale di
riferimento fosse in fase di allargamento. Indubbiamente, la teoria emergente nel primo
triennio (Neo-istituzionalismo) sembra aver raggiunto la sua fase di massima
affermazione diventando in qualche modo il paradigma di riferimento degli autori che
pubblicano su ASQ. A questa teoria dominante però si affiancano una serie di contributi
24
più differenziati che in passato. In particolare è possibile notare: la marginalizzazione
della prospettiva “ecologista”; la mancata accomunazione di questa ultima con la
prospettiva evoluzionista (Nelson e Winter, 1982; Amburgey, 1993); l’affermarsi di un
dibattito vivace intorno al comportamento dei consigli di amministrazione, dei CEO e
dei “top-management” team in genere (Hambrick, 1994; Westpahl e Zajak, 1994, …);
lo studio crescente delle relazioni inter-organizzative (Galaskiewicz, 1989; Haunschild,
1993; …); ed infine un piccolo nucleo isolato rappresentante un approccio diverso da un
punto di vista metodologico, ovvero la prospettiva configurazionista allo studio delle
organizzazioni (Miles e Snow, 1984; Glaser e Strauss, 1967). La figura quattro, invece,
serve esclusivamente a mettere ulteriormente in luce il ruolo dominante, ma anche
integrante, svolto dall’approccio neo-istituzionalista su ASQ nel triennio 96-98.
Abbiamo infatti eliminato i due nodi più centrali (DiMaggio e Powell, 1983; Meyer e
Rowan, 1977) e con essi tutte le citazioni che erano legate esclusivamente a questi due
contributi. L’eliminazione dei due nodi centrali fa ulteriore chiareza rispetto a quanto
dicevamo precedentemente, mettendo in luce come isolati i cluster restanti.
Le ultime tre figure descrivono invece l’evoluzione della base intellettuale degli autori
europei su Organization Studies.
La figura 5 mette in luce un panorama più differenziato rispetto al correspettivo
americano nel triennio 1990-1992. Esiste un nucleo centrale, ma anche relativamente
“esclusivo” di riferimenti tipicamente europei ed anglosassoni in particolare (Clegg,
1980; Burrell e Morgan; 1979; Braverman, 1974) che sembrano caratterizzare il
dibattito per l’attenzione a teorie non positiviste ed alla questione epistemologica. Allo
stesso tempo però, nella base intellettuale europea trovano spazio contributi anche più
mainstream, che sono tenuti insieme ai precedenti da una serie di nodi teorici centrali ad
25
elevata flessibilità – o almeno tale ci sembra sia percepita dagli autori – tra questi in
particolare il suggestivo libro di Morgan (1986), l’opera di Weick (1969) ed il classico
Weber (nella traduzione inglese). La figura 6 mostra invece una tendenza centripeta da
parte degli autori di OS, che nel triennio considerato, concentrano molto le loro
attenzioni intorno al dibattito (nascente già nel precedente triennio) intorno al post-
modernismo ed alla questione epistemologica. Ancora una volta tuttavia sono i
contributi meno “teorici” (Peter e Waterman, 1982; Morgan, 1986) e più divulgativi a
fare da ponte tra questo cerchio di discussione un po’ esoterico ed il resto della
disciplina organizzativa. La figura 7 infine illustra la fine della dominanza post-
modernista (ancora presente – Foucault, Clegg, Cooper - ma più “isolata”) e
conseguentemente riapre gli spazi per una serie molto variegata di prospettive, teorie e
metodologie: si veda ad esempio la prospettiva culturale (Hofstede) o il problema
dell’impatto delle politiche di organizzazione del lavoro sulla performance aziendale,
(Huselid, MacDuffie, …). Si è cercato di evidenziare nella figura le principali aree di
interesse emerse. E’ importante notare come molti di questi cluster di citazioni appaiano
tra loro completamente isolati a testimonianza da un lato della maggiore varietà presente
nel contesto europeo, ma anche della relativa impermeabilità e “incommensurabilità” di
alcuni paradigmi o dibattiti. Il nucleo più grande di contributi è invece abbastanza
connesso e ruota intorno a lavori classici dell’organizzazione, prevalentemente di
origine americana (Weick, Thompson, Williamson).
7. CONCLUSIONI: LA MOLTEPLICITÀ DELLE TEORIE ORGANIZZATIVE, TRA
PARADIGMI E CONTINENTI.
A conclusione di questa analisi della struttura intellettuale della disciplina organizzativa,
26
emergente dallo studio dei pattern di citazione, possiamo trarre alcune conclusioni più
generali.
L’auspicato desiderio di alcuni (Donaldson, 1988) di veder trionfare una visione della
disciplina organizzativa che evolve attraverso le rivoluzioni scientifiche che Kuhn
(1970) prospetta per le scienze naturali, sembra lontano dall’avverarsi. Questo succede
non soltanto perché, come ricorda Aldrich (1992), si è ancora lontani dal praticare (e
pubblicare!) i tipi di studi che una “scienza normale” richiederebbe – replicazione di
studi empirici già sperimentati, pubblicazione di risultati “negativi” o confutatori.
La disciplina infatti evolve nel corso degli anni seguendo traiettorie che è difficile
anticipare, che sembrano fortemente influenzate da processi di costruzione sociale,
percorrendo binari convergenti ma anche paralleli e mantenendo un elevato grado di
differenziazione interna. Come potremmo interpretare ad esempio i diversi ruoli
attribuiti agli stessi lavori nel corso degli anni, se non ricordando che il significato di
quei lavori è determinato fortemente da come essi vengono percepiti, usati e collocati
dagli studiosi di organizzazione in un determinato periodo storico? Come ricordava
Small (1978): “(Una citazione) costituisce l’interpretazione che l’autore offre del lavoro
citato. Nel citare un autore sta costruendo il significato della citazione stessa..” (trad.
nostra, p. 328). Così può succedere che lo stesso “classico” si trovi associato nel corso
del tempo a prospettive relativamente diverse e talvolta anche lontane dalle intenzioni
originarie dell’autore.
In maniera più specifica poi emergono risposte possibili ad alcuni dei quesiti posti alla
fine del paragrafo terzo.
27
Convergenza o divergenza?
Non sembra esistere un trend univoco di convergenza o divergenza della disciplina
organizzativa. Piuttosto sembra che questa sia caratterizzata da fasi di convergenza e da
fasi di divergenza, che si alternano in una evoluzione costante. La convergenza inoltre è
un fenomeno più articolato di come spesso sia stato descritto. Vi può essere
convergenza intorno a dibattiti specifici (es. post-modernismo e post-fordismo), intorno
a fenomeni particolarmente “alla moda” (es. il comportamento dei top-management
team), intorno a prospettive teoriche paradigmatiche ed “escludenti” (es. l’ecologia delle
popolazioni), oppure convergenza intorno a prospettive teoriche che, pur specifiche e
dominanti, sembrano avere una maggiore capacità aggregante (es. neo-istituzionalismo).
Un sistema di ruoli all’interno della struttura intellettuale della disciplina?
La sola nota di stabilità all’interno della base intellettuale della disciplina sembra in
realtà essere l’esistenza di un sistema di ruoli, ricoperti da diversi tipi di citazioni
ricorrenti.
Esistono anzitutto alcuni contributi “classici” che rappresentano il collante intellettuale
e la vera base comune degli studi organizzativi. Questi contributi sono rappresentati
all’interno delle reti di co-citazione da quei nodi ad elevata centralità ma anche a bassa
esclusività relazionale. Si tratta di contributi molto citati ma utilizzati in maniera diffusa
da autori che si rifanno a prospettive anche molto diverse tra di loro. Estremizzando
potremo dire che questi lavori rappresentano le radici comuni, le basi dell’identità di
una disciplina che alternativamente appare piuttosto dispersa e frammentata. Si tratta
spesso delle citazioni più datate ma anche di quelle che tutti gli studiosi di
28
organizzazione sembrano in qualche modo tenere a mente quando svolgono la loro
opera di concettualizzazione. Le basi intellettuali comuni della disciplina sono costituite
quindi da meta-teorie, ovvero da approcci teorici che sembrano in grado di integrare o
di superare i particolarismi degli specifici paradigmi. Essi sembrano costituire, nella
pratica, la sola risposta concreta alla cosiddetta incommensurabilità dei paradigmi
(Burrell e Morgan, 1979; Burrell, 1996). Diversi sono i contributi che hanno queste
caratteristiche, è possibile ricordare in particolare l’opera di Simon, March, Cyert,
Weick, Thomspon, Pfeffer, Williamson e Morgan. In questo breve elenco alcune
caratteristiche appaiono immediatamente evidenti: si tratta infatti di opere di origine
anglosassone e più in particolare nordamericane.
Affianco a questo primo tipo di ruolo esistono poi citazioni con ruoli più specifici e
meno pervasivi. Alcuni contributi infatti sembrano essere più fortemente paradigmatici
– si pensi ad esempio all’approccio dell’ecologia delle popolazioni. Questi lavori
diventano punti di riferimento per la disciplina ma sembrano in qualche modo collocati
dentro a cluster molto esclusivi e per quanto molto citati, tendono ad essere co-citati
insieme a contributi che condividono con i primi una forte identità comune, in termini di
domande di ricerca, livello di analisi, metodologia, spiegazioni utilizzate, fenomeni
analizzati. Questo secondo tipo di contributi attraversa la disciplina in maniera talvolta
violenta ma presentando un ciclo di vita apparentemente più rapido rispetto agli
approcci meta-teorici.
Infine, esistono cluster di citazioni che sono fortemente legati alle mode (non si intenda
questo termine con connotazione necessariamente negativa) del momento. Si tratta di
contributi che trovano la loro comunanza non tanto in comuni basi teoriche, in
prospettive e spiegazioni simili, ma piuttosto nel fatto che affrontano tutte lo stesso tipo
29
di fenomeno, particolarmente rilevante in quel determinato periodo di tempo. Il già
citato dibattito sui top-management team ma anche in qualche modo quello più europeo
sulla questione del post-modernismo, sembrano appartenere a questa terza categoria. I
cluster basati su fenomeni comuni sembrano essere tra l’altro anche quelli con ciclo di
vita più rapido: guadagnano rapidamente visibilità ma altrettanto rapidamente escono
dalla base intellettuale della disciplina.
Europa e Stati Uniti
Infine, per quanto riguarda il confronto tra Europa e Stati Uniti, le due sponde
dell’oceano, almeno per quanto emerge dalle due riviste considerate nello studio,
sembrano mantenere alcune differenze rilevanti e non mostrano una chiara tendenza
verso la convergenza.
Il contesto europeo è caratterizzato da una maggiore varietà degli approcci, dei
fenomeni studiati, delle metodologie, della provenienza degli studiosi. Tuttavia esso è
anche più nebuloso, frammentario, talvolta apparentemente contraddittorio. Questa
dispersione sicuramente è sintomo di una grande ricchezza culturale ma allo stesso
tempo, poiché la diffusione delle idee passa anche attraverso la legittimazione delle
stesse (Baldi, 1998; Latour, 1987), essa rischia di minare le possibilità che una
prospettiva originale europea raggiunga la massa critica necessaria a farne patrimonio
intellettuale di molti, magari anche sull’altra sponda dell’oceano.
D’altro lato la prospettiva americana sembra caratterizzata da una maggiore uniformità
e dalla presenza di un minor numero di prospettive altamente condivise da una buona
parte degli autori. Il minor numero di prospettive tuttavia non limita le contrapposizioni
30
tra teorie che spesso emergono come cluster non comunicanti.
Per quanto riguarda il confronto ed il livello di “comunanza” tra le due tradizioni
continentali occorre rimarcare ancora una volta l’apparente asimmetria esistente tra
Europa e Stati Uniti. Sembra empiricamente fondata l’osservazione di Koza e Thoenig
(1995) che recentemente ricordavano come “mentre la tradizione Europea, anche
quando si oppone alla controparte Americana, ne riconosce sempre l’esistenza, sarebbe
difficile trovare una qualche traccia di una visione non-americana in un libro di testo
Statunitense” (p. 1). Le uniche basi intellettuali comuni esistenti tra i due continenti
sono rappresentate da alcuni autori americani classici (Simon, Weick, …), che non
soltanto fungono da ponte tra i paradigmi ma svolgono una funzione simile anche tra le
tradizioni continentali. Tuttavia, il fatto che forse più dovrebbe far riflettere gli autori
della tradizione europea è che queste meta-teorie di origine americana spesso
costituiscono anche i ponti tra paradigmi diversi all’interno della nostra tradizione
continentale, come se le uniche basi comuni alla disciplina organizzativa tra i diversi
paesi membri dell’Europa fossero appunto contributi statunitensi.
Le spiegazioni possibili di queste differenze tra continenti possono essere molte. La
spiegazione di tipo neo-istituzionalista ci sembra comunque la più plausibile.
Gli studi organizzativi nordamericani contemporanei sono infatti certamente influenzati
dalle modalità di formazione dei giovani ricercatori e dei dottorandi di ricerca, dalla
struttura degli incentivi (fortemente centrata sul problema delle pubblicazioni in riviste
selezionate), dal processo di pubblicazione sulle medesime riviste, il tutto
accompagnato da una tendenza alla risoluzione di problemi pratici tipica delle Business
Schools. D’altro alto nel panorama europeo, alle spinte istituzionali si è probabilmente
affiancata negli anni la volontà di reagire al crescente dominio dei paradigmi americani.
31
Una minore pressione istituzionale al conformismo e la volontà di affermare scuole di
pensiero autonome hanno con buona probabilità sostenuto la proliferazione di visioni
anche radicalmente differenti nel contesto europeo.
Dominanza su base linguistica?
Infine, un’ultima osservazione è necessaria per quanto riguarda il fattore linguistico.
Appare evidente, tanto dall’analisi delle frequenze di citazione quanto dall’analisi delle
reti di co-citazione, come tutti i contributi emergenti siano opera di autori di lingua
madre inglese o comunque siano stati concepiti originariamente in quella lingua. Forse,
piuttosto che preoccuparsi della dominanza Statunitense sulla disciplina, occorrerebbe
riformulare il problema in termini linguistici e parlare di dominanza degli autori di
“lingua inglese”. Questa notazione è abbastanza vera anche per quanto riguarda il
contesto europeo e testimonia una barriera all’entrata di tipo linguistico che ancora non
è stata superata. L’ipotesi di una dominanza su base linguistica, piuttosto che su base
geografica, pare inoltre rafforzata dal fatto che le differenze tra i citati su ASQ ed i più
citati su OS è prevalentemente di tipo contenutistico, il che lascerebbe presagire una
possibile maggiore vicinanza di citazioni nel momento in cui le due riviste
convergessero verso metodologie ed approcci comuni. La barriera linguistica è infine
confermata dalla frequenza di citazioni americane (Weick, Schein) su OS anche per
quanto riguarda gli approcci qualitativi e fenomenologici, su cui pure esistono
importanti contributi di matrice originariamente europea.
BIBLIOGRAFIA
32
ALDRICH H., 1988, “Paradigm warriors: Donaldson versus the critics of organization theory”, Organization Studies, 9/1:19-25.
ALDRICH H., 1992, “Incommensurable paradigms? Vital signs from three perspectives”, pp. 17-45 in Michael I. Reed and Michael D. Hughes (a cura di) , Rethinking Organization: New Directions in Organizational Theory and Analysis, Newbury Park, CA: Sage
ASTLEY W.G., 1985, “Administrative science as socially constructed truth”, Administrative Science Quarterly, 30: 497-513.
ASTLEY W.G. e VAN DE VEN A. H., 1983, “Central perspectives and debates in organition theory”, Administrative Science Quarterly, 28: 245-273.
BALDI S., 1998, “Normative versus social constructivist processes in the allocation of citations: a network-analytic model”, American Sociological Review, vol. 63, 829-846.
BACHARACH S., GAGLIARDI P. e MUNDELL B. (a cura di), 1995, Studies of Organizations in the European Tradition. JAI Press, 1995.
BORGATTI S., EVERETT M.G. e FREEMAN L.C., 1999, Ucinet V for Windows: software for Social Network Analysis, Natick: Analytic Technologies.
BOULDER K. E., 1956, “General systems theory: the skeleton of science”, Management Science, 2: 197-208.
BOYACIGILLER N.A. e ADLER N.J., 1991, “The parochial dinosaur: organization science in a global context”, Academy of Management Review, vol. 16, n. 2, 262-290.
BURRELL G. 1996, “Normal science, paradigms, metaphors, discourses and genealogies of analysis”, in Clegg S., Hardy C. e Nord W.R. (eds.), 1996, Handbook of Organization Studies, pp. 642-658, Thousand Oaks (CA): Sage.
BURRELL G. e MORGAN G., 1979, Sociological paradigms and organizational analysis, London: Heineman.
CLEGG S., HARDY C. e NORD W.R. (eds.), 1996, Handbook of Organization Studies, Thousand Oaks (CA): Sage.
Crane D., 1972, Invisible colleges: diffusion of knowledge in scientific communities, Chicago: University of Chicago Press.
DANELL R., ENGWALL L. e PERSSON O., 1996, “The shoulders of giants beneath ASQ authors: the intellectual base of Administrative Science Quarterly 1981-1992”, Unpublished working paper, Draft, March the 24th.
DANELL R., ENGWALL L. e PERSSON O., 1997, “The first mover and the challenger: the relationship between two journals in organization research”, Scientometrics, 40: (3), 445-453.
DONALDSON L., 1988, “In successful defence of organization theory: a routing of the critics”, Organization Studies, 9/1: 28-32.
GIOIA D. A. e PITRE E., 1990, “Multiparadigmatic perspectives on theory building”, Academy of Management Review, 15: 584-602.
GOUDSMIT S.A., 1974, “Citation analysis”, Science, 183: 28.
33
HININGS B., 1988, “Defending organization theory: British view from North America”, in Organization Studies, 9/1, pp: 2-7.
HOFFMAN D.L. e HOLBROOK M.B., 1993, “The intellectual structure of research: a bibliometric study of author cocitations in the first 15 years of the Journal of Consumer Research”, Journal of Consumer Research, vol. 19, march, 505-517.
HOFSTEDE G., 1996, “An American in Paris: the influence of nationality on organization theories”, Organization Studies, 17/3, 525-537.
HOFSTEDE G., 1970, “Reflections on My Critics”, in Criticism and the Growth of Knowledge, ed. Lakatos I. and Musgrave A., Cambridge: Cambridge University Press, 231-278.
JACKSON N. e CARTER P., 1991, “In defence of paradigm incommensurability”, Organization Studies, 12: 109-127.
JEPPERSON R.L., 1991, “Institutions, institutional effects, and institutionalism”, in Powell W.W. e DiMaggio P.J. (a cura di), The new institutionalism in organizational analysis, 143-163, Chicago: University of Chicago Press.
KOZA M.P. e THOENIG J-C., 1995, “Organization theory at the croassroads: some reflections on European and United States approaches to organization research”, Organization Science, vol. 6, n. 1, 1-8.
KRACKHARDT D., BLYTHE J. e MC.GRATH C., 1995, KRACKPLOT 3.0, Columbia, USA, Analytic Technologies.
KUHN T.S., 1970, “Reflections on My Critics”, in Lakatos I. and Musgrave A. (eds.) Criticism and the Growth of Knowledge, 231-278, Cambridge: Cambridge University Press.
LAMMERS C., 1990, “Sociology of organizations around the globe: similarities and differences between American, British, French, German and Dutch brands”, Organization Studies, 11/2: 179-205.
LAMMERS C., 1998, “Book review: Research in the sociology of organization: studies of organizations in the European tradition”, Administrative Science Quarterly, March 1998.
LATOUR B., 1987, Science in action: how to follow scientists and engineers through society, Cambridge (MA): Harvard University Press.
LIEVROUW L.A., 1990, “Reconciling structure and process in the study of scholarly communication”, in Scholarly Communication and Bibliometrics, ed. Borgamn C.l., Newbury Park, CA: 59-72.
MCCAIN K.W., 1990, “Mapping authors in intellectual space: population genetics in the 1980s”, in BORGMAN C. (a cura di), Scholarly Communication and Bibliometrics, Newbury Park (CA): Sage.
PFEFFER J., 1993, “Barriers to the advance of organizational science: paradigm development as a dependent variable”, Academy of Management Review, 18: 599-620.
PFEFFER J., 1995, “Mortality, reproducibility and the persistence of styles of theory”, Organization Science, 6, 680-686.
34
PRICE J. e D. DE SOLLA, 1986, Little science, Big science … and Beyond, New York: Columbia University Press.(1963)
PRITCHARD A., 1969, “Statistical bibliography or bibliometrics?”, Journal of Documentation, 25, 348-349.
ROMANO C. e RATNANUGA J., 1996, “A citation analysis of the impact of journals on contemporary small enterprise research”, Entrepreneurship Theory and Practice, spring 1996, Baylor Univeristy: 7-21.
ROSENGREN K.E., 1968, Sociological aspects of the literary system, Stockholm: Natur och Kultur.
SMALL H. G., 1973, “Co-citation in the scientific literature: a new measure of the relationship between publications”, Journal of the American Society for Information Science, 24: 265-269.
SMALL H. G., 1978, “Cited documents as concept symbols”, Social Studies of Science, 8: 327-340.
USDIKEN B. e PASADEOS Y., 1995, “Organizational analysis in North America and Europe: a comparison of co-citation networks”, Organization Studies, 16/3, 503-526.
USDIKEN B. e PASADEOS Y., 1999, “Organization theory ‘Made in USA’: what has been changing lately in the produce of the world’s largest manufacturer”, paper presented at sub-theme 1, 15th EGOS Colloquium, 4-6 July, Coventry, UK.
VAN MAANEN J., 1995a, “Style as theory”, Organization Science, 6, 132-143.
VAN MAANEN J., 1995b, “Fear and loathing in organization studies”, Organization Science, 6, 687-692.
VON BERTALANFFY L., 1968, General systems theory: foundations, development, application. New York: George Braziller.
WHITE H.D., 1990, “Author Co-citation Analysis: Overview and Defense”, in Scholarly Communication and Bibliometrics, ed. Borgman C.L., Newbury Park, CA: Sage, 84-106.
WHITE H.D. e MCCAIN K.W., 1989, “Bibliometrics”, in M.E. Williams (Ed.), Annual review of information science and technology, (ARIST), 24, 119-186.
WILMOTT H., 1993, “Breaking the paradigm mentality”, Organization Studies, 14/5: 681-719.
ZAMMUTO R.F., 1998, “Book review: Handbook of organization studies”, Administrative Science Quarterly, September 1998.
35