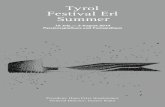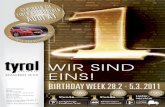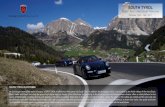The Structure of the State an Instrument of Peace – The South Tyrol Minority as an Example
-
Upload
oskar-peterlini-phd -
Category
Documents
-
view
219 -
download
2
description
Transcript of The Structure of the State an Instrument of Peace – The South Tyrol Minority as an Example
Oskar Peterlini
The Structure of the State – an Instrument of Peace? L’assetto dello Stato –
Prokopp & Hechensteiner
The South Tyrol Minority as an Example
uno strumento di pace?
L’esempio della minoranza sudtirolese
Prokopp & Hechensteiner
Oskar Peterlini
The South Tyrol Minority as an Example
The Structure of the State – an Instrument of Peace?L’assetto dello Stato – uno strumento di pace?
L’esempio della minoranza sudtirolese
© 2012Oskar Peterlini
eProkopp & Hechensteiner s.a.s.
S. Paolo presso Bolzanowww.prokopp-hechensteiner.com
Composto in carattereStrada di Albert Pinggera eMarat di Ludwig ÜbeleISBN: 978-88-6069-012-8Printed in Italy
Tutti i diritti riservati
Convegno della Central European Initiative (InCE/CEI) a Bolzano. Discorso introduttivo di Oskar Peterlini, coordinatore del Convegno:
AutoNomIa, tutela delle mINoraNze e del patrImoNIo culturale come StrumeNto dI pace tra I popolI
Bolzano, 26 – 28 aprile 2012
Central European Initiative (CEI) Congress in Bolzano/BozenIntroductory speech by Oskar Peterlini, Chairperson of the Conference:
AutoNomy, ProtectIoN of NatIoNal MINorItIeS aNd Cultural HerItage aS ToolS for Peace
Bolzano-Bozen, 26 – 28 April 2012
1 La guerra – una lezione mai imparata 92 Il dono dei Padri dell’Europa – 66 anni di pace 103 Le cause d’insorgenza dei conflitti internazionali 114 Gli avvertimenti: “Seme perenne di discordia e ribellione” 125 Una speranza dopo la guerra: l’autodeterminazione 136 L’ancoraggio internazionale, garanzia per il futuro 147 I punti salienti del Trattato di Parigi del 1946 148 Diffidenza e sospetto raggelarono i rapporti 159 Dal “Los von Trient” alla notte dei fuochi 1610 L’intimazione dell’ONU: “Riprendete le trattative!” 1811 Le basi politiche e giuridiche: il Pacchetto e lo Statuto 1912 Le Province vere protagoniste dell’autonomia 2013 Le tentazioni della secessione e la strada dell’autonomia 2114 Se l’Italia perdesse il sua carattere democratico 2315 Magnago preferisce “Roma lontana” alla Lega vicina 2316 Francesco Cossiga propone l’autodeterminazione del Sudtirolo 2417 Le reazioni a Bolzano 2518 Le autonomie speciali – eccezioni in un contesto centralistico 2619 La riforma federale – un’autonomia più ampia per tutti 2820 Una visione e un auspicio 2921 Operare per la pace 31
1. Freedom – a lesson learnt with difficulties 352. A gift from the founding fathers of Europe – 67 years of peace 363. Reasons for the outbreak of international conflicts 374. Warning: “Perennial seeds of discord and revolt” 385. Hope after the war: self-determination 396. Internationally enshrined principles, a safeguard for the future 407. The main points of the Treaty of Paris of 1946 408. Diffidence and suspicion chilled relations 419. From the “Los von Trient” slogan to the night of bonfires 4210. The UN order: “Resume negotiations!” 4411. The political and legal foundations: the Package and the Statute 4512. Provinces play a leading role in terms of autonomy 4613. The secession temptation and the road to autonomy 4714. If Italy were to lose its democratic character 4915. Magnago prefers to “keep Rome at a distance”
rather than be near the League 4916. Francesco Cossiga proposes self-determination for South Tyrol 5017. Reactions in Bozen/Bolzano 5118. Special autonomy – exceptions to a centralist context 5319. Federal reform – greater autonomy for all 5420. Vision and hope 5621. Working for peace 58
9
1 La guerra – una lezione mai imparata
Leggendo i libri di storia si deve purtroppo costatare, come l’umanità da mil-
lenni è flagellata da battaglie e guerre che hanno richiesto un altissimo tributo
di sangue e di risorse. Dietro i dati storici, dietro il sipario delle scene ufficiali,
si nascondono milioni di tragedie umane, di famiglie distrutte, di uomini, don-
ne e bambini morti o mutilati nei conflitti bellici.
Ricordiamo, spesso addirittura con malinconia i periodi classici della Me-
sopotamia, dell’antica Grecia, della grande Roma, dimenticando che le tap-
pe storiche più importanti sono state segnate da crudelissime guerre, come la
conquista di Troia, i conflitti tra Sparta e Atene, gli attacchi della Persia, la di-
struzione di Cartago nel 202 a.C. e quella di Corinto nel 146 a.C. Ricordiamo le
Crociate nel nome (in verità nell’offesa) di Dio, le guerre tra i popoli europei,
ma, anche in Italia e in Germania, le guerre tra le famiglie feudali che si tende-
vano il potere.
La guerra dei trent’anni che dilaniò l’Europa tra il 1618 e il 1648, per motivi
apparentemente religiosi, sembrava di entrare nella storia come una delle più
lunghe guerre mai vissute. La pace di Vestfalia del 1648 doveva spegnere que-
sto inferno. Invece no.
Seguì un secolo particolarmente emblematico, tra il 1667 e il 1763. Furono
quasi cent’anni tormentati da un susseguirsi di guerre pressoché continue. La
Francia fu in guerra per 53 anni, l’Inghilterra e l’Olanda per circa 40, la Russia
per 33 anni.1
Sembra proprio che la storia abbia insegnato poco o niente ai responsabili
politici alternatisi nei tempi, che hanno continuato e continuano tuttora a usa-
re le armi per motivi di potere e la risoluzione dei conflitti. Come se non ba-
stassero i terremoti e gli tsunami!
1 Gentile, G./ Ronga, L. (2005): Storia & Geostoria, vol. IV: Dalla metà dei Seicento alla fine dell’Ottocento, La Scuola, Brescia, pp. 64–71, http://www.luzappy.eu/storia_intro/settecento.htm.
10
2 Il dono dei Padri dell’Europa – 66 anni di pace
Mentre i conflitti nel mondo continuano quotidianamente, c’è uno spiraglio
che ci lascia sperare, ed è proprio la stessa Europa. La lezione non poteva più
essere disattesa. Dopo millenni di campi di battaglia, le due guerre mondiali
segnarono, in un unico mezzo secolo, un picco mai visto prima. Furono estinte
vite umane della dimensione di popoli interi, il sangue e le lacrime non poteva-
no non marcare una svolta, almeno per la prossima metà del secolo e almeno
in una parte del continente europeo. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che
nell’est europeo le guerre proseguirono fino agli anni più recenti.
Ma almeno nell’Europa occidentale la lezione è stata compresa, come rara-
mente successe nella storia. Da oltre 66 anni, abbiamo la fortuna di vivere e di
sperimentare un periodo di pace della durata mai concessa prima. Il contributo
alla pace è probabilmente il più grande dono, che i padri fondatori europei han-
no lasciato a noi e speriamo anche alle generazioni future dell’Europa. Grazie
anche al processo di integrazione europea, gli Stati che fino agli anni 70 erano
oppressi da dittature militari, come la Grecia, il Portogallo e la Spagna, potero-
no trasformarsi in democrazie stabili.
Gli stati dell’est, come si diceva, rimasero a lungo fuori da questo processo,
cementati nel blocco forzato dell’Unione Sovietica. Con loro rimasero disatte-
se le speranze di libertà dei popoli, delle nazioni e delle minoranze etniche, in-
catenati in Stati artificiosi, tenuti insieme solamente dalla forza militare. Ap-
pena però la storia, nella seconda metà del secolo, aprì loro una possibilità di
alzarsi, rivoluzionarono tutta l’Europa.
La cortina di ferro, che si era impregnata come una ferita che tagliava a me-
tà il cuore della Germania, crollò all’improvviso sorprendendo anche i polito-
loghi più visionari. E tanti Stati dell’est ritrovarono una propria identità nazio-
nale.
11
3 Le cause d’insorgenza dei conflitti internazionali
Un teorico americano delle relazioni internazionali, Kenneth N. Waltz, cercò
di analizzare in un saggio scritto nel 1959 le cause delle guerre. 2 Ne individuò
tre: Al primo livello pose il carattere e le maniere degli uomini, l’egoismo, l’ag-
gressività, e la stupidità. Il secondo livello sarebbe l’organizzazione interna de-
gli Stati e l’idea che questi richiedano un nemico esterno per unificare le loro
popolazioni. Il terzo livello d’analisi suggerisce che la guerra risulti dal sistema
internazionale, che è anarchico e non ha pertanto un potere regolatore.
Oltre queste cause, possiamo individuarne una, che rimane un seme peren-
ne d’instabilità e di conflitti: la mancata corrispondenza tra il territorio di uno
Stato e quello d’insediamento di una nazione, cioè di un popolo. Se i confini
non corrispondono agli insediamenti, troviamo minoranze etniche all’interno
e all’esterno dello stesso Stato. Una delle maggiori cause d’insorgenza dei con-
flitti internazionali va proprio ricercata, infatti, nella carenza di programmi per
la risoluzione dei conflitti tra le diverse nazionalità e le minoranze etniche. Ciò
è particolarmente evidente nell’Europa orientale e negli eventi più recenti do-
po il crollo dell’Unione Sovietica.
Nel corso della storia raramente vi è stata corrispondenza tra il territorio
nazionale e il territorio in cui risiedeva una popolazione. Molti conflitti, molte
guerre e molti problemi ancora irrisolti dei gruppi etnici sono sorti proprio per
questo motivo. Ragioni religiose e culturali si sono sovrapposte ai motivi etni-
ci, spesso anche nascondendo le vere ragioni.
Individuare pertanto una soluzione ai problemi delle minoranze e delle na-
zionalità costituisce una sfida rivolta a spegnere questi focolai e assicurare la
pace.
2 Waltz, K.N. (2001): Man, the State, and War (L’uomo, lo stato, la guerra), Columbia University Press New York, originally publish 1959.
12
4 Gli avvertimenti: “Seme perenne di discordia e ribellione”
Uno degli esempi più visibili è proprio il Südtirol annesso all’Italia dopo la prima
guerra e poi battezzato Alto Adige.
Recentemente, alle festività per il 150esimo anniversario dell’unità d’Italia,
vari membri del Governo, Ministri della Repubblica, Presidenti delle Regioni e
rappresentanti della Lega espressero la loro criticità (per usare un eufemismo)
alle cerimonie, senza suscitare troppo clamore. il Presidente della Provincia di
Bolzano Luis Durnwalder finì invece a provocare uno scandalo nazionale per la
sua mancata partecipazione alle festività. Non è qui il caso di entrare in questa
polemica, ma serve menzionarla per spiegare le diversità dei sentimenti che
sono il risultato di vicende storiche vissute diversamente.
Il Tirolo, cresciuto in una secolare storia come terra autonoma con propri
dritti e libertà all’interno dell’impero austro-ungarico, venne lacerato e diviso
dopo la prima guerra mondiale. La parte del sud passò all’Italia, non lungo la li-
nea chiaramente riconoscibile del confine linguistico, secondo i principi enun-
ciati dal Presidente americano Thomas Woodrow Wilson.Contro l’annessione si levarono anche in Italia voci autorevoli in nome dei
principi risorgimentali e patriottici. Filippo Turati il 14 luglio 1919 ammoniva la
Camera a respingere “l’annessione di oltre un quarto milione di tedeschi, gelosi della loro stirpe, della loro patria, della loro libertà, seme perenne di discordia e di ribellione”.3
Seguirono le dolorose dittature di Mussolini e Hitler, la soppressione delle
lingua e cultura delle minoranze, la chiusura delle scuole tedesche, il licenzia-
mento degli insegnanti e impiegati tedeschi, l’italianizzazione e l’immigrazio-
ne forzata. Il culmine dello sradicamento fu raggiunto con il trattato siglato a
Berlino da Hitler e Mussolini nel 1939, che portò alle “Opzioni”, nelle quali i
sudtirolesi dovettero votare se rimanere in Italia o espatriare. Fu una decisio-
3 Peterlini, O. (2000): Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige, edizione aggiornata, Cenni di storia e cultura, diritto e politica, Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Bolzano/Trento.
13
ne drammatica che spaccò intere famiglie, infuocata inoltre dalla propaganda
nazista. I sudtirolesi che intendevano rimanere tedeschi sarebbero dovuti emi-
grare nel Reich nazionalsocialista, mentre gli altri potevano restare in Italia ac-
cettando le condizioni poste dal regime fascista.
5 Una speranza dopo la guerra: l’autodeterminazione
Alla fine dell’aprile 1945, i comandanti supremi delle forze armate tedesche in
Italia sottoscrissero un armistizio con gli Alleati, all’insaputa del quartiere ge-
nerale tedesco. Così facendo evitarono che l’intero territorio cadesse sotto le
bombe della forza aerea degli Alleati. Nei primi giorni di maggio gli Alleati en-
trarono in Alto Adige.
L’8 maggio 1945 il commerciante bolzanino Erich Amonn fondò insieme
con un gruppo di sostenitori la Südtiroler Volkspartei (SVP). Il partito fu rico-
nosciuto dagli Alleati perché aveva le sue origini nei movimenti di resistenza
sudtirolese e dei non-optanti. Dopo la guerra, i Sudtirolesi chiesero l’esercizio del diritto di autodetermi-
nazione e cercarono di ottenere la riunificazione con l’Austria, ma la richie-
sta dell’Austria di un referendum popolare in Alto Adige venne respinta dagli
Alleati il 30 aprile 1946. Il ministro degli esteri sovietico Molotow si oppose
per primo alla richiesta austriaca. Egli riteneva importante che in primo luo-
go fossero soddisfatte le richieste iugoslave riguardanti il Friuli-Venezia Giulia.
Anche “le piccole correzioni del confine” originariamente proposte, il ritorno della
Val Pusteria insieme alla conca di Bressanone e alla Bassa Val di Vizze, furono
respinte il 24 giugno 1946 dai quattro ministri degli esteri di Gran Bretagna,
Francia, Unione Sovietica e Stati Uniti. Ma anche la Südtiroler Volkspartei (SVP)
respinse una simile soluzione parziale, poiché temeva per il rimanente territo-
rio del Sudtirolo un indebolimento e una possibile italianizzazione.4
4 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser Vetrag, Direttivo del partito della SVP, Bolzano.
14
6 L’ancoraggio internazionale, garanzia per il futuro
Dopo lunghe trattative e a seguito delle pressioni esercitate anche da molti pa-
esi, nonché dell’opera di mediazione del ministro degli Esteri britannico Ernst
Bevin, il 5 settembre 1946 si giunse alla sottoscrizione del cosiddetto Accordo
di Parigi tra Italia e Austria, che vide protagonisti Karl Gruber ed Alcide De Ga-
speri. Il 3 dicembre 1946 la Conferenza dei ministri degli esteri tenutasi a New
York prese la decisione di inserire l’Accordo di Parigi all’interno dell’articolo 10
del Trattato di pace sottoscritto dall’Italia il 10 febbraio 1947 a Parigi.
L’importanza di quest’atto va rinvenuta nell’internazionalizzazione della
questione sudtirolese e nella contestuale funzione di partner contrattuale del
Trattato di Parigi che Vienna assunse con tale accordo. L’ambasciatore Mario
Toscano svelò in seguito le ragioni che avevano invece indotto De Gasperi a
sottoscriverlo: un trattato stipulato direttamente con l’Austria avrebbe signi-
ficato riconoscere implicitamente la frontiera del Brennero. Infatti, questa so-
luzione diplomatica non avrebbe più permesso al Governo austriaco di parlare
dell’esistenza di un “diktat”, riconoscendo a quest’ultimo di aver implicitamen-
te e liberamente stipulato un accordo. Per l’Alto Adige Südtirol l’accordo avreb-
be invece significato l’ancoraggio internazionale della sua autonomia.
7 I punti salienti del Trattato di Parigi del 1946
Il Trattato di Parigi nel suo primo articolo prevede la parificazione degli “abi-tanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento” alle popolazioni di lingua italiana. In particolare, l’articolo 1
garantisce ai cittadini di lingua tedesca l’insegnamento nella loro madrelingua,
l’equiparazione della lingua tedesca e di quella italiana nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, nei documenti e inoltre anche la nomenclatura topografica bilin-
gue.
15
L’articolo 2, attribuendo “alle popolazioni delle zone sopraddette (...) l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse”, riconosce
un’autonomia vera e propria.
Nell’articolo 3 l’Italia si obbligava a rivedere in uno spirito di comprensione
il regime delle Opzioni di cittadinanza per coloro che in precedenza avevano
optato per la Germania e a stipulare accordi con l’Austria per il mutuo ricono-
scimento dei titoli di studio e la libera circolazione di merci e di persone.
Iniziò poi un sofferto cammino verso l’autonomia, all’inizio negata e falsifi-
cata, un cammino segnato anche da tensioni violente, da due risoluzioni delle
Nazioni Unite, che solo nel 1992 trovò un suo completamento.
8 Diffidenza e sospetto raggelarono i rapporti
Con legge costituzionale n. 5 del 19 febbraio 1948 l’Italia emanò il primo Sta-
tuto di Autonomia, che deluse le attese dei sudtirolesi. L’autonomia ivi previ-
sta era molto circoscritta e non corrispondeva al testo dell’accordo di Parigi. Il
suo campo di applicazione non fu limitato agli “abitanti di lingua tedesca della
Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Tren-
to” (come appunto recitava il testo dell’accordo), ma fu invece esteso a tutta
la Provincia di Trento. Nella Regione “Trentino Alto Adige”, a tal fine creata
e denominata in tedesco “Trentino-Tiroler Etschland” (negando così il nome
Südtirol), i rappresentanti di lingua tedesca erano in evidente minoranza e non
potevano pertanto decidere le proprie agende in una propria autonomia. La
sede della Regione fu inoltre stabilita a Trento. Nell’ambito dell’autonomia re-
gionale furono previste due sub-autonomie per le Province di Bolzano e Trento,
alle quali venivano concessi Consigli ed esecutivi propri. Ma sia le competenze
sia le attribuzioni delle due Province autonome erano talmente circoscritte al
punto che non era certamente possibile affermare seriamente che si trattas-
se di concrete autonomie provinciali. “Diffidenza e sospetto” – scriveva Rena-
16
to Ballardini – “raggelarono via via i rapporti fra potere centrale e sudtirolesi,
produssero uno stillicidio di piccoli inadempimenti, di ritardi nell’emanazione
delle norme di attuazione, di assurde astuzie nella cavillosa redazione dei te-
sti.” 5
9 Dal “Los von Trient” alla notte dei fuochi
Nel 1957 il Governo di Roma annunciò un ampio programma di edilizia po-
polare per Bolzano, fatto che fece temere ai sudtirolesi l’arrivo di una nuova
ondata d’immigrazione da altre zone dell’Italia. “Questo programma poteva esse-re comparato solamente con il programma d’industrializzazione annunciato a suo tempo dai fascisti per italianizzare il Sudtirolo”, affermò l’allora Presidente della Südtiroler Volkspartei Silvius Magnago e il suo partito esortò alla protesta. Il 17 novembre
dello stesso anno 35.000 sudtirolesi convenuti a Castelfirmiano per una grande
manifestazione chiesero a gran voce attraverso lo slogan “Los von Trient” (via da
Trento) l’autonomia regionale per il Sudtirolo.6
La tensione nella popolazione continuava a crescere. Dopo che già negli
anni precedenti si erano verificati alcuni isolati episodi attentatati, scoppiò
l’insorta. Era nella notte tra l’11 e il 12 giugno del 1961, quella della tradiziona-
le domenica del Sacro Cuore, data nella quale il Tirolo commemora le lunghe lotte
per la libertà contro le truppe napoleoniche, accendendo simbolicamente dei
falò sulle montagne. In quella notte fu accesa una nuova miccia: furono compiuti
37 attentati dinamitardi ai danni dei tralicci dell’alta tensione.7
5 Ballardini, R. (1970): Relazione della Ia Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, n. 2216–277 A, Camera dei Deputati, Roma, p. 2.
6 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser, op. cit, p. 21.7 Baumgartner, E./ Mayr, H./ Mumelter, G. (1992): Feuernacht, Südtirols
Bombenjahre, Edition Raetia, Bolzano. Peterlini, H.K. (2005): Südtirols Bombenjahre. Von Blut und Tränen zum Happyend, Edition Raetia.
17
Queste azioni diedero il via ai duri anni della violenza, delle persecuzioni,
degli arresti e delle torture e nelle carceri.8 La Südtiroler Volkspartei, prese uffi-
cialmente le distanze dagli atti estremistici dei bombaroli. Soltanto anni dopo,
Silvius Magnago, divenuto nel frattempo Presidente della Provincia di Bolzano
concesse una riabilitazione agli attivisti: ”Non c’è da meravigliarsi se i sudtiro-
lesi, che per anni hanno dovuto constatare che ricorrendo ai mezzi democrati-
ci, cioè percorrendo la strada delle trattative, non si compiva alcun progresso,
abbiano perduto la fiducia negli strumenti della democrazia.9
La prima ondata di attentati, quelli compiuti nel 1961, costituiva senza dub-
bio una forma di resistenza sorta e sviluppatasi nella base popolare. Per quan-
to ingenti fossero i danni materiali, le persone che si raccolsero attorno a Sepp
Kerschbaumer non volevano fare vittime. La polizia italiana intervenne però
energicamente, incarcerando la maggior parte degli attentatori entro poche
settimane. Purtroppo, le torture ai danni dei detenuti sudtirolesi, emerse in se-
guito alla luce e quindi rese note all’opinione pubblica nel corso dei proces-
si svoltisi nei tribunali, non contribuirono certamente a placare gli animi. Lo
stesso Sepp Kerschbaumer trovò la morte in prigione.
Dopo di lui il movimento sudtirolese cadde in altre mani. I sudtirolesi rac-
coltisi attorno a Georg Klotz restarono in minoranza, mentre contestualmente
i circoli stranieri di estrema destra acquisirono crescente influenza. Purtroppo
si registrarono numerose vittime su entrambi i fronti. Si insinuò il sospetto del
coinvolgimento dei servizi segreti in attività oscure: Rimarranno aperte pre-
supposizioni, speculazioni e mezze verità sinché non si apriranno gli archivi
dei servizi segreti.10
8 Der Mailänder Prozess/Il processo di Milano nelle arringhe della difesa (Raccolta delle arringhe dei difensori degli imputati sudtirolesi ai processi per gli attentati dinamitardi), Casa editrice Europa, Vienna 1969
9 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser Vertrag, op. cit, p. 33.10 Baumgartner, E./ Mayr, H./ Mumelter, G. (1992): Feuernacht, p. 244–270, al
riguardo si veda in modo particolare p. 260; Strasser, W. (1967): Österreich und die Vereinten Nationen, Braumüller Wien, p.370 e 371 e Toscano, M. (1967):
18
10 L’intimazione dell’ONU: “Riprendete le trattative!”
Nell’ottobre del 1960 e nel novembre del 1961, su iniziativa dell’Austria e di altri
Stati l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si occupò due volte della que-
stione dell’Alto Adige Südtirol e dell’annoso problema concernente l’esecuzio-
ne dell’accordo di Parigi. L’Assemblea Generale intimò alle parti di riprendere
le trattative per giungere a una soluzione di tutte le controversie sorte dopo il
Trattato di Parigi del 1946.11
Nel settembre del 1961 l’Italia istituì la Commissione di studio dei problemi dell’Alto Adige, nota anche come “Commissione dei 19”. I lavori di detta commis-
sione e, più in generale, le trattative in corso tra Roma e Vienna, inizialmente
procedettero a rilento, ma trovarono la loro conclusione nel cosiddetto “Pac-chetto” di misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato a Copena-
ghen dal ministro degli Esteri austriaco Kurt Waldheim e dal suo omologo ita-
liano Aldo Moro il 30 novembre 1969. I sudtirolesi riuscirono ad accettare so-
lo faticosamente questo compromesso, poiché esso non recepiva totalmente
quanto essi si attendevano dall’Accordo di Parigi. Il Pacchetto venne comun-
que accettato, a stretta maggioranza dal congresso straordinario della Südtiroler Volkspartei tenutosi a Merano, grazie all’impegno del leader storico Magnago,
che nelle prime ore del mattino del 23 novembre 1969 riuscì a convincere una
risicata maggioranza del suo partito.12
Seguirono, nel dicembre del 1969 la Camera dei Deputati e il Senato del-
la Repubblica e poi il Nationalrat di Vienna, la Camera dei deputati austriaca. I
rispettivi parlamenti non approvarono un provvedimento legislativo, bensì le
dichiarazioni dei loro Presidenti, in Italia del Presidente del Consiglio dei mi-
Storia diplomatica della questione dell’Alto Adige-Südtirol, Laterza, Bari , p. 5. pp. 536–538, 592 e 593.
11 Nazioni Unite, risoluzioni, n. 1497 (1960) e n. 1661 (1961). Testo delle risoluzioni in: Peterlini, O. (2000): Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige, op. cit., pp. 92–95.
12 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser Vertrag, op. cit., p. 46.
19
nistri Mariano Rumor e, in Austria, del Cancelliere Josef Klaus, dichiarazioni
con le quali venivano proposte le misure citate. Un calendario intrecciato d’im-
pegni reciproci, legislativi e amministrativi, il cosiddetto “calendario operativo”,
prevedeva inoltre una garanzia per la graduale attuazione del Pacchetto. Si aprì
così una nuova stagione, la stagione della nuova autonomia e della sua attua-
zione.
11 Le basi politiche e giuridiche: il Pacchetto e lo Statuto
Il cosiddetto Pacchetto contenente le misure a favore delle popolazioni altoa-
tesine, contiene 137 disposizioni, varie precisazioni e note interpretative. Esso
costituisce l’impegno politico a emanare una serie di provvedimenti a favo-
re dei sudtirolesi, che dovevano trovare adempimento in parte mediante una
legge costituzionale, riformando lo Statuto di Autonomia, e in parte attraver-
so norme di attuazione e leggi ordinarie, nonché con provvedimenti di natura
amministrativa. Il Pacchetto non va quindi identificato con lo Statuto di Autono-mia, che costituisce soltanto una parte dell’attuazione, anche se la più rilevante.
In attuazione del Pacchetto, il Parlamento emanò la Legge costituzionale n.
1/1971, che prevedeva incisive modifiche e integrazioni dello Statuto speciale
del 1948,13 in seguito raccolte in un testo unificato, il nuovo Statuto di Autono-
mia nella sua versione consolidata.14 Le norme attuative dovevano essere ema-
nate entro due anni dall’entrata in vigore dello Statuto stesso. Ma in realtà si
impiegarono venti anni, fino al 1992.
Nella gerarchia delle fonti lo Statuto di Autonomia rivesta lo stesso rango
primario della Costituzione e, in caso di conflitto, esso prevale in forza della
sua specialità. Immediatamente dopo di esso seguono quindi le sue norme di
attuazione, seguite a loro volta dalle leggi ordinarie e dagli atti amministrativi.
13 La riforma dello Statuto di Autonomia entrò in vigore il 20 gennaio 1972, quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14 DPR 31 agosto 1972 n. 670.
20
12 Le Province vere protagoniste dell’autonomia
Alle due Province autonome di Bolzano e Trento furono attribuite la maggior
parte delle competenze. La Regione rimane come una sorta di cornice, poiché
è stata spogliata di buona parte delle sue competenze originarie. Il primo arti-
colo dello Statuto dispone che: “Il Trentino Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto”.15
La riforma costituzionale ha, nel 2001, capovolto questa prevalenza della
Regione e, sulla base del principio di sussidiarietà, precisato che: “La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.”16
Delle poche competenze rimaste alla Regione, rivestono particolare impor-
tanza quella sugli enti locali (i comuni) e quella sulla previdenza complemen-
tare, tema sul quale la Regione ha sviluppato innovativi progetti.17
La competenza sulla maggior parte delle altre materie è stata trasferita o
delegata alle Province autonome di Trento e di Bolzano, divenute quindi le ve-
re protagoniste dell’autonomia, occupandosi, infatti, di cultura, economia e di
numerosi altri aspetti sociali. Il Consiglio provinciale legifera in sostanza sul
90% delle materie. Che siano opere pubbliche, strade (anche statali), ospedali
o scuole, incentivi economici nei vari settori o sostegni sociali, i stipendi degli
insegnanti o il finanziamento dell’Università, la protezione dell’ambiente o la
conservazione del patrimonio storico, lo sport o il tempo libero, è la Provincia
autonoma che interviene e finanzia, e da recente si è assunta anche il finanzia-
15 Statuto di autonomia in versione aggiornata (2010): http://www.regione.taa.it/normativa/statuto_speciale.pdf.
16 Art. 116, comma 2, Costituzione italiana: http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html.
17 Peterlini, O. (2003): Le nuove pensioni . FrancoAngeli, Milano. Peterlini, O. (2000): Pianificare il futuro, La nuova previdenza complementare in Trentino Alto Adige, Athesia Bolzano.
21
mento delle le trasmissioni RAI in lingua tedesca e ladina, le Poste, e strutture
di competenza dello Stato come le carceri. 18
Il finanziamento, già aggiornato al federalismo fiscale, è garantito al 90%
del gettito proveniente dal territorio. Varie sono anche le garanzie a tutela dei
gruppi linguistici, come ad esempio la proporzionale linguistica per l’assunzione
in enti pubblici e l’occupazione negli organi amministrativi e, oltre il criterio
del bisogno, per l’assistenza e l’edilizia sociale. Nella Regione la lingua italiana
e quella tedesca sono parificate, quella ladina tutelata nelle valli ladine, men-
tre l’insegnamento scolastico viene garantito da personale insegnante appar-
tenente al gruppo linguistico degli alunni.
13 Le tentazioni della secessione e la strada dell’autonomia
La SVP, dalla sua nascita nel 1945 a tutt’oggi il partito maggiore delle minoran-
ze linguistiche sudtirolesi, perseguì la strada dell’autonomia. Non rinunciò mai
formalmente al diritto di autodeterminazione, ma si rese conto che l’unica via
percorribile non fosse quella di rincorrere un diritto non realizzabile ma la stra-
da della Realpolitik, rappresentata soprattutto dal leader storico Silvius Ma-
gnago (Segretario della SVP dal 1957 al 1991). Ma la scelta provocò forti tensio-
ni interne. Il Südtiroler Heimatbund, l’associazione degli attivisti carcerati de-
gli anni 60,19 e l’ala più oltranzista del partito chiedevano il ritorno all’Austria.
Magnago persisteva a rispondere che i confini si cambiano o con il consenso
delle due parti o con la guerra. Poiché il consenso da parte italiana sembrò im-
possibile, anche alla luce delle resistenze poste in qui anni a una vera autono-
18 Peterlini, O. (2010): L’autonomia che cambia, Gli effetti della riforma costituzionale del 2001 sull’autonomia speciale del Trentino Alto Adige Südtirol e le nuove competenze in base alla clausola di maggior favore, Casa editrice Praxis 3 Bolzano, pp.145–156.
19 http://www.suedtiroler-freiheitskampf.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=44.
22
mia, sarebbe rimasta la guerra. E Magnago, ironizzando, aggiungeva che una
guerra si doveva non solo iniziare ma anche vincere.
Il tema dell’autodeterminazione rischiò, però, di spaccare la SVP, quando
Eva Klotz,20 primogenita dei sei figli di Georg Klotz, attivista degli attentati degli
anni 60, nel 1983 lasciò il gruppo consiliare della SVP nel Comune di Bolzano
e si candidò con il Südtiroler Heimatbund al Consiglio provinciale. La passionaria del Sudtirolo, come la battezzarono i media italiani, si sente chiamata a prose-
guire l’opera di suo padre con strumenti pacifici e democratici, perseguendo
il fine dell’autodeterminazione per il Sudtirolo. Eletta Consigliere provinciale
e regionale nel 1983, ne fa tuttora parte da 28 anni. Nelle più recenti elezioni
del 2008 la sua lista, Südtiroler Freiheit, ottenne 14.888 voti (il 4,9% del totale) e
due Consiglieri. A questi vanno aggiunti, per affinità politica i 7.048 voti (2,3%)
dell’Union für Südtirol, partito che la stessa Eva aveva fondato ma poi lasciato
dopo una scissione nel 2007.
Sul fronte dell’opposizione alla SVP negli anni più recenti si è profilato so-
prattutto il partito dei Freiheitlichen, che raggiunse, sempre nel 2008, 43.614 voti,
il 14,3% e cinque consiglieri. I Freiheitlichen vantano un programma più ampio
che va oltre il tema dell’autodeterminazione, ma persegue anche un modello
di Freistaat (Stato libero), come recentemente sottolineò il loro Segretario Pius Leitner, che vorrebbe coinvolgere nella sua visione anche il gruppo linguistico
italiano.21 Sommando le tre forze politiche si arriva a 65.550 voti, corrispon-
dente al 21,5%, e a complessivamente otto consiglieri (dei 35 complessivi).22 La
SVP rimase però il partito di maggioranza assoluta con il 48,1% dei consensi e
18 consiglieri.
20 http://www.consiglio-bz.org/de/abgeordnete/klotz.asp.21 Discorso del’8.1.2011: http://www.die-freiheitlichen.com/index.php/unsere-
arbeit/reden/3453-3-freiheitliches-dreikoenigstreffen-am-8-jaenner-2011-in-eppan-ansprache-von-lpo-und-l-abg-pius-leitner.
22 Ferrari, P. (2009): Südtiroler Handbuch, Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio stampa Bolzano, p.90.
23
14 Se l’Italia perdesse il sua carattere democratico
La linea politica della SVP sul tema dell’autonomia non è cambiata. Il parti-
to ha sempre respinto le tentazioni derivanti dall’opposizione. Solo una volta,
nel 1976, uno dei padri nobili del partito, il Senatore SVP Peter Brugger, all’in-
combente “pericolo comunista”, minacciò che “chiederemo l’autodetermina-
zione” se in Italia vincessero i Comunisti, temuti allora come un ritorno allo
stalinismo russo, anche se in verità allora erano guidati da Enrico Berlinguer
che cercava l’apertura verso i cattolici. Il messaggio in sintesi era quello, che se
l’Italia perdesse il suo carattere di Stato liberale e democratico, la maggioranza
– diceva Brugger – voterebbe per l’Austria.23 Da menzionare è anche una peti-
zione firmata in gennaio del 2006 dalla maggior parte dei sindaci (113 di 116)
dell’Alto Adige per inserire il diritto all’autodeterminazione del Sudtirolo nella
Costituzione austriaca, intento promosso da una parte dell’ÖVP austriaca, poi
rilevatosi più una campagna elettorale per le elezioni al Nationalrat che una pro-
posta seriamente seguita.
15 Magnago preferisce “Roma lontana” alla Lega vicina
Forte del consenso elettorale alle politiche del 1996 (30% in Veneto, 25% in
Lombardia), il 15 settembre la Lega Nord, radicalizzando la propria politica,
annunciò di voler perseguire il progetto della secessione delle regioni dell’Italia
settentrionale (indipendenza della Padania). A tal fine organizzò una manife-
stazione lungo il fiume Po il cui culmine si tenne a Venezia. Dopo le note vicen-
de giudiziarie, la Lega mostrò di non accontentarsi di queste riforme e decise di
proseguire nella sua battaglia secessionista, creando le Camice Verdi e un Gover-no padano. Il programma secessionista subì, dopo il 1997 una battuta d’arresto
e un calo di consensi, in considerazione anche dei tentativi di federalizzazione
espressi dal legislatore costituzionale. La SVP ha seguito con interresse lo svi-
23 Der Spiegel, rivista della Germania, 11/1976.
24
luppo federale in Italia, contribuendovi quanto poteva, sia in Parlamento sia
tramite le Conferenze dei Presidenti della Regioni e dei Consigli regionali. Poco
invece è stata coinvolta dai tentativi di secessione della Lega. Magnago una vol-
ta disse che è meglio stare con Roma che è lontana piuttosto che con Milano,
che sarebbe troppo vicina.
16 Francesco Cossiga propone l’autodeterminazione del Sudtirolo
Il Presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, da Senatore a vita pre-
sentò già nella trascorsa legislatura un disegno di legge costituzionale al Senato
per concedere il diritto di autodeterminazione al “Land Südtirol”. Cossiga ripre-
sentò il suo disegno di legge anche nella corrente legislatura nel 2008 al Sena-
to.24
Nella sua relazione Cossiga ricordava la storia del “Tirolo del Sud” e la sua
annessione all’Italia dopo la seconda Guerra mondiale. Da grande conoscitore
della storia, narra anche come la Contea del Tirolo godette sempre di uno sta-
tus speciale anche sotto l’Austria, ricordando l’esenzione dei Tirolesi dal se-
vizio di guerra per l’Austria, i corpi degli Schützen per l’autodifesa nonché i di-
ritti di libertà di cui godevano i Tirolesi all’interno dell’impero. Cossiga, nella
sua relazione al disegno di legge, criticava anche l’annessione all’Italia alla luce
dei principi rinascimentali: “Mai, durante il Risorgimento, da Cavour a Cesare
Balbo, da Mazzini a Cattaneo a Garibaldi, nessuno pensò che della futura Ita-
lia Unita dovesse fare parte il Tirolo, escluso il Trentino, che anche se di cultura
24 Disegno di legge costituzionale N. 218, d’iniziativa del senatore Cossiga, comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2008. Riconoscimento del diritto di autodeterminazione al Land Südtyrol – Provincia Autonoma di Bolzano, Senato della Repubblica XVI. Legislatura, tipografia del Senato (600), Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica.
25
italianissima acquistò solo con Cesare Battisti e con il socialismo trentino una
coscienza «irredentista»..”
Nella relazione al suo disegno di legge Cossiga richiamava anche il diritto
all’autodeterminazione:
“Il diritto di autodeterminazione dei popoli consacrato nelle dichiarazioni
delle Nazioni Unite ed in quelle del Consiglio d’Europa, e che e` stato di fonda-
mento alla costituzione sulle ceneri della Jugoslavia degli Stati indipendenti di
Slovenia, di Croazia, di Bosnia Erzegovina, della Macedonia, del Montenegro e
del Kossovo, non può essere negato al popolo del Tirolo del Sud.”
Nel suo disegno di legge Cossiga prevedeva un Referendum, nel quale i cit-
tadini dell’Aklto Adige si potessero scegliere tra varie alternative, che variega-
vano dalla possibilità di rimanere in Italia, a uno Stato indipendente, all’annes-
sione all’Austria, o alla Germania. 25
17 Le reazioni a Bolzano
La SVP, inizialmente, sembrava possibilista: “È una bella sorpresa su cui ragionare”
disse il Presidente della Provincia Luis Durnwalder. Il presidente del suo stesso
partito però, Elmar Pichler Rolle, invitò a “tenere i nervi saldi”. “È una proposta fuori dalla storia” disse Gianclaudio Bressa, deputato dell’Unione eletto a Bolzano. Con-
trari anche i Ds: “È una spacconata”. An attaccò Cossiga con violenza: “È una scheg-gia impazzita che spiazza chi ha sempre soffiato sul fuoco dell’autodeterminazione”.26
Dopo i primi commenti, le reazioni a Bolzano furono piuttosto fredde, a
parte naturalmente l’entusiasmo della Consigliera Klotz, del Heimatbund e,
in modo più moderato, dei Freiheitlichen. La SVP si è vista, infatti, fortemente
sconfessata nel suo difficile cammino per l’autonomia e contro la scissione, nei
lunghi anni che la vedevano impegnata a tranquillizzare le tensioni e a trova-
25 Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 218 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
26 La Repubblica del 25.05.2006, p. 12.
26
re soluzioni pacifiche e condivise. La SVP si chiese anche perché Cossiga non
avesse presentato il suo disegno di legge quando rivestiva le più alte cariche
dello Stato, invece che da Presidente emerito e Senatore a vita. Cossiga si mo-
strò comprensibilmente offeso dal mancato accoglimento della sua proposta.
L’autodeterminazione rimane sicuramente un diritto irrinunciabile, appar-
tenente a tutti i popoli, ma l’attuazione non è altrettanto facile e ovvia. È uno
strumento delicato che non si presta a giocare come con il fuoco. Deve essere
conservato per momenti di estrema emergenza, quando incombesse il perico-
lo di un regime che violi i diritti delle minoranze linguistiche e dell’autonomia.
Non mi riferisco naturalmente ai comunisti di una volta, ma in sintonia con
il Senatore Peter Brugger, a possibili governi che violino i principi democratici
anche con nuove forme di un presidenzialismo popolare moderno. In quel ca-
so si potrebbe contare con la solidarietà del mondo internazionale e non solo
dell’Austria, che potrebbe risollevare il caso presso le Nazioni Unite. Farne uso
in tempi tranquilli, in un’Europa che sta superando i confini, significherebbe
riaccendere speranze al momento poco realistiche e riaprire tensioni supera-
te con grande difficoltà. Meglio puntare invece sull’autonomia, cioè a una for-
ma di autodeterminazione interna, e a rivitalizzare la collaborazione europea e
transfrontaliera.
18 Le autonomie speciali – eccezioni in un contesto centralistico
Il Trentino Alto Adige non è l’unica Regione con uno statuto speciale. Per af-
frontare le particolarità e i problemi che si presentavano per diversi motivi sto-
rici, politici e culturali, furono previste sin dall’inizio (con l’art.116 Cost.) Re-
gioni a statuto speciale, prima quattro e poi (nel 1963) una quinta. Si tratta delle
due isole maggiori Sicilia e Sardegna e delle Regioni di frontiera Trentino-Alto
Adige/Südtirol, Valle d’Aosta e del Friuli Venezia Giulia, che si è aggiunta come
27
ultima nel 1963. Tra le varie ragioni già elencate si trova anche la risposta che
si voleva dare alle tendenze separatiste presentatesi dopo la guerra nelle isole e
nelle zone di confine.
A queste cinque Regioni vennero ”attribuite forme e condizioni particolari di au-tonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali”, come citava verbal-
mente l’articolo 116 della Costituzione nella sua prima versione. Le loro ampie
competenze legislative e amministrative rappresentano un’eccezione rilevan-
te nell’ordinamento statale italiano. Le competenze attribuite a queste Regioni
speciali e più tardi (con il nuovo Statuto del 1972) alle Province autonome di
Trento e di Bolzano non temono il confronto con quelle che invece sono dete-
nute per esempio dai Länder austriaci (le Regioni), anzi per alcuni aspetti sono
persino più ampie e descrivono un’autonomia maggiore.
Esse assumono una posizione particolare nel diritto costituzionale, contra-
stano con il resto della struttura dello Stato. La loro posizione particolare pro-
voca anche invidie, soprattutto tra chi non conosce le vere ragioni della loro
particolarità.
La Costituzione italiana entrata in vigore nel 1948, con i suoi principi, con
le sue garanzie per i diritti civili, sociali, economici e politici è animata da un
grande spirito democratico, liberale e sociale che la colloca senza dubbio tra le
costituzioni più moderne e democratiche. L’ordinamento statale invece, segui-
va una chiara traccia centralistica. Era prevista la presenza delle Regioni, ma
senza che erano state loro attribuite competenze esclusive proprie. I padri Co-
stituenti erano ispirati dal compito di rafforzare l’unità d’Italia e di evitare una
nuova frammentazione in tanti piccoli Stati.
La Costituzione prevedeva la presenza di Comuni, Province e Regioni, con-
siderandoli però non tanto quali soggetti costituenti dello Stato, ma più una
sua semplice articolazione. Le poche competenze assegnate alle Regioni non
furono attuate.
Mentre nel caso degli Stati federali le articolazioni interne sono inserite in
un contesto federale e rappresentano una parte organica dello Stato, le Regio-
28
ni italiane a statuto speciale invece si trovano spesso in rotta di collisione con i
principi centralistici di uno Stato, in cui rappresentano non la regola bensì l’ec-
cezione. La lotta decennale per la realizzazione dell’autonomia dell’Alto Adige/
Südtirol è un palese esempio di questa frizione. Lo Statuto speciale della Sicilia
è stato elaborato ed è entrato nell’ordinamento giuridico italiano addirittura
prima della stesura della Costituzione (già nel 1946), proprio per i movimen-
ti separatistici, e detiene (almeno sulla carta) competenze molto maggiori ri-
spetto a quelle dell’Alto Adige/Südtirol. In realtà però la Sicilia ha usufruito di
un margine d’azione più circoscritto e, nella concreta attuazione, ha realizzato
un’autonomia di fatto meno estesa nonostante formalmente sia appunto più
ampia.
19 La riforma federale – un’autonomia più ampia per tutti
Dagli anni ’80 e ’90 sono stati intrapresi vari tentativi per una riorganizzazione
in senso federale dello Stato. Dopo diverse rincorse andate a vuoto, nel 2001
l’Italia riescì a darsi una riforma costituzionale,27 che non l’ha trasformata in
uno Stato federale sul modello americano o – in Europa – austriaco, tedesco o
svizzero, ma ha bensì introdotto alcuni principi fondamentali del federalismo.
Le Regioni e gli enti territoriali non sono più una pura articolazione dello
Stato. Sono diventati pilastri portanti, che insieme con lo Stato costituiscono la
Repubblica, come recita il nuovo art. 114 della Costituzione.
Le competenze statali sono state circoscritte ed è stata introdotta una clau-
sola generale a favore delle Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropo-
litane e le Regioni dispongono di propri statuti, poteri e funzioni, nonché di
un’autonomia finanziaria, di proprie risorse e patrimoni. Il nuovo progetto
in corso di attuazione sul federalismo fiscale dovrà inoltre rafforzare le attri-
27 Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, no. 3, entrata in vigore in data 8 novembre 2001.
29
buzioni finanziarie di questi enti e istituire un fondo di solidarietà per quelli
più poveri. Altre riforme costituzionali sono in discussione, al fine di riservare
una delle due Camere alle Regioni e quindi realizzare una loro partecipazione
all’iter decisionale dello Stato.
Gli Statuti delle Regioni speciali, sono dal punto di vista formale rimasti
immutati. La riforma Costituzionale del 2001 non è stata recepita nel testo for-
male degli Statuti. Ma nella sostanza la riforma li ha profondamente mutati,
apportando novità notevoli, che leggendo il testo stampato non si intravve-
dono. In conseguenza della c.d. “clausola di maggior favore“ le disposizioni della
riforma costituzionale trovano, infatti, una immediata applicazione anche al-
le Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per
quelle parti che “prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribui-te” (art. 10, legge Costituzionale 3/2001).
Con ciò le Regioni autonome hanno ottenuto, con l’evoluzione federale
dell’Italia, più autonomia di quanto non era loro riconosciuto dai loro rispet-
tivi Statuti.28
Dall’essere quindi un’eccezione assoluta all’interno di uno stato centralisti-
co, con il quale collidono, le Regioni autonome diventano quasi dei precursori
di un nuovo sistema più federale.
20 Una visione e un auspicio
L’autonomia raggiunta costituisce non certo l’adempimento di tutte le richieste
dei Sudtirolesi ma un punto d’incontro, un compromesso riconosciuto valido
anche a base internazionale, un modello di convivenza di tre gruppi linguistici e
di equilibrio molto delicato, che si spera, abbia saputo superare definitivamen-
28 Peterlini, O. (2010): L’autonomia che cambia, Gli effetti della riforma costituzionale del 2001 sull’autonomia speciale del Trentino Alto Adige Südtirol e le nuove competenze in base alla clausola di maggior favore, Casa editrice Praxis 3 Bolzano.
30
te le contrapposizioni e possa prevenire altri conflitti. Il nuovo Statuto di auto-
nomia del 1972 rappresenta il tentativo di assicurare la sopravvivenza alle mi-
noranze tedesca e ladina con le loro lingue e culture. L’autonomia vuole e deve
però anche garantire una pacifica convivenza dei tre gruppi etnici.
Lo Statuto di autonomia offre alla popolazione dell’Alto Adige e del Trenti-
no una consolidata autonomia legislativa ed amministrativa che permette lo-
ro, in molti importanti settori, di improntare la propria vita secondo le proprie
esigenze; essa pertanto va a vantaggio di tutti e tre i gruppi linguistici ovvero
quello italiano, tedesco e ladino. La prosperità economica, il basso tasso di di-
soccupazione, i servizi in campo sanitario, la promozione dell’edilizia abitativa
agevolata e le conquiste sociali ne sono un esempio tangibile.
Anche la crescita della Casa comune europea e l’adesione dell’Austria
all’Unione Europea (dal 1 gennaio 1995) costituiscono importanti tappe di tale
processo. Il confine del Brennero ha perso e perderà sempre piè la sua impor-
tanza. In questa Europa sempre più grande la partecipazione democratica dei
cittadini diventa però sempre più difficile. È doveroso pertanto che si cerchi di
rivalutare le Regioni e creare degli spazi in comunità di piccola e trasparente
configurazione, nei quali le popolazioni possano compartecipare.
La creazione di una “Euregio” transfrontaliera (il nome è ancora oggetto di
discussioni) con il coinvolgimento delle componenti del Tirolo storico, già prevista per
la prima volta nel programma di coalizione della Regione Trentino-Alto Adige
nel 1994, può costituire una via pacifica per superare i confini e ridare a tut-
te le popolazioni quella dimensione storica, che le era stata tolta nel 1918. Il
22 febbraio 1995 il Parlamento italiano ha approvato l’Accordo tra l’Austria e
l’Italia sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali (legge
n. 76/1995). Grazie a tale accordo potrà essere raggiunta una vera cooperazio-
ne in diversi settori come ad esempio quello economico, dei trasporti e delle
comunicazioni, della distribuzione dell’energia, della tutela ambientale, della
31
cultura, dello sport e tempo libero, della sanità, in numerosi settori sociali e nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica applicata.29
Questa Regione europea potrà fungere da modello per il superamento dei
confini e da ponte tra il nord e il sud, giacché fondata sul polimorfismo, sulla
molteplicità linguistica, culturale e su una storia ricca di tradizione.
La sfida in Alto Adige Südtirol va ancora oltre. È di far sentire tutti i gruppi
a casa propria, senza soprafazione dell’uno sopra l’altro, facendo della diversi-
tà una fonte di ricchezza invece che di scontro. Vogliamo essere fieri di vivere
in questa terra, di godere di un’autonomia che meglio può recepire le esigenze
della gente, che ha dato frutti visibili per tutti, fieri di conoscere più lingue e
culture, di vivere e anticipare l’Europa di domani e dare ai giovani non solo più
opportunità di lavoro in Italia e all’estero, ma anche un orizzonte professionale
e culturale più ampio. Serve a tal fine trovare una convergenza ancora miglio-
re tra i gruppi linguistici sul cammino da intraprendere e sviluppare una viso-
ne dell’autonomia, nella quale tutti i gruppi linguistici possano identificarsi. Si
tratta di portare avanti un progetto di condivisione di valori e di prospettive
comuni che si contrappone fermamente alla politica di scontro e di divisione
etnica da sempre perseguita dalle destre.
21 Operare per la pace
Quanto meglio uno Stato saprà costruire il proprio assetto secondo il principio
di sussidiarietà, quanto più saprà sostituire l’imposizione di appartenenza allo
Stato con una libera scelta e con il federalismo, quanto più autonomo e rispet-
toso delle minoranze saprà essere, tanto più sicura diventerà la sua esisten-
29 L’Accordo-quadro europeo sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività territoriali, Madrid 1980 ed il relativo Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria, Vienna 1993 in: Regione autonoma, Trentino-Alto Adige, la cooperazione transfrontaliera, Proposte per il suo sviluppo, Centro stampa e riproduzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Trento 1993.
za poiché avrà saputo prevenire i conflitti e rendere superflue le modifiche dei
confini. Speriamo pertanto che l’umanità possa trarre un insegnamento dal-
le cruenti guerre del passato, cariche di sofferenze, in modo da consolidare la
pace.
Sarà pertanto motivo di orgoglio se le nostre esperienze auto nomistiche
potranno in qualche modo contribuire alla soluzione dei molteplici e diversi-
ficati problemi delle minoranze etniche in Europa e nelle altre parti del mondo.
35
1. Freedom – a lesson learnt with difficulties
In reading history books, one learns that, unfortunately, for thousands of years
mankind has been ravaged by battles and wars that took a heavy toll in terms of
human lives and resources. Hidden behind the historical data, behind the cur-
tain of official scenes there are millions of human tragedies, shattered families,
men, women and children who died or were maimed in wars.
Sometimes we may wistfully remember the classical times of Mesopota-
mia, ancient Greece, the Roman Empire and forget that the most important
historical milestones were marked by extremely cruel wars, such as the con-
quest of Troy, the conflicts between Sparta and Athens, the Persian attacks, the
destruction of Carthage in 202 B.C. and that of Corinth in 146 B.C. We recall the
crusades fought in the name of God (or rather as an affront to God), the wars
between the peoples of Europe, but also the wars in Italy and Germany, and
those between feudal families struggling for power.
The Thirty-Year War, which ravaged Europe between 1618 and 1648 –
fought for ostensibly religious reasons – appears to have gone down in history
as one of the longest wars ever fought. The Peace of Westphalia in 1648 should
have put an end to the devastation, but it did not.
The century that followed was emblematic: the years between 1667 and
1763 were almost one hundred years marked by continuous wars. France was
at war for 53 years, England and Holland for about 40, Russia for 33 years.1
It seems that history has taught little or nothing to policy makers through
the ages – since they have continued and still continue to use weapons to gain
power or solve conflicts. As if earthquakes and tsunamis were not enough!
1 Gentile, G./ Ronga, L. (2005): Storia & Geostoria, vol. IV: Dalla metà dei Seicento alla fine dell’Ottocento, La Scuola, Brescia, pages 64–71, http://www.luzappy.eu/storia_intro/settecento.htm.
36
2. A gift from the founding fathers of Europe – 67 years of peace
Even though conflicts in the world continue on a daily basis – there is a glim-
mer of hope: Europe. The lesson of history could no longer be ignored: after
thousands of years in the battlefield, with two world wars in fifty years an un-
precedented peak was reached. Millions of lives were lost, entire populations
were wiped out – the blood and tears that were shed were a turning point –
at least for the following half-century and at least in one part of the European
continent.
We should not forget that wars were fought until recently in Eastern Eu-
rope.
However, the lesson has been learnt as never before in history, at least in
Western Europe. For over 67 years we have been fortunate enough to live and
experience the longest-ever period of peace. The contribution to peace is prob-
ably the greatest gift given by the founding fathers of Europe to us and hope-
fully to the future generations of Europe. Thanks also to the European integra-
tion process, the States that up until the 1970s were under military dictator-
ship, such as Greece, Portugal and Spain, could become stable democracies.
Eastern European countries, which for a long time were ‘walled in’ inside
the Soviet bloc, were excluded from this process. The hopes of freedom of peo-
ples, nations, and ethnic minorities – forced into artificial states held together
by military force alone – were ignored.
In the fourth last part of the century, however, when history gave those peo-
ples an opportunity to lift themselves out of their situation; they revolutionized
the whole of Europe.
The Iron Curtain, which was like a wound severing the heart of Germany,
suddenly collapsed: it was an event that took even the most visionary political
scientists by surprise and thanks to which many Eastern states found their na-
tional identity again.
37
3. Reasons for the outbreak of international conflicts
In an essay written in 1959, Kenneth N. Waltz, an American international rela-
tions theorist, tried to analyze the causes of war2 and found three: he identified
the first cause in the nature and character of people, their selfishness, aggres-
sion and stupidity. The second level of his analysis focuses on the internal or-
ganization of States and the idea that they need an external enemy in order to
feel united. The third level suggests that wars are the result of the international
system, which is anarchic and does not have a governing power.
In addition to these causes, there is another one, which continues to be a
source of instability and conflict: when state boundaries that do not match eth-
nic boundaries are drawn, ethnic minorities are found both within the state
territory and outside its borders”.
One of the main causes of the outbreak of international conflicts must be
sought in the lack of programs for the resolution of conflicts between different
nationalities and ethnic minorities. This is particularly evident in Eastern Eu-
rope and in the events that followed the collapse of the Soviet Union.
Throughout history state borders and ethnic-group boundaries have rarely
coincided. This has been the cause of conflicts and of many wars and still un-
resolved problems of ethnic groups. Religious and cultural reasons, on top of
ethnic reasons, have sometimes concealed the true motives.
Therefore, finding a solution to the problems of minorities and nationali-
ties is a challenge that can eliminate these flashpoints and ensure peace.
2 Waltz, K.N. (2001): Man, the State and War, Columbia University Press, New York, originally published 1959.
38
4. Warning: “Perennial seeds of discord and revolt”
An evident case in point is South Tyrol, annexed to Italy after World War I and
later named Alto Adige.
Recently on the occasion of the 150th anniversary of Italy’s unification,
some government representatives, Ministers, Presidents of Regions as well as
representatives of the Lega levelled criticism (to put it euphemistically) at the
celebrations, but this did not cause too much of an uproar. Conversely, when
the President of the Province of Bozen/Bolzano, Luis Durnwalder, failed to par-
ticipate in the celebrations, a national scandal broke out. I do not want to go
into that controversy now, but it is worth recalling it to explain the difference
in attitudes which result from historical events that were perceived differently.
After World War I, Tyrol, which in its century-long history developed as
an autonomous land with its own rights and liberties within the Austro-Hun-
garian Empire, was torn apart and divided up. The southern part was assigned
to Italy, but not on the basis of the clearly recognisable language divide, in line
with the principles of American President Thomas W. Wilson.
In the name of Risorgimento and other patriotic principles authoritative
voices argued against the annexation. On 14 July, 1919 the MP Filippo Turati
warned the Chamber of Deputies to reject “the annexation of over 250.000 Germans, jealous of their ancestry, their homeland, their freedom – which would sow perennial seeds of discord and revolt”.3
Then came the painful dictatorships of Mussolini and Hitler, the suppres-
sion of minority languages and cultures, the closing down of German schools,
the firing of German teachers and employees, Italianisation and forced immi-
gration. The campaign peaked in 1939 with the treaty signed in Berlin by Hit-
ler and Mussolini, which led to the so-called “options”, whereby the people of
3 Peterlini, O. (2000): Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige, edizione aggiornata, Cenni di storia e cultura, diritto e politica, Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Bozen/Bolzano/Trento.
39
South Tyrol had to vote on whether they wanted to remain in Italy or leave the
country. Amid rampant Nazi propaganda, a suffered decision was taken that
divided entire families. The South-Tyrolean’s who wanted to remain German
had to migrate to Nazi Germany, while the others could remain in Italy under
the conditions imposed by the fascist regime.
5. Hope after the war: self-determination
At the end of April 1945, the supreme commanders of the German armed forces
in Italy signed an armistice with the Allied forces, unbeknownst to the German
Army headquarters. In so doing, they prevented the entire territory from being
exposed to the onslaught of the Allied forces air raids. In early May the allied
forces marched into South-Tyrol.
On May 8, 1945, Erich Ammon, a Bozen/Bolzano shopkeeper, together with
a group of supporters, founded the Südtiroler Volkspartei (SVP). The party was
recognised by the allied forces because it had its roots in the South-Tyrolean
resistance movements and in the movements of those who did not opt for Ger-
many.
After the war, South Tyroleans asked to exercise their right to self-determi-
nation and tried to achieve reunification with Austria, but Austria’s request to
hold a referendum in South Tyrol was rejected by the Allies on April 30, 1946.
Soviet Foreign Minister Molotow was the first one to reject Austria’s request.
He thought Yugoslavia’s requests concerning Friuli Venezia Giulia had to be
met first.
The “minor border adjustments” that were originally proposed to return
Pustertal Valley together with the Eisack-Valley and the Wipptal-Valley, were
also rejected on 24 June 1946 by the four Foreign Ministers of Great Britain,
France, the Soviet Union and the United States. The Südtiroler Volkspartei
40
(SVP) also rejected such a partial solution, fearing that the remaining territory
of South Tyrol would be weakened and possibly undergo Italianization.4
6. Internationally enshrined principles, a safeguard for the future
After long negotiations and following pressure exerted by many countries,
and thanks to the mediation by British Foreign Minister Ernst Bevin, the Paris
Agreement between Italy and Austria was finally signed on 5 September 1946
by Karl Gruber and Alcide De Gasperi. On 3 December 1946, the Foreign Min-
ister conference held in New York agreed to include the Paris Agreement in Ar-
ticle 10 of the peace treaty signed by Italy on 10 February 1947 in Paris. The im-
portance of this decision lies in the internationalisation of the South Tyrolean
issue, as a result of which Austria became a signatory to the Treaty of Paris.
Ambassador Mario Toscano later revealed the reasons that had led De Gasperi
to sign it: a treaty directly signed with Austria would mean a de facto recogni-
tion of the Brenner border. Indeed, this diplomatic solution would no longer
have allowed the Austrian government to speak of a “diktat”, as the Austrians
signed the agreement freely. For Alto Adige / South Tyrol the agreement meant
that the principle of its autonomy was securely enshrined in an international
agreement.
7. The main points of the Treaty of Paris of 1946
Article 1 of the Treaty of Paris envisages that “the German-speaking inhabitants of the Bolzano Province and of the neighbouring bilingual townships of the Trento Province will be assured a complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants”. More
specifically, Article 1 ensures, in addition to bilingual names of places, that
4 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser Vetrag, Steering committee of the SVP, Bozen/Bolzano.
41
German-speaking people are taught in their native language and that German
is considered on a par with Italian in public administration, documents, etc.
By giving “the population of the above-mentioned zones (...) the exercise of an auton-omous legislative and executive regional power” Article 2 envisages true autonomy
for these people.
Article 3 required Italy to review – in a spirit of understanding – the regime
of citizenship options for those who had previously opted for Germany, and to
enter into agreements with Austria for mutual recognition of educational qual-
ifications and free circulation of people and goods.
Then a painful process leading to autonomy started: autonomy was at first
denied and faked, violent strife followed, as well as two UN Resolutions; it was
only in 1992 that the process finally ended.
8. Diffidence and suspicion chilled relations
With constitutional law No. 5 of February 19, 1948, Italy issued the first Statute
of Autonomy that disappointed the expectations of South Tyroleans. The au-
tonomy it envisaged was quite limited and not in keeping with text of the Paris
Agreement. Its scope was not limited to “the German-speaking inhabitants of the Province of Bolzano and those in the neighbouring bilingual communities of the Province of Trento” (as the text of the agreement read), but was extended to the whole
Province of Trento. In the “Trentino Alto Adige” Region, which was established for
the purpose of the above extension and in German was called “Trentino-Tiroler Etschland” (thus not acknowledging the name Südtirol), the German-speaking
representatives were a clear minority and could therefore not set their agen-
das autonomously. The Regional government was located in Trento. Within
the regional autonomy two sub-autonomies were envisaged for the Provinces
of Bozen/Bolzano and Trento, which were granted their own councils and ex-
ecutive committees. However, both the responsibilities and the powers of the
two autonomous provinces were so limited that they could not possibly be con-
42
sidered autonomous provincial authorities. “Diffidence and suspicion” – so wrote
Renato Ballardini – “gradually chilled the relations between the central power and the South Tyroleans, leading to an endless, albeit small, trickle of acts of non-feasance, delayed issuance of implementation provisions, absurd craftiness in the hair-splitting drafting of texts.” 5
9. From the “Los von Trient” slogan to the night of bonfires
In 1957 the Central Government in Rome announced a far-reaching council-
housing programme for Bozen/Bolzano, which led South Tyroleans to fear the
arrival of a new wave of immigration from other areas of Italy. “This programme could only be compared with the industrialisation programme that had been announced by the fascists for the Italianisation of South Tyrol”, stated the then President of the
Südtiroler Volkspartei, Silvius Magnago, while his party urged the people to
protest. On November 17 of that same year, 35,000 South Tyroleans, who had
gathered in Sigmundskron/Castelfirmiano for a major rally, demanded the re-
gional autonomy for South Tyrol chanting the slogan “Los von Trient” (away
from Trento).6 Tension amidst the people continued to mount. After a few isolated at-
tacks that had been perpetrated in previous years, riots broke out in the night
between 11 and 12 June 1961, the night of the traditional Sacred Heart Sunday
– when Tyrol commemorates the long freedom struggles against Napoleon’s
troops by lighting symbolic bonfires in the mountains. That night a new fuse
was lit: 37 blasts damaged 37 high-tension power pylons.7
5 Ballardini, R. (1970): Report of the 1st Constitutional Affairs Committee of the Chamber of Deputies, Parliamentary Proceedings, No. 2216–277 A, Camera dei Deputati, Roma, page 2.
6 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser, op. cit, p. 21.7 Baumgartner, E./ Mayr, H./ Mumelter, G. (1992): Feuernacht, Südtirols
Bombenjahre, Edition Raetia, Bozen/Bolzano. Peterlini, H.K. (2005): Südtirols Bombenjahre. Von Blut und Tränen zum Happyend, Edition Raetia.
43
This was the start of those harsh years of violence, with persecutions, ar-
rests and torture against those in prison.8 The Südtiroler Volkspartei, official-
ly distanced itself from the violence perpetrated by extremist terrorists. It was
only after several years that Silvius Magnago, who in the meantime had be-
come President of the Province of Bozen/Bolzano, granted the rehabilitation
of the activists: ”No wonder that South Tyroleans, who realised over the years
that no progress had been made through democratic means, i.e. negotiations,
lost their trust in them.9
The first wave of attacks, perpetrated in 1961, was clearly a form of resist-
ance that arose and developed at the grassroots level. Even though material
damage was extensive, the people who gathered around Sepp Kerschbaumer
did not mean to cause any casualties. However, the Italian police reacted firm-
ly, arresting most of the attackers within a few weeks. Unfortunately, the tor-
ture of South Tyrolean convicts, which later came to light and was made known
to the public during the trials, certainly did not help assuage the hearts and
minds of the people. Sepp Kerschbaumer passed away in prison.
After his death the South Tyrolean movement fell into the hands of other
people. South Tyroleans who gathered around Georg Klotz remained a minor-
ity, while at the same time foreign circles of the extreme right became increas-
ingly influential. Unfortunately many people lost their lives in those years. A
suspicion began to grow that the secret services might be involved in mysteri-
ous activities: conjectures, speculations and half-truths will continue to float
around until the files of the secret services are opened.10
8 Der Mailänder Prozess/Il processo di Milano nelle arringhe della difesa (A collection of pleadings of the counsels of the Southtyrolean defendants in the bomb-attack trials), Casa editrice Europa, Vienna 1969
9 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser Vertrag, op. cit, p. 33.10 Baumgartner, E./ Mayr, H./ Mumelter, G. (1992): Feuernacht, p. 244–270, more
specifically on this refer to Strasser, W. (1967): Österreich und die Vereinten Nationen, Braumüller Wien, pages 370 and 371 and Toscano, M. (1967): Storia diplomatica della questione dell’Alto Adige-Südtirol, Laterza, Bari , page 5. Pages 536–538, 592 and 593.
44
10. The UN order: “Resume negotiations!”
In October 1960 and November 1961, on the initiative of Austria and other
States, the UN General Assembly addressed the issue of Alto Adige – South
Tyrol and the age-old problem of executing the Treaty of Paris. The General As-
sembly urged the parties to resume negotiations to reach a settlement of all
controversies arisen after the Treaty of Paris of 1946.11
In September 1961 Italy set up a Study Committee on the Problems of Alto Adige,
also known as the “Committee of the Nineteen”. At first the Committee’s work and
more generally the negotiations under way between Rome and Vienna dragged
on, but eventually came to a conclusion with the so-called “Package” of meas-
ures for the people of South Tyrol, agreed in Copenhagen by Austrian Foreign
Minister Kurt Waldheim and his Italian opposite number, Aldo Moro, on 30
November 1969. South Tyroleans accepted this compromise only grudgingly,
since it did not totally acknowledge the Treaty of Paris as they had expected.
However the Package was adopted by a narrow majority at an extraordinary
party conference of the Südtiroler Volkspartei held in Meran/Merano, thanks
to the efforts of its historical leader, Magnago, who in the early morning of 23
November 1969 managed to convince a narrow majority of his party.12
The Package was then adopted by the Chamber of Deputies and the Senate
in December 1969, and later by the Nationalrat (Austria’s lower house of par-
liament) in Vienna. The parliaments of the respective countries did not adopt
a set of legislative measures, but the statements of their leaders: i.e. of Italy’s
Prime Minister, Mariano Rumor, and Austria’s chancellor, Josef Klaus, whose
statements contained the above-mentioned measures. A complex schedule of
mutual commitments, both legislative and administrative, the so-called “op-
11 United Nations, Resolutions, No. 1497 (1960) and No. 1661 (1961). The text of the Resolutions is quoted in: Peterlini, O. (2000): Autonomia e tutela delle minoranze nel Trentino-Alto Adige, op. cit., pages 92–95.
12 Magnago, S. (1976): 30 Jahre Pariser Vertrag, op. cit., page 46.
45
erational schedule”, envisaged a guarantee for the gradual implementation of the
Package. Thus a new era began, the era of a new autonomy and its implemen-
tation.
11. The political and legal foundations: the Package and the Statute
The so-called Package containing measures for the people of South Tyrol con-
tains 137 provisions, various clarifications and explanatory notes. It is a politi-
cal commitment to adopting a set of measures for South Tyroleans, which were
to be fulfilled partly by constitutional law, through a reform of the Statute of
Autonomy, and partly by implementing provisions and ordinary laws as well as
administrative provisions. The Package should therefore not be confused with
the Statute of Autonomy, which is only a part of its implementation, albeit the
most important one.
In order to implement the Package, Parliament enacted Constitutional Law
No. 1/1971, that envisaged significant changes and integrations of the Special
Statute of 1948,13 which were later merged into one consolidated text, the new
Statute of Autonomy in its consolidated version.14 The implementation provi-
sions should have been enacted within two years of the entry into force of the
Statute, but in actual fact they took twenty years, until 1992.
The Statute of Autonomy has been given constitutional ranking in the hier-
archy of sources, and, in case of conflict between the two, the Statute of Auton-
omy shall prevail by virtue of its special nature. Its implementation provisions
come immediately under it in the hierarchy of laws, which are in turn followed
by ordinary laws and administrative acts.
13 The reform of the Statute of Autonomy came into force on January 20, 1972, fifteen days after being published in the Official Journale.
14 Presidential Decree of August 31, 1972 No. 670.
46
12. Provinces play a leading role in terms of autonomy
The two autonomous Provinces of Bozen/Bolzano and Trento were given most
of the responsibilities. The Regional Authority is now a sort of framework, be-
cause it has been deprived of a great deal of its original responsibilities. The
first article of the Statute envisages that: “Trentino Alto Adige, comprising the terri-tory of the Provinces of Trento and Bolzano, is established as a regional authority, having legal personality, within the political unity of the Italian Republic, which is one and indivis-ible, in keeping with the principles of the Constitution and pursuant to this Statute”.15
The 2001 constitutional reform overturned this prevalence of the Regional
Authority; on the basis of the subsidiarity principle it pointed out that: “The Trentino South Tyrol Region is made up of the autonomous Provinces of Trento and Bol-zano.” 16
Of the few areas for which the Region still holds responsibility, local au-
thorities (municipalities) and supplementary pension funds are particular-
ly important; the latter is an area where the Region has developed innovative
projects.17
Responsibilities for most other areas have been transferred or devolved to
the autonomous Provinces of Trento and Bozen/Bolzano, which have come to
play a leading role in terms of autonomy, since they are now responsible for
cultural, economic and many other social issues. The Provincial Councils leg-
islate on 90% of matters. Whether it be public works, roads (also state roads),
hospitals or schools, economic incentives in the various sectors or forms of
social support, the salaries of teachers or University funds, the protection of
the environment or the preservation of the historical heritage, sports or leisure
15 Statute of autonomy (updated version – 2010): http://www.regione.taa.it/normativa/statuto_speciale.pdf.
16 Art. 116, paragraph 2, Italian Constitution: http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html.
17 Peterlini, O. (2003): Le nuove pensioni . FrancoAngeli, Milano. Peterlini, O. (2000): Pianificare il futuro, La nuova previdenza complementare in Trentino Alto Adige, Athesia Bozen/Bolzano.
47
time, it is the autonomous Province that takes action and provides funds; more
recently it has also started funding RAI radio and television programmes in
German and Ladin, the postal service and facilities such as prisons, which usu-
ally fall within the Government’s responsibilities.18
In line with fiscal federalism, 90% of funding is raised through the commu-
nity’s tax revenues. There are also provisions to protect language groups, such
as the language proportion provision for civil servant recruitment and employ-
ment in administrative bodies, and, besides the need criterion, to ensure ac-
cess to welfare services and council housing. Italian and German were both
made official languages, the Ladin language is protected in the Ladin valleys
where it is spoken, while tuition is provided by teachers belonging to the lan-
guage groups of pupils.
13. The secession temptation and the road to autonomy
The SVP, which, since its birth in 1945 up until today, has been the biggest party
of South Tyrolean language minorities, pursued the way to autonomy. It never
formally renounced the right to self-determination, but realised that the only
way that goal could be achieved was not through chasing a right that could not
be exercised, but through Realpolitik, epitomized by the historic leader Silvius
Magnago (Party leader of the SVP from 1957 to 1991). However, his decision to
seek autonomy caused strong tensions within the party. The Südtiroler Hei-
matbund, the association of activists who were imprisoned in the 1960s,19 and
the most extremist wing of the party wanted the region to be returned to Aus-
tria. Magnago continued to reply to them that borders can be changed either
18 Peterlini, O. (2010): L’autonomia che cambia, Gli effetti della riforma costituzionale del 2001 sull’autonomia speciale del Trentino Alto Adige Südtirol e le nuove competenze in base alla clausola di maggior favore, Casa editrice Praxis 3 Bozen/Bolzano, pages.145–156.
19 http://www.suedtiroler-freiheitskampf.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=44.
48
with the agreement of both countries or with a war. As it seemed impossible
that Italy would agree to a return of the region to Austria, also considering the
Italian government’s resistance to grant true autonomy over the years, the only
option left was war. And Magnago, added – not without irony – that wars can-
not simply be started – they should be won.
However, the issue of self-determination risked causing a rift in the SVP,
when in 1983 Eva Klotz,20 the first-born of six children of Georg Klotz, an ac-
tivist who had taken part in the 1960s attacks, left the party group within the
Municipal Council of Bozen/Bolzano to run for a seat in the Provincial Council
as a member of the Südtiroler Heimatbund. The “pasionaria” of South Tyrol,
as she was dubbed by the Italian media, felt she had to continue her father’s
work through peaceful and democratic means, pursuing the goal of self-deter-
mination for South Tyrol. She was elected provincial and regional councillor in
1983 and has served as a Councillor for 29 years. In the most recent elections
in 2008, her list, Südtiroler Freiheit, won 14,888 votes (4,9% of the total) and
two council seats. As the Union für Südtirol was a party that Eva herself had
founded (but which she left after a split in 2007), for reasons of political kin-
ship, on top of those 14,888 votes also the 7,048 votes (2.3%) cast for the Union
für Südtirol should be taken into account.
In recent years the party of the Freiheitlichen has begun to emerge as a
competitor to the SVP; in 2008 it won 43,614 votes, or 14.3% and five coun-
cil seats. The Freiheitlichen boast a broader programme that goes beyond the
issue of self-determination; as party leader Pius Leitner recently pointed out,
they pursue a model of Freistaat (Free State) that calls for developing a vision
for the participation also of Italian-speaking people.21 The votes cast for the
three political forces add up to 65,550, accounting for 21.5% and a total of eight
20 http://www.consiglio-bz.org/de/abgeordnete/klotz.asp.21 Speech held on 8.1.2011: http://www.die-freiheitlichen.com/index.php/unsere-
arbeit/reden/3453-3-freiheitliches-dreikoenigstreffen-am-8-jaenner-2011-in-eppan-ansprache-von-lpo-und-l-abg-pius-leitner.
49
council seats (on a total of 35).22 However, the SVP still has an absolute major-
ity with 48.1% of the vote and 18 council seats.
14. If Italy were to lose its democratic character
The SVP’s autonomy policy has not changed. The party has always rejected
the temptations coming from the opposition. Only once, in 1976, in the face
of the impending “communist danger” did SVP Senator Peter Brugger, one of
the noble fathers of the party, threaten: “we shall demand self-determination”
if the Communists rise to power in Italy. In those years, even though the par-
ty’s leader was Enrico Berlinguer who sought contact with Italy’s Catholics, the
Communist party was feared as a threat that would entail a return to Russian
Stalinism. Basically the message was that if Italy lost its character as a liberal
and democratic state, the majority – said Brugger – would vote to return to
Austria.23 Worth mentioning is also a petition, signed in January 2006 by most
mayors (113 out of 116) of Alto Adige, to include the right to self-determination
of South Tyrol in the Austrian Constitution, a goal promoted by part of the Aus-
trian ÖVP, but that turned out to be more an electoral campaign pitch for the
elections to the Nationalrat than a seriously pursued proposal.
15. Magnago prefers to “keep Rome at a distance” rather than be near the League
Relying on its success at the general election of 1996 (30% in Veneto, 25% in
Lombardy), the Lega Nord radicalised its policy: on September 15 it announced
its intention to pursue a secession plan for Italy’s northern regions (the inde-
pendence of Padania – the northern regions around the Po Valley region). With
22 Ferrari, P. (2009): Südtiroler Handbuch, Provincia autonoma di Bozen/Bolzano, Press Office, page 90.
23 Der Spiegel, a German weekly magazine, 11/1976.
50
this goal in mind, he called for a march to be staged on the shores of the Po River
that culminated in a mass rally in Venice. After the well-know judicial events,
the Lega made clear that it was not going to settle for those reforms and decided
to continue its secessionist battle; it founded the Camicie Verdi (green shirts)
and a Government of Padania. After 1997 the secessionist plan suffered a set-
back and lost its popularity, also as a result of the federalization attempts ex-
pressed by the constitutional legislator. On the one hand, the SVP followed It-
aly’s federal development with interest, making its contribution when it could,
both in Parliament and through the Conferences of the presidents of the re-
gions and of regional councils. On the other, however, it was not much involved
in the secession attempts of the Lega Nord. Magnago once said that it was bet-
ter “to be with Rome which is far away” rather than be with Milan which would
be too near.
16. Francesco Cossiga proposes self-determination for South Tyrol
In the previous Parliament, Italy’s former president Francesco Cossiga, in
his capacity as life senator, submitted to the Senate a bill to amend the Consti-
tution to grant the right of self-determination to the “Land Südtirol”. Cossiga re-
introduced his bill to the Senate again in 2008, in this parliament.24
In his report Cossiga recalled the history of “South Tyrol” and its annexa-
tion to Italy after World War I. A great history expert, he gave an account of
how the County of Tyrol had always enjoyed a special status also under Aus-
24 Constitutional draft bill No. 218, initiated by senator Cossiga, submitted to the Office of the Speaker on April 29, 2008. Recognition of the right to self-determination to the “Land Südtyrol” – Autonomous Province of Bozen/Bolzano, Senato della Repubblica XVI. Parliament, the Senate Printing Office (600), Parliamentary proceedings – 2 – Senato della Repubblica.
51
trian rule, recalling the exemption from the war service that Tyroleans enjoyed,
the corps of the Schützen for self-defence as well as the freedom rights the Ty-
roleans enjoyed within the empire. In his report on the bill, Cossiga also criti-
cised the annexation to Italy on the basis of the principles of the Risorgimento:
“Never in the course of Risorgimento did anyone, from Cavour to Cesare Balbo,
from Mazzini to Cattaneo and Garibaldi, think that Tyrol, was to become part
of a future united Italy, except for the Trento region, which, even though it had a
very Italian culture, acquired an “irredentist” awareness only with Cesare Bat-
tisti and with the socialism of Trento”.
In the report on his bill Cossiga also recalled the right to self-determina-
tion:
“The right of peoples to self-determination, enshrined in the declarations
of the United Nations and of the Council of Europe, and which has been the
foundation for the establishment – on the ashes of Yugoslavia – of the inde-
pendent states of Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Mon-
tenegro and Kosovo, cannot be denied to the people of South Tyrol.
Cossiga’s bill envisaged a referendum, in which the citizens of Alto Adige
could choose from a series of options: to stay with Italy, to become a fully inde-
pendent state or to return to Austria or Germany. 25
17. Reactions in Bozen/Bolzano
At first the SVP seemed not to rule out any of the options: “It is a nice surprise that deserves thinking over” said Luis Durnwalder, the President of the Province. Yet
his party chairman, Elmar Pichler Rolle, urged “steady nerve and cool judgement”. “It is a proposal that ignores history” said Gianclaudio Bressa, an MP of the Union
of Prodi elected in Bozen/Bolzano. Also the Democrats of the Left were against
25 Parliamentary proceedings– 5 – Senato della Repubblica – N. 218 XVI PARLIAMENT – BILLS AND REPORTS – DOCUMENTS
52
it: “It’s a brag”. And Cossiga was harshly criticised: “He’s a loose cannon who wrong-foots those who have always added fuel to the fire of self-determination”.26
After the first few comments, Bozen/Bolzano reacted coolly to the proposal,
apart from the enthusiasm shown by Councillor Klotz, quite understandably,
by the Heimatbund and, albeit more moderately, by the Freiheitlichen. The SVP
realised it had no support for its difficult course towards autonomy and against
a split; it was a path it had pursued over the years, during which time it had
worked to allay tensions and find peaceful and consensus solutions. The SVP
also wondered why Cossiga did not bring in his bill when he held the highest
office instead of doing so now as a former president and life senator. Cossiga
was understandably upset when his proposal was not accepted.
Undoubtedly, self-determination remains a right that cannot be renounced,
and belongs to all peoples, but its implementation is neither easy nor obvious.
It is a delicate instrument and – like fire – should not be played with. It
must be kept for times of extreme emergency; in case of an impending danger
such as a regime that violates the rights of linguistic minorities and the prin-
ciples of autonomy. I am not referring to the communists of the old school, of
course, but to those who agree with Senator Peter Brugger, to those who violate
democratic principles also with new forms of a modern popular presidential-
ism. In such case one could count on the solidarity of the international com-
munity and not just Austria’s that could once again raise the issue at the United
Nations. Using it in quiet times, in a Europe that is abolishing borders, would
mean rekindling expectations that are now quite unrealistic and refuelling ten-
sions that were very difficult to overcome. Better to concentrate one’s efforts on
autonomy that is to say on a form of internal self-determination, and revitalize
European and cross-border cooperation.
26 La Repubblica of 25.05.2006, page 12.
53
18. Special autonomy – exceptions to a centralist context
Trentino-South Tyrol is not the only Regional Authority with a special sta-
tus. Since their inception (with Art. 116 of the Constitution) special–status
Regions have addressed special concerns and issues arising for different his-
torical, political and cultural reasons. At first four special-status Regions were
established, then a fifth one was added (in 1963): the two bigger islands Sicily
and Sardinia and the border regions Trentino-South Tyrol, Valle d’Aosta and
Friuli Venezia Giulia, which was the last one to be established in 1963. One of
the reasons for their establishment was the wish to respond concerns about
separatist tendencies that developed after the war on the islands and in the
border regions.
These five Regional Authorities were”given special autonomous conditions, based on special statutes adopted by constitutional laws”, as the wording of Art. 116 of
the Constitution read in its first version. Their far-reaching legislative and ad-
ministrative responsibilities represent a notable exception in Italy’s polity. The
responsibilities conferred upon the special-status Regions and later (with the
new 1972 Statute) on the autonomous provinces of Trento and Bozen/Bolzano
cannot be compared to those of the Austrian Länder (regions), in fact, in some
respects they are even further reaching and entail greater autonomy.
They have a special position in constitutional law and run counter to the
rest of the State structure. However, their special position also gives rise to en-
vy, especially among those who are not familiar with the true reasons for the
special character they have.
The Italian Constitution came into force in 1948, with its principles and safe-
guards for civil, social, economic and political rights; it is predicated on a great
democratic, liberal and social spirit, which undoubtedly makes it one of the
world’s most modern and democratic constitutions. Italy’s polity, instead, was
marked by a clear strand of centralism. Regional authorities were established,
54
but they were not given exclusive responsibilities. The founding fathers of It-
aly’s Constitution were inspired by the wish to strengthen Italy’s unity and to
prevent it from fragmenting again into many smaller states.
The Constitution envisaged municipal, provincial and regional authorities,
not considering them as units making up the State, but rather as its parts. The
few responsibilities conferred upon the Regional authorities, however, have
never been implemented.
While in federal States its internal parts belong to a federal context and
form an organic part of the State, Italy’s special-status Regions are often at
odds with the centralist principles of a State, where they are not the rule, but
the exception.
The many-year long struggle to achieve South Tyrol’s autonomy is an obvi-
ous example of this fiction. Sicily’s special statute was drawn up and became
part of Italy’s legal system as early as in 1946, before the Constitution was
drafted, precisely for separatist reasons, and (at least on paper) it envisages
much further-reaching responsibilities than South Tyrol’s. However, in actu-
al fact, Sicily has enjoyed less leeway and has obtained a degree of autonomy
which, though formally greater, is actually smaller.
19. Federal reform – greater autonomy for all
Since the 1980s and 1990s several attempts have been made in the way of
a federal reorganisation of the State. After a series of unsuccessful events, in
2001 Italy succeeded in carrying through a constitutional reform,27 which did
not turn it into a federal state similar to the US or Austria, Germany and Swit-
zerland, but introduced some key federal principles.
27 Constitutional Law of 18 October 2001, no. 3, which came into force on 8 November 2001.
55
Regional and local authorities are no longer simply a part of the State. They
have become important pillars, which together with the State make up the Repub-lic, as reads the new version of Art. 114 of the Constitution.
Limits have been set to the responsibilities of the State and a new gen-
eral clause in favour of the Regions has been introduced. Municipalities and
Provinces, Metropolitan Cities and Regions have their own statutes, powers
and functions, and have financial autonomy with their own resources and as-
sets. The new fiscal federalism project, which is being developed, will have to
strengthen the financial powers of these authorities and establish a solidarity
fund for the poorest. Other constitutional reforms are being discussed with a
view to reforming the Senate, turning it into a House of the Regions, thereby
ensuring the Regions’ participation in the Parliament’s decision-making proc-
ess.
From a formal point of view, the Statutes of special-status Regions have re-
mained unchanged. The 2001 constitutional reform was not transposed in the
formal text of the Statutes. Yet the reform has changed them significantly, intro-
ducing substantial novelties, which one does not immediately become aware
of when reading the text. Thanks to the so-called “better treatment clause”, the
provisions of the Constitutional reform are directly applied also to special–
status Regions and to the autonomous Provinces of Trento and Bozen/Bolzano
for those areas “for which more extensive autonomous rights and powers are
envisaged than those already conferred” (art. 10 Constitutional Law 3/2001).
Thus, thanks to Italy’s federal development, the autonomous Regions have
obtained more extensive autonomous rights and powers than those conferred
upon them in their respective Statutes.28
28 Peterlini, O. (2010): L’autonomia che cambia, Gli effetti della riforma costituzionale del 2001 sull’autonomia speciale del Trentino Alto Adige Südtirol e le nuove competenze in base alla clausola di maggior favore, published by Casa editrice Praxis 3 Bozen/Bolzano.
56
What were once absolute exceptions within a centralist state, with which
they are at odds; the autonomous Regions are now becoming forerunners of a
new, more federal system.
20. Vision and hope
The degree of autonomy thus achieved certainly does not meet all the demands
of South Tyroleans, but it meets them half-way; it is a compromise which is
also recognised at international level, a model of coexistence of three language
groups that strikes a very delicate balance, which, hopefully, can once and for
all overcome conflicts and prevent future wars. The new 1972 Statute of Auton-
omy is an attempt to ensure the survival of the German and Ladin minorities
with their languages and cultures. Autonomy, however, is also intended to and
must ensure the peaceful coexistence of the three ethnic groups.
The Statute of Autonomy gives the people of Trentino South Tyrol/ Alto
Adige consolidated legislative and administrative autonomy that allows them
to shape their lives according to their needs; it goes to the benefit of all three
language groups – Italians, Germans, and Ladins, as clearly evidenced by eco-
nomic prosperity, low unemployment, the promotion of concessional housing
schemes and other social achievements.
Also the development of a common European home and Austria’s entry in-
to the European Union (since January 1, 1995) are important milestones in that
process. The Brenner border has lost and will continue to lose its importance.
Yet in an ever larger Europe citizens’ democratic participation becomes all the
more difficult. It is therefore right and proper to try to rediscover the Regions
and to create opportunities in small and clearly defined communities where
different people can coexist.
The establishment of a cross-border “Euregio” (the name is still being de-
bated) with the participation of the parts making up historical Tyrol, which was
envisaged for the first time in the coalition programme of Trentino-South Tyrol
57
in 1994, can be a peaceful way to overcome borders and restore to all inhabit-
ants that historical dimension which was taken away from them in 1918.
On February 22, 1995 the Italian Parliament adopted the Agreement be-
tween Austria and Italy on cross-border cooperation of local and regional
communities (Law No. 76/1995). Thanks to that agreement, true cooperation
can be achieved in different areas such as the economic, transport, and com-
munications sectors, energy distribution, environmental protection, the sport,
leisure and culture sectors, as well as health and several social sectors and in
scientific research and applied technology.29 This European Region can serve as a model for overcoming borders and be
a bridge between North and South, as it is based on polymorphism, on linguis-
tic and cultural multiplicity and a history rich in tradition.
The challenge in South Tyrol does not end here. The challenge is to make
all groups feel at home, with none overbearing the others, making diversity a
source of wealth rather than confrontation. We want to be proud of living in
this country, of enjoying a degree of autonomy that can better respond to peo-
ple’s needs, which has clearly borne fruit for everyone; we are proud of speak-
ing more languages and knowing more cultures, of living and anticipating to-
morrow’s Europe and giving young people not only more opportunities to work
in Italy and abroad, but also a broader cultural and professional horizon.
To this end, greater consensus should be achieved among the language
groups on the path to take, and a vision of autonomy should be developed which
all linguistic groups can identify with. The idea is to work for the advancement
of a project for sharing values and common perspectives and against the poli-
29 The European frame work agreement on transboundary cooperation of regional and local authorities, Madrid 1980 and the related agreement between the Italian Republic and the Republic of Austria, Vienna 1993 in: Regione autonoma, Trentino-Alto Adige, la cooperazione transfrontaliera, Proposte per il suo sviluppo, Centro stampa e riproduzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Trento 1993.
tics predicated on confrontation and ethnic division that has always been pur-
sued by right-wing forces.
21. Working for peace
The more a State can set itself up according to the subsidiarity principle, the
more it renounces imposing affiliation while relying on free choice and feder-
alism, the more autonomous and respectful of minorities it is, the more it will
secure its existence as it will prevent conflicts and make border changes un-
necessary.
We therefore hope that mankind can learn a lesson from the bloody wars
of the past, which caused such a great deal of suffering, and that peace will be
strengthened.
It will therefore be our proud boast if our experience with autonomy can
help solve the many and various problems of ethnic minorities in Europe and
in other parts of the world.