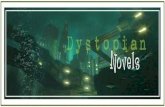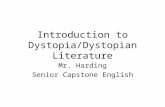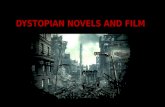Papers, Please - "A dystopian document thriller"
-
Upload
federiconejrotti -
Category
Documents
-
view
261 -
download
0
description
Transcript of Papers, Please - "A dystopian document thriller"

Federico Nejrotti, IIIDAnno scolastico 2013/2014
Papers, Please“A dystopian document thriller”
AbstractLa mia tesina di maturità analizza Papers, Please, un videogioco indipendente pubblicato l’8 Agosto 2013 e vincitore dei BAFTA 2014 (British Academy of Film and Television Arts). Intraprendo l’analisi dell’opera decostruendo il concept dietro a Papers, Please: Lucas Pope, l’autore, infatti si ispira completamente al saggio La Banalità del Male di Hannah Arendt, ponendo, sotto forma di videogioco, la questione del dilemma etico che si presenta davanti alle “pedine” di un regime totalitario (come quello del luogo dove si svolge il videogioco). Passo poi all’analisi di Opinioni di un Clown di Heinrich Boll: sia il romanzo che il videogioco, infatti, condividono la stessa ambientazione storica; Papers, Please si sviluppa infatti attorno alla città di Grestin, al confine tra lo stato di Arstotzka e Kolechia, la quale dopo la “Guerra dei 6 Anni” si è ritrovata divisa a metà, appunto, tra i due Stati. Lucas Pope, con questa scelta, indubbiamente ammicca alla Berlino post-Seconda Guerra Mondiale, trovando dunque un punto di contatto con il romanzo di Boll, il quale descrive proprio il disagio della Bonn post-bellica. Concludo infine con l’analisi della distopia-utopia di Aldous Huxley Il Mondo Nuovo, paragonando l’efficacia della denuncia sociale di Huxley con quella di Papers, Please. Se il romanzo inglese è infatti una distopia atipica, camuffata da utopia, Papers, Please invece non fa sconti e fa vivere il giocatore in una vera e propria distopia comunista.

Mappa concettuale
2

IndicePapers, Please
- “A dystopian document thriller”- Il gioco
o Perché Papers, Please esiste?- Cominciamo una partita
o Come si gioca?o Perché dovrei giocare Papers, Please?
- La banalità del maleo Il dramma dietro i documentio La banalità del male
La banalità del male- “Eichmann a Gerusalemme”
o Il processo di Gerusalemmeo Adolf Eichmann era un essere umanoo Umanizzare il nazismo
Il Mondo Nuovo- “Brave New World”
o Non c’è civiltà senza stabilità socialeo Il lettore nel libro
Opinioni di un clown- “La malinconia è una faccenda seria da morire”
o Perché Opinioni di un clown?o Il protagonista dell’operao Conclusione
3

Riferimenti
LudografiaLucas Pope, Papers, Please, indipendente, 2013
BibliografiaHannah Arendt, La Banalità del Male, Feltrinelli, 1963; capitoli: primo, La Corte; secondo, L’imputato; terzo, Un esperto di questioni ebraiche; quarto, La prima soluzione: espulsione; quinto, La seconda soluzione: concentramento; sesto, La soluzione finale: sterminio; settimo, La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato; ottavo, I doveri di un cittadino ligio alla legge; quindicesimo, Prove e testimonianze; sedicesimo, Epilogo.
Aldous Huxley, Il Mondo Nuovo, Mondadori, 1932
Heinrich Böll, Opinioni di un clown, Mondadori, 1963
Sitografiahttp://theshelternetwork.com/papersplease-ludologia/ (Papers, Please – Ludologia: la banalità del male) – The Shelter
http://theshelternetwork.com/papers-please/ (Papers, Please – giorno dopo giorno) – The Shelter
http://www.rockpapershotgun.com/2013/08/12/wot-i-think-papers-please/ (Papers, Please – Recensione) – Rock, Paper, Shotgun
http://gamasutra.com/view/news/199383/Designing_the_bleak_genius_of_Papers_Please.php (Papers, Please - analisi del processo di game design) - Gamasutra
4

Papers, Please“A dystopian document thriller”
“Il regime comunista di Arstotzka ha concluso la guerra, che perdurava da ormai 6 anni, con il vicino stato di Kolechia e ha occupato la parte che gli spettava di Grestin, una città sul confine tra i due stati. Il tuo lavoro come ispettore all’immigrazione consiste nel controllare il flusso di persone che entrano nel lato Arstotzkiano di Grestin dalla Kolechia. Nascosti tra le mandrie di migranti sono celati mendicanti, spie e terroristi. Utilizzando solamente i documenti posseduti dai viaggiatori e i primitivi strumenti di controllo forniti dal Ministero degli Interni il tuo compito sarà di decidere chi può entrare ad Arstotzka e chi deve essere rimandato indietro o arrestato.”
Papers, Please è un videogioco indipendente ideato, sviluppato e pubblicato da Lucas Pope. Viene messo in vendita l’8 Agosto 2013 e vince i BAFTA 2014 (British Academy of Film and Television Arts) nella categoria “strategia e simulazione”. L’obiettivo di Papers, Please non è intrattenere in senso lato il giocatore ma di metterlo faccia a faccia con sé stesso: in quanto videogioco sviluppato indipendentemente da qualsiasi produttore o editore interessati ad avere un bilancio in attivo, l’autore ha potuto permettersi di lasciare da parte la cura del contenente a favore del contenuto. Ciò non ha però danneggiato in alcun modo il successo del titolo, permettendogli di vendere oltre 500,000 copie solo nel 2013.
5

Ho scelto di voler parlare di questa opera perché, esattamente come per un film d’autore o un quadro da galleria, ciò che ti lascia qualcosa dopo averne usufruito merita di essere discusso. Papers, Please non è divertente né tecnologicamente avanzato: è un gioco crudo, schietto e terribilmente onesto, e rende questa sensazione senza alcuna sparatoria o combattimento epico, ma timbrando e verificando carte e passaporti. La scelta di portare un videogioco come tesina di maturità può sembrare atipica, ma occupandomi di giornalismo e critica sull’argomento da ormai diversi anni ho sentito il bisogno di analizzare e parlare di un’opera di particolare bellezza, analizzandone le caratteristiche al fine di nobilitare un medium che è necessario ottenga la dignità che merita. Il videogioco è un’opera multimediale interattiva, ovvero uno strumento di comunicazione che potenzialmente racchiude al suo interno tutti i media già esistenti e permette a colui che ne usufruisce di interagire con esso, rendendolo così lo strumento didattico in potenza più efficiente finora mai creato.
Il mio approfondimento su Papers, Please va a toccare anche tre importanti opere letterarie. Il lavoro psicologico effettuato da Lucas Pope sul giocatore è infatti una riuscitissima resa in forma videoludica deii concetti espressi da Hannah Arendt ne La Banalità del Male; l’ambientazione è inoltre quella di una dittatura distopica, motivo per il quale ho scelto di parlare di Il Mondo Nuovo di Aldous Huxley, per analizzare l’efficacia della utopia-distopia di Huxley e i mezzi utilizzati per raggiungere questo risultato. Infine, considerato il periodo storico in cui il gioco è ambientato, ho scelto di parlare del mio libro preferito, Opinioni di un Clown di Heinrich Boll.
Papers, Please; Lucas Pope, 2013
6

Papers, PleaseIl gioco
Perché Papers, Please esiste?Un videogioco è una opera multimediale interattiva, ovvero un’opera artistica che racchiude dentro di sé più media e li rende interattivi con il fruitore di essi. Un videogioco è dunque un film del quale puoi decidere la sceneggiatura, la colonna sonora e le location delle riprese in tempo reale e con conseguenze immediate sulla tua esperienza di gioco. Come per qualunque altro tipo di arte ci sono videogiochi più o meno buoni, esattamente come succede per il cinema, i libri, la musica, la pittura o la scultura; ritengo quindi fondamentale, avendo ormai diversi anni di critica sull’argomento alle spalle e gestendo una testata web interamente dedicata a ciò, evidenziare quegli esperimenti validi, che rischiano spesso di essere sommersi da una delle caratteristiche più primordiali del videogioco, ovvero la sua – necessaria – commercializzazione, in quanto il modello classico di videogioco viene concepito avendo come fine la vendita su un mercato.
Papers, Please nasce dalla mente di Lucas Pope, programmatore e game designer che ha già navigato nel mare delle utopie/distopie: degno di nota è The Republia Times, risalente a inizio 2013, dove al giocatore viene assegnata la direzione dell’unica testata giornalistica di uno stato totalitario; lo scopo del gioco è di scegliere i titoli e gli articoli da pubblicare sul quotidiano del giorno successivo affinché il consenso generale per il regime aumenti ed eventuali scandali vengano insabbiati senza generare troppo scalpore per una censura troppo evidente.
Papers, Please appartiene alla categoria dei videogiochi indipendenti, ovvero quei videogiochi per i quali lo sviluppo non è supportato da alcun produttore che fornisca fondi per il progetto. Questo significa che lo sviluppo del titolo ha seguito la direzione artistica del solo Lucas Pope, il quale pur dovendo sacrificare alcuni aspetti tecnici limitati dal budget ristretto, ha potuto dare adito in maniera libera alla sua idea, non dovendo fare i conti con un produttore il cui compito è di far andare in verde il bilancio e dunque, per forza di cose, indirizzato ad uno sviluppo atto a creare un prodotto il più commercializzabile possibile. Ciò ha permesso all’autore di esprimere il medium al meglio delle sue possibilità, sfruttando ciò che la caratteristica fondamentale del videogioco, l’interattività, permette.
Il medium del videogioco va rivalutato per un motivo estremamente pratico: all’interno di quella che tecnicamente può essere chiamata un’opera multimediale interattiva troviamo, appunto, una multimedialità interattiva. Il videogioco è la combinazione del concetto di libro, film e musica elevati all’ennesima potenza e interlacciati tra loro in maniera talmente efficace da risultare malleabili dall’indole del giocatore, che può dunque adattare la loro presenza in base alle proprie esigenze di apprendimento. Che si parli infatti di nozioni più o meno culturalmente importanti, un videogioco è tanto più riuscito quanto più è giocabile, ovvero sensibile ai differenti tipi di approcci che ogni giocatore può intraprendere nei suoi confronti.
7

Papers, PleaseCominciamo una partita
Come si gioca?Possiamo fare tutta la filosofia e le riflessioni di questo mondo su un videogioco, ma a conti fatti il gioco nasce per intrattenere. Qualunque gioco basa il proprio intrattenimento su un concetto chiamato feedback, ovvero la risposta che il gioco restituisce al giocatore in base alle sue azioni: maggiore è l’efficacia del feedback più il gioco intratterrà. Papers, Please ti fa vestire i panni di un ispettore di frontiera: il tuo compito sarà quello di controllare i documenti degli immigranti, verificare eventuali discrepanze coi protocolli che il governo ti fornisce e, nel caso fosse necessario, ordinare l’arresto di eventuali soggetti pericolosi. Il feedback ci giunge alla fine di ogni giornata di lavoro, quando il gioco conterà il numero di documenti controllati correttamente, ti pagherà di conseguenza ed infine ti metterà davanti il tuo bilancio famigliare dove luce, gas e affitto saranno da pagare.
I comandi di gioco sono piuttosto basilari, ma sono anche inizialmente impostati in modo da risultare scomodi – intendo proprio scomodi da utilizzare con le mani -. Questo perché superando le varie giornate di gioco verrà offerta al giocatore la possibilità di acquistare classici potenziamenti per la propria postazione di lavoro che renderanno questi comandi meno scomodi. In questa maniera il giocatore sarà costantemente posto davanti alla stuzzicante idea di spendere i preziosi soldi guadagnati in strumenti che potenzialmente potrebbero rendere il lavoro più veloce (e quindi più redditizio) il giorno successivo.
Lucas Pope vince i BAFTA 2014 nella categoria “strategia e simulazione”
8

Perché dovrei giocare Papers, Please?Il cuore pulsante del titolo di Lucas Pope batte proprio nel finale di ogni giornata. Il feedback che ci viene restituito da ogni partita (e quindi da ogni giornata di lavoro) rimane efficace nel corso del tempo perché la difficoltà nel controllo dei documenti degli immigrati aumenta di giorno in giorno, a braccetto con la degenerazione della situazione politica di Arstotzka che deve fare i conti con un riassestamento post-bellico. I primi giorni di lavoro saranno tranquilli, ma cosa succede quando dopo una manciata di partite il gioco ti mette faccia a faccia con il fatto che il lavoro che hai appena svolto non basta a pagare il riscaldamento?
È in questo momento che Papers, Please subisce un’improvvisa svolta e cambia il piano del proprio intrattenimento. Se prima infatti il giocatore, non minacciato da alcun tipo di game over aveva come unico obiettivo il guadagnare quanti più soldi possibili, ora che la curva di difficoltà ha subito una brusca impennata il game over è possibile: il giocatore intraprende quindi un duello contro la struttura di gioco nel quale dovrà trovare un modo per evitare la sconfitta, ovvero per riuscire a guadagnare sempre quanto basta per poter soddisfare il bilancio famigliare. Lucas Pope non ha fatto grandi studi per risalire ad una meccanica di gioco così efficace; gli è bastato chiedersi quale sia il game over nella vita reale di tutti i giorni e riproporlo in maniera così crudelmente schietta.
Quando deve parlare del messaggio che vuole trasmettere, Papers, Please non fa troppi giri di parole; è un’opera infatti che parla sempre in modo chiaro al suo giocatore: se non hai i soldi per pagare il riscaldamento dormi al freddo, e se si dorme al freddo spesso capita un altro evento drammaticamente ovvio. Ci si ammala. È qui che Papers, Please prende una piega inaspettata e ti intrattiene non più divertendoti ma facendoti correre nella maratona dei dilemmi etici, perché se il mio lavoro non basta a salvare i miei due figli dal freddo allora sì, domani mi siederò alla mio ufficio immigrazione e se qualcuno tenterà di corrompermi non opporrò troppa resistenza; d’altronde quanto fastidio può dare un clandestino se una sua mazzetta permette di salvare mio figlio dalla polmonite?
Certamente poco. È comprensibile pensare di accettare il peso della corruzione se il prezzo da pagare, altrimenti, sarebbe quello del funerale della propria prole; ma cosa può avvenire nella nostra testa se quel clandestino, mazzetta consegnata, facesse due passi oltre il confine e si facesse esplodere in mezzo ad una folla? Qui Papers, Please mi ha colto impreparato. Di videogiochi ne ho finiti tanti, alcuni più leggeri, altri molto più impegnati, ma nessuno come il titolo di Lucas Pope mi aveva mai mandato, effettivamente, in crisi. Mi occupo di videogiochi da ormai davvero tanto tempo e doversi interfacciare con questo tipo di opere per doverne poi scrivere ti permette di sviluppare un occhio critico capace di individuare subito le qualità reali di un videogioco: le meccaniche attraverso le quali Pope obbliga il giocatore a prendere una decisione etica sono studiate nei minimi dettagli per generare quanta più pressione psicologica possibile. Una volta presentatosi un clandestino al controllo documenti ci sono pochi secondi per decidere se accogliere il tentativo di corruzione rischiando di mettere a repentaglio delle vite che, seppur virtuali, sono innocenti o se seguire le direttive dei protocolli governativi e condannare una persona apparentemente onesta e disgraziatamente disperata. Lo stato di Arstotzka non è però impassibile davanti al tuo cedere alla corruzione: il governo si accorgerà dell’ingresso dei clandestini e ti ammonirà una, due, tre volte, fino a diminuirti lo stipendio e a minacciare il licenziamento. Papers, Please è stato per me difficile da giocare, perché ogni partita diventava un tiro alla fune tra giustizia e necessità.
9

Papers, PleaseLa banalità del male
Il dramma dietro i documentiL’obiettivo che si prefigge Lucas Pope non è semplice. Un’opera d’arte funziona quando riesce a trasmettere qualcosa e per riuscire a comprendere perché Papers, Please sia un ottimo videogioco bisogna analizzare in che modo riesce a trasmettere il proprio messaggio. Come già detto ci troviamo davanti ad un titolo il quale non fa della componente tecnologica il suo cavallo di battaglia. L’autore è quindi costretto a sfruttare uno stile grafico privo di dettagli appariscenti: una carta che Lucas Pope si gioca così bene da riuscire a camuffare una necessità tecnica dovuta dal bisogno di spendere il minor tempo e budget possibile su questo aspetto del gioco con una trovata che può fornire una ulteriore chiave di lettura. Infatti, benché lo sforzo grafico sia minimo, la scelta di dipingere un mondo privo di colori sgargianti non è scontata, ma, assieme all’assenza di qualsivoglia colonna sonora caratteristica appesantisce ancora di più i toni della distopica dittatura in cui il gioco si svolge. Tutti questi piccoli stratagemmi di design permettono all’autore di truffare il giocatore, facendogli sottovalutare, inizialmente, le potenzialità di coinvolgimento del gioco e scoprendo le carte in tavola solamente quando questi trucchetti hanno già sortito l’effetto necessario sul giocatore.
Papers, Please; Lucas Pope, 2013
Ma mettiamoci per un attimo nei panni del giocatore di Papers, Please: dopo poche ore di gioco ti stai annoiando perché timbrare documenti non è così divertente e hai moglie e figli virtuali più di là che di qua; nonostante ciò ti senti in dovere di andare avanti, perlomeno per vedere dove si andrà a finire – e anche perché in Papers, Please il suicidio non è contemplato -. Il ripetersi delle giornate e la monotonia delle azioni da svolgere nel gioco spezzano il legame tra la persona e il lavoro: ti alzi al mattino non più per verificare i documenti di immigranti alla frontiera di una nazione in piena crisi ma per arrivare a fine giornata; i protocolli di sicurezza si inaspriscono, la polizia ti obbliga a denunciare infrazioni inesistenti al solo scopo di metterne di più in manette, misteriose sette terroristiche ti promettono ricompense in cambio di qualche falso in atto pubblico.
10

La banalità del maleA te di tutto questo, degli immigrati, dei clandestini, del governo, della tua nazione, non importa poi tanto: l’importante è arrivare a fine giornata, avere il proprio bilancio in attivo, farsi corrompere quel tanto che basta per evitare che tua moglie passi all’altro mondo. Sei una vittima del sistema, parrebbe.
Parrebbe, certo, perché il grande merito di Papers, Please è di mettere in mano al giocatore gli strumenti del carnefice. Il gioco non ti obbliga a seguire alcun tipo di percorso: la drammaticità risiede nel fatto che in ogni momento si è liberi di rifiutare di piegarsi alle angherie del sistema; si è liberi di dire di no alla corruzione rifiutando le mazzette o negare il controllo al governo ignorando documenti contraffatti. Ma è davvero possibile farlo?
Hannah Arendt, La banalità del male, 1963
Papers, Please coglie ispirazione a piene mani dall’opera socio-politica di Hannah Arendt La Banalità del Male, dove la giornalista racconta per conto del New Yorker il processo ad Adolf Eichmann tenutosi a Gerusalemme, dopo il quale il gerarca nazista verrà condannato a morte per “aver spietatamente perseguito lo sterminio degli ebrei”. La premessa necessaria a questo discorso riguarda il fatto che io non avevo idea di chi fosse Hannah Arendt, né tantomeno Adolf Eichmann, prima di giocare a Papers, Please. È importante puntualizzare questo fatto perché, nel corso della lettura del saggio, la mia attenzione è stata costantemente focalizzata sul ritratto di Eichmann dipinto dalla Arendt, fino a rendermi conto, infine, che quel gerarca nazista già lo conoscevo: Adolf Eichmann ero io mentre giocavo a Papers, Please quando la mia etica e la mia morale venivano distorte dalla necessità di dare da mangiare ai miei figli e di sopravvivere ad un regime a cui non potevo fare altro se non sottomettermi coscientemente. Adolf Eichmann ero io quando perdevo contatto con la realtà perché, paradossalmente, un videogioco mi gettava nel più reale dei drammi: quello della vita di tutti i giorni estremizzato fino a rendere quasi invisibile la sottile linea tra bene e male. Adolf Eichmann ero io quando commettevo la peggiore delle malvagità rendendomi padrone della libertà altrui, e lo facevo coperto da una drammatica aura di banalità, perché non riuscivo e non potevo guardare oltre la punta del mio naso.
Papers, Please non è un videogioco in cui si viene dis-umanizzati, al contrario: Papers, Please risulta non solo un videogioco, ma un vero e proprio capolavoro, perché riesce nell’impresa di intrattenere chiedendo al giocatore di essere drammaticamente umano, annebbiando la sua morale per lasciare posto ad un banale istinto di sopravvivenza.
11

La Banalità del Male“Eichmann a Gerusalemme”
Adolf Eichmann, responsabile dell’RSHA – ufficio centrale per la sicurezza del Reich – e uno tra i principali responsabili della Shoah, non fu un uomo particolarmente fortunato: nel Giugno 1948, dopo essere sfuggito al Processo di Norimberga, si rende conto che il nazismo non fa più per lui e con l’aiuto del vicario di Bressanone fugge in Argentina grazie ad un passaporto falso con il nome di Riccardo Klement. In Argentina va tutto benone, ma la pacchia finisce in fretta: purtroppo il nostro eroico latitante, il quale oltre che incappare nel brutto incidente del Terzo Reich era incappato anche nel tragico incidente di dare i natali ad un figlio, viene incastrato proprio dal suo più diretto consanguineo.
Nel 1957 il figlio di Eichmann si innamora di una ragazza tedesca; disgraziatamente succede che quella ragazza tedesca fosse figlia di un ebreo ceco sfuggito all’Olocausto, e succede che il figlio di Eichmann si faccia scappare con lei il vero cognome del padre . Il padre della ragazza, dopo aver sentito che la figlia si frequentava con un figuro oberato dal peso di un cognome del genere, si insospettisce e, immaginando un qualche collegamento tra il compagno della figlia e il gerarca nazista, riferisce la questione al Mossad. I Servizi Segreti Israeliani non sono esattamente annoverati nella lista di “intelligence che prendono le cose alla leggera”, così nel 1960 fanno un salto a Buenos Aires e privano senza troppi complimenti Adolf Eichmann della sua condizione di latitante.
12

Il Processo di GerusalemmeUn anno dopo, nel 1961, si svolgerà il Processo di Gerusalemme, nel quale Eichmann, nel 1962, verrà condannato a morte per aver spietatamente perseguito lo sterminio degli ebrei. Non è un caso che abbia riassunto la vicenda in maniera leggera e a tratti ironica, non è un caso che provi quasi compassione per questo gerarca nazista che nel tentativo di fuggire e di lasciarsi tutto il male che aveva fatto alla spalle, viene incastrato proprio dal figlio, il quale per qualche scherzo del destino decide di innamorarsi proprio della figlia di un ebreo sfuggito all’Olocausto. Il saggio di Hannah Arendt ha proprio questa intenzione: di ridare dignità ad un uomo che non ne aveva più. Perché la filosofa ha voluto questo? Perché, lei stessa ebrea, ha voluto in qualche modo prendere le parti di un operatore della Shoah e mettere in risalto l’ipocrisia generale che si respirava in quel tribunale di Gerusalemme?
Hannah Arendt nasce nel 1906 a Linden, in Germania. Nel 1933 essendo ebrea, dopo una breve incarcerazione, è costretta a lasciare la Germania e a emigrare negli Stati Uniti, dove otterrà la cittadinanza solo nel 1951. Allieva di Heidegger, lavora principalmente come giornalista e nella sua carriera si distingue redigendo numerosi articoli che la porteranno a guadagnare il titolo di “filosofa politica”: suoi cavalli di battaglia sono infatti le numerose analisi riguardanti i concetti di potere, totalitarismo, autorità e politica. Viene inviata dal New Yorker come corrispondente per il Processo di Gerusalemme, reportage che si trasformerà poi, nel 1963, nel saggio ‘Eichmann in Jerusalem – A Report on the Banality of Evil’.
‘La Banalità del Male’ è un monito. È un grido di aiuto, un disperato SOS per ricordare a tutto il mondo che i nazisti erano esseri umani. Nell’empatia che la Arendt trasmette delineando il ritratto di un Eichmann seduto al banco degli imputati confuso, stanco, sincero e soprattutto demolito dall’aria che (comprensibilmente) si respirava in quel tribunale, si cela la richiesta di non dimenticare che Adolf Eichmann non era un superuomo, un Übermensch, ma era un essere umano semplice e terribilmente normale – in una delle lettere inviate durante la stesura del rapporto sul Processo di Gerusalemme, la Arendt definisce il crimine di Eichmann “stinknormal”, “di una normalità assoluta” -.
La colpa che viene descritta nel saggio non è quella dei crimini nazisti, ma bensì quella di aver reso colpevoli di quei crimini non degli uomini ma degli alieni. Il lavoro fatto da Hannah Arendt nella stesura dell’opera è estremamente raffinato perché, allo scopo di far arrivare al lettore questo monito, si è adoperata nel contrappore una descrizione dettagliata dell’antefatto nazista ad un disperato appello morale, fatto citando in maniera apparentemente sterile numerose testimonianze pronunciate durante il processo. Il ‘male’ del saggio delle Arendt è un concetto privo di radici, che non è innato ma viene bensì innestato, per vie traverse, nell’imputato, il quale diventa una pedina perfetta. I gerarchi nazisti sono operatori del Reich, perfettamente consapevoli delle loro azioni ma volontariamente ignari delle conseguenze di esse. Perché? Questo tipo di messaggio è veicolato con efficacia, a mio parere, disarmante proprio da Papers, Please, dove vestiamo i panni di un operatore di una dittatura comunista, cosciente che il proprio lavoro determini la vita o la morte di altre persone potenzialmente innocenti, ma forzato a ignorare le conseguenze delle proprie decisioni perché obbligato a dare priorità alla propria sopravvivenza. Adolf Eichmann è completamente colpevole dei reati da lui commessi, ma si può leggere tra le righe del saggio un’accusa, riguardante l’eguale colpevolezza di chi non ha voluto trattare Eichmann come un essere umano, a chi quel Processo di Gerusalemme l’ha presieduto.
Adolf Eichmann era un essere umano13

La Arendt si preoccupa di sottolineare di come il Pubblico Ministero, nella fasi iniziali del processo, si fosse preoccupato di chiedere a tutti i testimoni in che modo un genocidio di quella portata potesse essere stato possibile. La risposta è riassunta da una dichiarazione di David Rousset, scrittore e attivista politico francese: “Il trionfo delle SS esige che la vittima torturata si lasci condurre dove si vuole senza protestare, che rinunzi a lottare e si abbandoni fino a perdere completamente la coscienza della propria personalità. […]”.
Questa citazione viene, poche pagine dopo, contrapposta ad una accurata analisi dell’atteggiamento dei giudici nei confronti di Eichmann: “Questo comportamento – ndC: poca precisione nei racconti dei fatti, errori, ricordi distorti - di Eichmann creò notevole imbarazzo al processo: non tanto per lui, quanto per coloro che lo dovevano processare, difendere, giudicare e per i giornalisti. Eppure era essenziale che qualcuno lo prendesse sul serio; ma la cosa era tutt’altro che facile.”
La cattura di Eichmann, ci racconta la Arendt, generò un clima di vera e propria euforia a Gerusalemme: si stava per svolgere il primo processo contro i crimini nazisti dello stato di Israele; l’euforia non riguardava il processo, ma la condanna. Eichmann era un “dead man walking”, un morto che cammina sin dall’istante immediatamente successivo alla sua cattura da parte del Mossad. I giudici e l’intero apparato legislativo israeliano erano (giustamente) certi che quei crimini fossero stati commessi da lui e che l’unico modo per espiare le sue colpe fosse condannare a morte questo imponente angelo della morte; la condanna di Eichmann avrebbe trascinato con sé tutto il restante anti-semitismo rimasto: il problema era che Eichmann era tragicamente normale, non era un angelo della morte. Non poteva essere psicologicamente instabile, perché non si potevano uccidere tutti quegli ebrei se non attraverso un pensiero lucido e ragionato; ma allo stesso tempo non poteva essere normale, anzi “era visto come un buffone” per le sua incoerenza nell’agire, dichiarando al Procuratore, ancora prima di essere accusato di colpe che non aveva (effettivamente) commesso, che la peggior cosa che avrebbe potuto fare sarebbe stato negare le sue colpe per poi implorare pietà; senonché la primissima istanza di grazia che fu richiesta, in prossimità dell’esecuzione, fu scritta proprio da Eichmann.
Hannah Arendt nel 1969
Umanizzare il nazismo
14

Il dramma che si è consumato nel 1961 a Gerusalemme riguarda il fatto che durante quel processo la normalità non corrispondeva all’umanità, e ciò significava perdere di vista che quello stesso male fatto da Eichmann poteva risultare lecito per qualunque altra persona non normale, ovvero per qualunque altro essere umano che non corrispondesse ai canoni di normalità della procura Israeliana – che per la cronaca, secondo quanto raccontato dalla Arendt, sembra corrispondessero più ai canoni di un manuale, che a quelli di una persona dotata di cervello sensibile alle emozioni -.
Eichmann forniva testimonianze confuse, lacunose e spesso tragicamente egocentriche. Quando fu analizzata la questione riguardante il collaborazionismo ebraico durante le prime “emigrazioni” dalla Germania, Eichmann, benché, secondo le sue stesse parole, “voleva aiutare gli ebrei a fondare un loro Stato”, faticava vistosamente a ricordarsi nomi che non fossero quelli di ebrei che ebbe sotto il suo diretto controllo. Eichmann descriveva nei minimi dettagli tutte le circostanze riguardanti i suoi avanzamenti di grado, ma brancolava nel buio quando gli si chiedeva di parlare di eventi dalla portata storica ben più rilevante. In definitiva Eichmann forniva al tribunale di Gerusalemme la testimonianza di un uomo normale , le cui priorità non coincidevano con “soluzione finale” ma con “carriera”, e per questo riferiva ai Procuratori solamente ciò che si ricordava, ovvero ciò che riguardava la sua carriera.
Hannah Arendt condanna Eichmann ed è d’accordo con la scelta della pena di morte per lui, e sebbene io sia perfettamente conscio del fatto che potrei aver in qualche modo frainteso il significato intrinseco dell’analisi filosofica della Arendt riguardo “la banalità del male”, non ho alcun dubbio nel dire che se un’introspettiva di un criminale nazista doveva farmi riflettere, beh allora quest’opera si è comportata in maniera egregia non solo facendomi pensare, ma avendo un vero e proprio effetto dirompente sul mio modo di vedere questioni così “umanamente” lontane da me.
Il tribunale di Gerusalemme non riusciva a capacitarsi del fatto che Adolf Eichmann fosse, tutto sommato, una persona normale. Una persona normale che è stata capace di mandare a morire una quantità tale di persone. Questo fattore non era previsto dalla (comprensibile) euforia dello stato di Israele, ed è fondamentale comprendere e accettare che i gerarchi nazisti erano persone normali, persone che ancor prima di “soluzione finale” si svegliavano al mattino pensando, banalmente, alla loro carriera. La paura che pervade l’intera opera non è tanto quella che possa ritornare il nazismo, piuttosto quella che si possa ignorare un nuovo nazismo, perché quando arriverà il momento di fare di nuovo i conti con un totalitarismo del genere, noi saremmo troppo occupati a ricordarci di quanto anormali ed irripetibili i nazisti fossero. Ciò che personalmente ho evinto dall’analisi di Hannah Arendt sul processo Eichmann riguarda il fatto che il nazismo non deve spaventare per ciò che è stato, ma per ciò che potrebbe di nuovo essere data la natura “stinknormal” dei suoi operatori: il nazismo era tutt’altro che disumano, ed è proprio questo che dovrebbe far gelare il sangue.
Hannah Arendt era un essere umano.Adolf Eichmann era un essere umano.
Il male è disperatamente umano.Il male è tragicamente banale.
15

Il Mondo Nuovo“Brave New World.”
Aldous Huxley nasce nel 1894 a Goldaming, in Inghilterra, si laurea ad Oxford e non lo ricordiamo come una persona che si potrebbe normalmente definire “un tipo a posto”. Trascorre la sua infanzia tormentato da numerosi lutti famigliari causati dal cancro e non appena iniziati gli studi patisce una grave malattia che lo porterà alla semi-cecità. Grazie a questo provvidenziale imprevisto evita l’arruolamento per la Prima Guerra Mondiale e finisce per diventare insegnante di George Orwell. Tra il 1934 e il 1937 compie una serie di viaggi nel Centro America, dove riesce a curare la propria malattia alla cornea. Nel frattempo comincia a praticare la meditazione, diventa vegetariano e predica i piaceri delle sostanze psicoattive nel suo saggio “Le porte della percezione”. Scopre infatti il magico mondo della mescalina, esperienza che lo accompagnerà fino al suo capezzale, dove come ultimo desiderio chiederà di ricevere 100 microgrammi di LSD intramuscolari. Nel 1955 la moglie muore di cancro al seno, il nostro amico Aldous non si scoraggia ed un anno dopo si sposa con una torinese; nel 1960 riceve la diagnosi di un cancro alla laringe, che porta la sua vista a peggiorare di nuovo.
Nonostante tutti i drammi di natura medica che vive nella sua vita, l’opera magna dell’autore inglese, appunto Il Mondo Nuovo, nascerà allo scopo di fungere da monito contro la corsa al progresso scientifico che si verificava in quegli anni. Negli anni successivi al cancro alla faringe Huxley, però, comincia la scrittura della sua opera L’Isola, all’interno della quale predicherà le meraviglie del potenziale umano. Aldous Huxley, in definitiva, per quanto autore dal titanico talento e maestria contenutistica, risulta un soggetto piuttosto instabile.
16

Non c’è civiltà senza stabilità socialeIl Mondo Nuovo (Brave New World) viene scritto nel 1932 ed è il romanzo che inaugura il genere distopico nel ‘900. Aldous Huxley in quest’opera anticipa temi tipici di questo secolo come l’eugenetica, il controllo della riproduzione ed in generale le tecniche atte al condizionamento della società. Ne Il Mondo Nuovo ci viene proposta una distopia atipica, perché camuffata da perfetta utopia: siamo nel 1940 quando la devastante guerra dei Nove Anni cambia radicalmente la storia e il mondo viene riunito in un unico Stato governato da dieci “Coordinatori Mondiali”. Dio viene abolito, la cultura abolita, il sapere limitato a favore dell’unico Salvatore Henry Ford e al modello di produzione del suo leggendario “Modello T”, datato 1908. Il Mondo Nuovo, infatti, è ambientato nell’anno Ford 632, ovvero nel 2540, e tutto il mondo ha plasmato le proprie strutture di pensiero a favore del modello di produzione in serie.
Le strutture della società sono già prefabbricate, pianificate a tavolino grazie a dei controlli eugenitici effettuati all’inizio della vita di ciascun individuo. Non parlo di “nascita” perché nel mondo di Huxley la gravidanza è un abominazione superflua e i feti vengono fatti sviluppare in vitro, per poi essere condizionati alla classe sociale richiesta dal “piano del Mondo”. Il Mondo Nuovo è una realtà votata al piacere personale e dove ogni primaria necessità dell’essere umano viene soddisfatta affinché il livello di malcontento sia ridotto al minimo; siamo alla California Medical School di San Francisco quando Huxley, nel 1961, durante un discorso tenuto agli studenti pronuncia queste parole: “ci sarà in una delle prossime generazioni un metodo farmacologico per far amare alle persone la loro condizione di servi e quindi produrre dittature, come dire, senza lacrime; una sorta di campo di concentramento indolore per intere società in cui le persone saranno private di fatto delle loro libertà, ma ne saranno piuttosto felici”. Il Mondo Nuovo è la concretizzazione letteraria di questa affermazione.
Ciò che Il Mondo Nuovo lascia realmente al lettore sono sensazioni. Huxley divide esattamente a metà l’opera, raccontando in una prima parte le bellezze e le stranezze di questo “Mondo Nuovo” e facendo subentrare, nella seconda, un agente estraneo a questo Mondo. Ci viene raccontato infatti che una regione del Nuovo Messico non è stata “civilizzata” per ragioni economiche, e che rimane dunque una bolla appartenente alla società pre-moderna, dove la vita scorre esattamente come prima dell’avvento di Ford: in questa situazione viene introdotto il personaggio di John il Selvaggio, figlio di Linda, donna che, una volta abitante del Mondo Nuovo, si perde durante un viaggio nel Nuovo Messico e lì partorisce John. Huxley mischia i due mondi quando fa portare Il Selvaggio nel Mondo Nuovo; la reazione del pre-moderno è ovvia: non comprende. È proprio a questo punto che la distopia di Huxley diventa concreta e tangibile sul lettore.
17

Il lettore nel libroL’autore dissemina per tutto il corso del romanzo numerosi episodi che suggeriscono come, per quanto apparentemente paradisiaca, la vita che i personaggi trascorrono è artificiale e pilotata. Il Mondo Nuovo è un complesso intrecciarsi di momenti che presentano la duplice faccia della medaglia dell’opera di Huxley: la sottile linea che divide l’ovvietà dell’intento di denuncia di una realtà distopica e la, paradossalmente altrettanto ovvia, situazione di utopia dove tutti i bisogni primari dell’uomo sono soddisfatti è squisitamente sottile. I personaggi che si fanno portavoce delle opinioni dell’autore nel corso della storia sono molteplici e soprattutto si rendono tali nelle situazioni più diverse, creando una miscela di retorica e narrativa che, a mio parere, risulta oltremodo efficace per trasmettere il messaggio de Il Mondo Nuovo.
Il collegamento tra il romanzo di Huxley e Papers, Please non è dunque riconducibile ad un banale parallelismo tra le due distopie, ma si trova ad un livello più profondo . Per quanto nell’opera di Lucas Pope la realtà sia molto più chiara – niente infatti tenta di farci credere che il giocatore non stia vivendo in un totalitarismo di stampo comunista -, l’opera di costruzione di un credibile antefatto storico ai fatti che si vivono giocando, rende l’insieme decisamente più coinvolgente. Ritengo infatti che l’efficacia nel raccontare una distopia non si trovi tanto nella crudezza dei metodi descritti o nell’accuratezza usata per parlare delle iniquità di essa, bensì nella capacità dell’autore di mettere a suo agio il lettore, di coinvolgerlo con grazia per poi fargli improvvisamente crollare il mondo addosso, obbligandolo ad una presa di coscienza determinante e repentina e che lo pone nell’unica condizione permessa da un’ambiente distopico: il lettore entra nel libro e, banalmente, prova una grande sensazione di impotenza.
Huxley non rappresenta in maniera plateale il lettore nel libro: non lo fa entrare in scena fin da subito né tantomeno lo “coccola” assegnandoli un qualche particolare intreccio narrativo, ma ne Il Mondo Nuovo lo ignora fino a metà dell’opera e quando lo tira fuori rimane comunque relegato nella sfera dei caratteri marginali, oscurati da altri personaggi narrativamente molto più d’impatto. La distopia di Huxley è estremamente subdola anche nell’evoluzione della trama: l’autore infatti crea una crescendo costante fatto di continue prese di coscienza nei confronti delle contraddizioni e delle limitazioni della libertà umana imposte dalla “società di Ford”, ma infine abbatte brutalmente questa rinnovata speranza di liberazione generatasi nel lettore – per altro con una di dimensione narrativa, a mio parere, titanica – facendolo rassegnare alla dura e terribile realtà che ha incontrato per tutta la durata dell’opera.
In definitiva ritengo “Il Mondo Nuovo” una dimostrazione di efficacia narrativa impressionante: il trionfo di una storia rifinita a tal punto da risultare, finalmente, veramente alienante e non banalizzata dal ripetersi dei temi delle solite distopie; un’opera che rifiuta di colpire il lettore allo stomaco e lo sorprende invece subdolamente alle spalle.
18

Opinioni di un clown“La malinconia è una faccenda seria da morire.”
Heinrich Boll nasce a Colonia il 21 Dicembre del 1917, cresce in Germania nel pieno dell’avvento nazista ma rifiuta di iscriversi alla Gioventù Hitleriana; anziché vestirsi di svastiche preferisce studiare, arriva all’immatricolazione per l’Università di Colonia ma nel 1939 è strappato dalle sudate carte per essere mandato al fronte. Dal 1949 in poi la carriera letteraria di Boll sarà un costante crescendo che culminerà, infine, nella vincita del premio Nobel per la Letteratura nel 1972. Il protagonista principale dei suoi romanzi è la denuncia sociale contro il nazismo prima e la guerra fredda poi.
Nel 1963 pubblica Opinioni di un clown (Ansichten Eines Clowns), un romanzo ambientato nel secondo dopo-guerra e che critica in maniera decisa l’ipocrisia di una borghesia tedesca orfana di un forte credo nazionalista e ora abbandonata alla mercé delle potenze che sarebbero poi state protagoniste della Guerra Fredda.
La verità è che Opinioni di un clown ha ben poco a che spartire con Papers, Please a livello pratico. L’unico ovvio punto di contatto è infatti proprio l’ambientazione: l’opera di Boll si svolge infatti interamente a Bonn, mentre il videogioco di Lucas Pope si sviluppa a Grestin, divisa in Grestin Est e Ovest dopo la “Guerra dei Sei Anni”; visto e considerato che il nostro lavoro alla frontiera si svolgerà a Grestin Est e proprio quella sarà la parte della città appartenente alla dittatura comunista di Arstotzka, l’occhiolino alla Berlino dell’Unione Sovietica è pressoché lapalissiano.
19

Perché Opinioni di un clown?Benché il romanzo metta a fuoco molto di più i frangenti psicologici del protagonista piuttosto che quelli degli altri personaggi, l’atmosfera che si respira racconta perfettamente l’involontaria ipocrisia borghese della Germania Ovest. Anche in Papers, Please i riferimenti ad un antefatto di questo tipo non mancheranno, e anche se sicuramente l’opera di Pope non trae diretta ispirazione da quella di Boll, la comprensione delle ragioni politico-sociali di Opinioni di un clown permette di capire meglio numerosi aspetti del gioco, che altrimenti risulterebbero stridenti con il resto dell’ambientazione.
Opinioni di un clown permette di evidenziare un contrasto piuttosto evidente tra Germania Est ed Ovest: se entrambe erano accomunate da una banalissima tristezza per il loro status politico, il modo di mostrare questo sentimento differisce fortemente tra le due. Parliamo di reazioni diverse ad uno stesso problema.
Opinioni di un clown è un romanzo che segue le vicende di Hans Schnier, un clown di Bonn, e del collasso tragicamente perfetto della sua vita. Hans ci racconta un antefatto composto da una carriera piuttosto rosea ma che inevitabilmente precipita dopo i suoi primi problemi con l’alcolismo e arriva, poche pagine dall’inizio del libro, a parlare del vero protagonista dell’opera: Maria, la donna che lo ha abbandonato per apparenti discrepanze religiose tra lui – si evince pratichi una qualche forma di agnosticismo – e la famiglia di lei – ferventi cattolici -. Heinrich Boll evidentemente se la doveva essere vista brutta con qualche donna in particolare, nella sua vita, perché per tutta la durata del romanzo tenta disperatamente di mettere in primo piano la denuncia sociale contro una Germania che è stata forzatamente sradicata dal credo del nazismo e ora scaraventata in un contesto internazionale che non le poteva (ancora) appartenere, ma semplicemente non ci riesce.
Opinioni di un clown è un romanzo che parla di una donna, Maria, e dell’impossibilità di accettare che quella donna possa essersi allontanata dalla vita dell’uomo che ci racconta la vicenda. A mio parere Heinrich Boll riesce nell’incredibile impresa di trovare in Hans Schnier l’eroe romantico-decadente originale: privato infatti di un contesto affine alla sua indole estranea all’ambiente tedesco di quel periodo, Hans Schnier è un clown, una voce fuori dal coro che non solo non viene compresa dai restanti personaggi del romanzo, ma viene anzi nascostamente derisa. Posizionato in questo ecosistema, Heinrich Boll si appropria di un personaggio che è giustificato a fare qualunque cosa perché intrappolato in un limbo contemplabile solamente da lui e incomprensibile a chiunque altro.
Hans Schnier è un personaggio fatto di sentenze e lamenti, è un personaggio che, quasi a riflesso dell’autore, tenta continuamente di “cambiare discorso”: la critica sociale è chiara, evidente, spudorata e spesso spietatamente accurata, ma non è mai abbastanza per poter permettere davvero al lettore e al narratore di dimenticarsi di Maria, la vera protagonista e destinataria di ogni singola parola dell’opera. Opinioni di un clown è un costante crescendo, una corsa disperata verso questo orizzonte, verso Maria, un orizzonte che Hans non vuole raggiungere e che schiva preoccupandosi in misure sempre diverse della “borghesia ipocrita”, ma soprattutto è un orizzonte che non può raggiungere, perché Maria è definitivamente fuori dalla vita di Hans per quanto la negazione di ciò da parte del protagonista sia presente nell’intera opera.
20

Il protagonista dell’operaPosso quindi tagliare qui la retorica sulla tragica bellezza della descrizione di questo amore disperato e tentare di ridare dignità ad un’opera che finora, per come ne ho parlato, ha di che spartire qualcosa solamente con un romanzo Harmony. Heinrich Boll, esattamente come Dante maschera senza nemmeno troppi sforzi mimetici la teologia dietro il personaggio di Beatrice, scrive un romanzo che parla di arte.
La visione del protagonista è quella dell’arte circense, certo, ma Boll stila un trattato generale che non si occupa di arte, ma dell’arte in quanto fine da inseguire: insomma, non ci vuole parlare di quadri ma dei quadri in potenza. Perché dunque Maria è l’arte? Per spiegare ciò mi sento di citare interamente un passo dal libro; la parte veramente importante corrisponde solamente all’ultimo paragrafo – ironicamente, le ultime due misere righe -, ma una lettura integrale dell’estratto permette di comprendere appieno l’intensità della corsa disperata di Hans verso l’orizzonte di Maria.
"L'impazienza, l'irritazione dietro la grata del confessionale: quell'interminabile scambio di sussurri sull'amore, matrimonio, dovere, amore e infine la domanda: "Neppure dubbi sulla fede; ma allora che cosa le manca, figliola?". Tu non puoi dirlo, non riesci nemmeno a pensarlo quello che io so. Un clown ti manca, definizione ufficiale: attore comico, non iscritto nei registri di nessuna chiesa.
Dal balcone mi diressi zoppicando verso il bagno per truccarmi. Era stato un errore stare davanti a mio padre senza trucco, ma davvero la sua visita era l'ultima cosa che mi sarei potuto aspettare. Leo ci aveva sempre tenuto tanto a sapere la mia vera opinione, vedere il mio vero volto, conoscere il mio vero io. Lo avrebbe visto. Quando non ero truccato aveva sempre paura delle mie finzioni, degli scherzi, delle mie "maschere", di quello che egli chiamava il mio "non far sul serio".
21

La mia valigetta del trucco era ancora in viaggio fra Bochum e Bonn. Quando in bagno aprii il bianco armadietto a muro, era ormai troppo tardi. Avrei dovuto pensarci, avrei dovuto sapere quale mortale sentimentalismo si nasconde negli oggetti. I tubetti e i barattoli, le bottigliette e le matite di Maria: nell'armadio non c'era più nulla di tutto questo e questo non esserci assolutamente più niente di lei in modo così totale, definitivo era altrettanto terribile come se avessi trovato ancora un tubetto o un barattolo di crema. Tutto via, sparito. Forse Monica Silvs era stata tanto misericordiosa e aveva impacchettato e fatto sparire ogni cosa. Mi guardai nello specchio: i miei occhi erano completamente vuoti, per la prima volta non avevo bisogno di fissarmi allo specchio per una mezz'ora e fare ginnastica facciale per svuotarli. Era il volto di un suicida e quando cominciai a truccarmi il mio volto era il volto di un morto.
Mi spalmai la faccia di vaselina e spezzai un vecchio tubo di biacca mezzo secco, ne spremetti fuori tutto quello che c'era ancora dentro e mi stesi la biacca su tutta la faccia: non un solo segno nero, non un punto rosso, tutto bianco, anche le sopracciglia ricoperte di bianco; accanto a tutto quel bianco i capelli sembravano una parrucca, la bocca pulita, era scura, quasi bluastra, gli occhi azzurri come un cielo di pietra, vuoti come quelli di un cardinale che non vuole confessare neppure a se stesso di aver già perso la fede da molto tempo. Non avevo neanche paura di me stesso. Con questa faccia potevo fare carriera, potevo persino accingermi a fare dell'ipocrisia sulla cosa che nella sua miseria, nella sua stupidità mi era ancora la più simpatica: la cosa nella quale Edgar Wieneken credeva. Questa almeno avrebbe avuto un cattivo sapore, nella sua volgarità era la più onesta fra le cose disoneste, il più piccolo fra i mali minori.
Dunque oltre al nero, al marrone scuro e all'azzurro esisteva ancora un'alternativa che sarebbe stato troppo eufemistico e anche troppo ottimistico chiamare rosso: era un grigio con un lieve, lontano riflesso di aurora. Un colore triste per una cosa triste, in cui forse c'era posto persino per un clown che si era reso colpevole della più grave colpa per un clown: suscitare pietà. Il guaio era soltanto questo: Edgar era l'uomo che meno di chiunque altro avrei potuto imbrogliare, a lui meno che a chiunque altro avrei potuto dare a intendere qualcosa. Ero l'unico testimone che lui avesse veramente corso i cento metri in 10"1 e lui era uno di quei pochi che mi avevano sempre preso così com'era, al quale mi ero sempre mostrato così com'ero. E non possedeva altra fede che quella in alcune persone; gli altri in senso astratto, in qualcosa come lo Stato, la Germania. Edgar no. Per lui era stato già abbastanza duro quella volta, quando avevo preso quel tassì. Adesso mi dispiaceva, avrei dovuto spiegarglielo, a nessun altro al mondo avrei dovuto una spiegazione, ma a lui sì.
Mi allontanai dallo specchio, mi piaceva fin troppo quello che ci vedevo, non pensai neppure per un momento che ero io quello che vedevo. Quello non era più un clown, era un morto che recitava la parte di un morto. Avevo voglia di piangere: la biacca sul viso me lo impediva, era così perfetta con quelle crepe, con quei punti in cui il gesso cominciava a sfogliarsi; le lacrime avrebbero rovinato tutto.
Tutti sanno, cioè, che un clown dev'essere malinconico per essere un buon clown,
ma che per lui la malinconia sia una faccenda seria da morire, fin lì non arrivano."
22

È qui la dichiarazione della chiave di lettura dell’intera opera. Heinrich Boll crede – e io con lui – che l’arte sia possibile solo in presenza di malinconia, perché è questa che permette all’artista di sfiorare ancora per un disperato istante quella bellezza di cui è stato una volta partecipe e di poterla quindi, in qualche modo, riproporre nel suo operato. Hans Schnier dipende dalla malinconia per poter svolgere al meglio il suo lavoro di clown, perché è solo attraverso di essa che può risultare credibile.
Boll riflette quindi, in fase di stesura, su quale sia il modo migliore per poter parlare in maniera efficace di un concetto così astratto come la malinconia, e trova la più ovvia quanto geniale delle risposte: l’unica malinconia di cui tutti possono essere veramente partecipi è quella per l’amore, ed è così che con una spiazzante nonchalance Heinrich Boll schiva qualunque tipo di complicato intreccio etico-morale e colpisce il lettore allo stomaco, facendogli provare malinconia non per la Maria di Hans, ma bensì malinconia per quella sensazione di dolore tragicamente perfetto che Boll fa vivere in Hans Schnier.
ConclusioneIo non so bene cosa cinque anni di Liceo Classico mi abbiano insegnato; non so se mi abbiano insegnato ad ignorare le interpretazioni “da manuale” e a rileggere con una chiave di lettura personale le opere di cui faccio esperienza. Non ho idea, e onestamente non ho nemmeno interesse a scoprire, se queste interpretazioni siano in qualche modo corrette. So però che se cinque anni di Liceo Classico mi hanno insegnato a interpretare l’arte con un occhio così personale da renderle abbastanza mie da permettermi di portarmele dietro per tutto il resto della mia vita, allora questi cinque anni di Liceo Classico sono valsi a qualcosa.
La mia tesina tratta di un videogioco, di un saggio su un processo, di un’utopia distopica e di un romanzo sentimentale, ma quello che spero abbia trasmesso riguarda l’adattabilità didattica di un prodotto artistico e la mia forte e inamovibile convinzione che un’opera d’arte valida non sia quella che può insegnare di più, ma bensì quella abbastanza umile e di conseguenza riuscita da adattarsi a colui che ne fa esperienza per potergli trasmettere quanti più concetti possibile.
Io non credo in uno studio a misura di arte, ma in un’arte a misura di studio.
Federico Nejrotti2 Luglio 2014, Torino
23