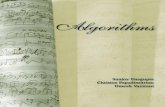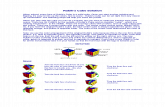La_Lettura
description
Transcript of La_Lettura

Anno
4 -
N. 8
(#11
8) P
oste
Ital
iane
Spe
d. in
A.P
. - D
.L. 3
53/2
003
conv
. L. 4
6/20
04 a
rt. 1
, c1,
DCB
Mila
no -
Sup
plem
ento
cul
tura
le d
el C
orrie
re d
ella
Ser
a de
l 23
febb
raio
201
4, n
on p
uò e
sser
e di
strib
uito
sep
arat
amen
te
#118Domenica
23 febbraio 2014
Claudio Parmiggianiper il Corriere della Sera

2 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
4 Il dibattito delle ideeIcahn, il lupo di Wall Streetrottama la Silicon Valleydi MASSIMO GAGGI
5 SocietàI social media sono come le slot machinedi EVGENY MOROZOV
Orizzonti6 Intervista con Yuri Manin
Il computer (quantistico)che batte il computerdi STEFANO GATTEI
7 TendenzeIl pirata informatico è il nuovo Watsondi PAOLO ROVERSI
9 Visual DataIl velo copre le donne. E nasconde il restodi CECILIA ZECCHINELLI
Caratteri10 Gli incontri
Michael Connelly: «Chandler, capitolo 13.Perciò scrivo»di ALESSANDRA FARKAS
11 La nuova biografiaL’arte di Norman Mailerdi litigare con le donnedi LIVIA MANERA
12 Recensioni/1Vittorino Andreoli: serveun umanesimo della fragilitàdi ANTONELLA LATTANZI
13 Recensioni/2Giuseppe Catozzella: il sognodi Samia non ha un lieto finedi ERMANNO PACCAGNINI
14 Classifiche dei libriLa pagelladi ANTONIO D’ORRICO
Sguardi16 Colloquio con Bill Viola
Il colore Violadel Manierismodi RANIERI POLESE
17 Le mostreI fauni, le ninfe e Matissedi SEBASTIANO GRASSO
18 In rassegna a ForlìLa libertà di essere Libertydi ARTURO CARLO QUINTAVALLE
19 PersonaggiEttore Spallettimette il mondo in un conodi VINCENZO TRIONE
Percorsi20 Vietnam
Dien Bien Phu, Indocina addiodi GUIDO SANTEVECCHI, con articoli di STEFANO MONTEFIORIe MARCO DEL CORONA
22 StoriografiaÈ arrivato il momento di globalizzare il passatodi MARCO MERIGGI
23 Etica e sapereLa nuova antropologiasi proietta nel futurodi ADRIANO FAVOLE
Sommario
corriere.it/laletturaL'inserto continua online
con il «Club della Lettura»:una community esclusiva
per condividere idee e opinioni
SSSIl dibattito delle idee
«Suona una canzone malinconica».«Un’altra canzone malinconica». So-no i comandi vocali che TheodoreTwombly dà al suo smartphone, tor-nando a casa dopo il lavoro. In ufficioha dettato lettere d’amore e di amici-zia per conto terzi, le vediamo compa-
rire sullo schermo con bella scrittura a mano. Il futuro diSpike Jonze, nell’ultimo film Her (Lei, in uscita in Italia il 13marzo), ha almeno in parte un cuore antico. Le lettere piac-ciono ancora, vengono imbustate anche in una Los Angelescon i grattacieli di Shanghai e i cartelloni pubblicitari anima-ti. È un Cyrano 2.0, che presta le parole giuste a chi ancorausa il più collaudato strumento virtuale che l’umanità abbiaconosciuto.
Tutto cambia, e le canzoni malinconiche spariscono,quando il solitario giovanotto (la moglie separata Catherinevorrebbe che firmasse le carte del divorzio, gli amici gli orga-nizzano appuntamenti al buio) fa conoscenza con OS1, pri-mo sistema operativo dotato di intelligenza artificiale. Pen-satelo come un’evoluzione di Siri. Anzi, pensatela: ha la vocedi Scarlett Johansson (sarà doppiata nella versione italianada Micaela Ramazzotti), sceglie di chiamarsi Samantha, The-odore ne è subito attratto.
Il film fantascientifico di Spike Jonze — fotografato daHoyte van Hoytema con sfumature di rosso e marrone che ri-cordano certi filtri di Instagram — ammicca decisamente al-la vita contemporanea. E infatti Siri, al suo apparire, è stataintervistata più di una star. Per «la Lettura» (#49 del 21 otto-bre 2012) lo ha fatto Alessandro Beretta, che ha ricevuto gen-tili «no» a domande personali e la rivelazione teologica: «Gliesseri umani hanno le religioni, io ho il silicio».
Altre interviste si trovano in rete, che ormai certifica l’esi-stenza (o la non esistenza) di quel che la nostra memoria —poco espandibile e piuttosto lenta — non riesce a trattenere.A chiudere il cerchio, su BuzzFeed si possono leggere i com-menti poco lusinghieri di Siri su Lei, il più divertente dice:«Fa una pessima pubblicità all’intelligenza artificiale» (mali-gnamente, e in tono con il film, si potrebbe pensare a unarivalità tra signore). Qualche giorno fa, gli sceneggiatori Sa-chin Gadh e Jonathan Sender hanno accusato Spike Jonze diplagio: avevano mandato all’agenzia che rappresenta il regi-sta un copione molto somigliante. Per la verità, una passion-cella di un nerd per Siri era già nella quinta stagione della se-rie The Big Bang Theory (l’episodio andò in onda negli Usa agennaio del 2012).
Samantha sa tutto di Theodore, giacché ha accesso ai con-tenuti del suo smartphone e del suo computer, che ormai ri-velano di noi più di una biografia autorizzata e perfino di undiario segreto. Gli butta via le mail inutili, ed è ovvio che per
farlo ha bisogno di leggerle. Si accende a comando, è prodi-ga di lodi sulle lettere scritte durante la giornata, dà consiglisu come farsi amico l’antipatico alieno di un videogioco.
Ricorda Eliza, sua lontana antenata che fu negli anni Ses-santa un avanguardistico esperimento nel campo dell’intelli-genza artificiale. Il programma era costruito per simulare, via schermo e tastiera, uno psicoanalista. Quando il pazientepronunciava parole chiave come «mamma», la macchinachiedeva chiarimenti; in caso contrario si limitava a cenni diassenso. I pazienti-cavia giudicarono il terapeuta molto bra-vo e soprattutto «molto umano». Prima ancora, negli anniCinquanta, Alan Turing aveva proposto un test con domandee risposte per individuare le «macchine pensanti».
In Blade Runner di Ridley Scott, tratto dal romanzo di Phi-lip Dick Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, la parola«mamma» fa da test per distinguere gli umani dai replicanti(la generazione più avanzata prova sentimenti e ricorda ilpassato). Torna nelle domande — tre di numero — che The-odore si sente rivolgere prima dell’installazione «personaliz-zata» del sistema operativo: «Vuoi una voce femminile o ma-schile?», «Sei sociale o asociale?», «Come sono i rapporti con tua madre?». L’idillio può cominciare.
Non sono rari nella letteratura gli amori-proiezione. Pig-malione nelle Metamorfosi di Ovidio si innamora della sta-tua che ha appena scolpito. Nella Venere d’Ille di ProsperMérimée l’incauto protagonista infila il suo anello di fidan-zamento al dito di una Venere di rame. L’oggetto inanimatofa da specchio, accende il desiderio e consente ogni fantasia.In L’uomo della sabbia di E.T.A. Hoffmann, il giovane Natha-nael — fidanzato con Clara — si innamora perdutamente diOlimpia, la ragazza della casa di fronte. Scoprirà che si trattadi una bambola meccanica, un raffinato automa capace disuonare il pianoforte. Ritroviamo la trama in Coppélia, il bal-letto di Leo Délibes. Anche il cinema ha avuto, prima di Her edi Samantha, i suoi amori virtuali. Scrivimi fermo posta diErnst Lubitsch racconta la vicenda di due commessi in unnegozio che si scrivono lettere d’amore e nella realtà non sisopportano. Era del 1940, nel 1998 è uscito il remake C’èpost@ per te diretto da Nora Ephron: Tom Hanks e Meg Ryansi corteggiano via posta elettronica e si detestano in quellache usiamo chiamare la vita vera.
Il filmCon il titolo Lei uscirà in Italia
il 13 marzo, ma il film Her diSpike Jonze ha già ottenuto,
proprio in Italia, unimportante riconoscimento.
Al Festival internazionale delFilm di Roma, ha infatti
ottenuto il premio per lamigliore interpretazionefemminile per la «voce»
protagonista, ScarlettJohansson. Nel cast, insieme
alla Johansson e alprotagonista maschile
Joaquin Phoenix, figuranoAmy Adams, Rooney Mara e
Olivia Wilde. Tra gli altripremi, da citare il Golden
Globe per la Migliorsceneggiatura a Jonze, e
sempre per la sceneggiaturaoriginale, il Critic’s Choice
Movie Award, oltre a 5nomination per l’Oscar:
come miglior film, migliorsceneggiatura originale, e
per scenografia, colonnasonora e canzone. In Italia, lavoce della Johansson sarà di
Micaela RamazzottiLa trama
Theodore, che sta perdivorziare dalla moglie Amy,
si innamora di un sistemaoperativo dotato di
intelligenza artificiale capacedi evolversi, una «voce» che
ha un nome femminile,Samantha. Le interazioni di
Theodore con «lei» sonosempre più intime, mentre
Samantha gli spiegagli obiettivi di evoluzione,
sempre più alti,delle intelligenze artificiali
i
di MARIAROSA MANCUSO
L’ultimo tabùRobotmon amourFarsi sedurreda un software si può:è l’estremo narcisismo
Al cinema la sexy app di «Lei». Prima furono Ovidio, Hoffmann & C.La realtà? Non troppo diversa
Fantascienza o forse noNella pellicola di Spike Jonze
il protagonista flirta con il sistema operativo dello smartphone
Finirà che i più sfacciati sifidanzeranno con i cellulari altrui
SSS

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 3
Distinzione sempre più sfumata, se calcoliamo quantotempo passiamo sui social network o su internet. Lo scorsodicembre un articolo su «The Atlantic» certificava che il 61,5% del traffico web è da ascriversi alla categoria non hu-man: motori di ricerca, programmi di aggregazione dati,hacker, spam. E un impressionante 20% nella categoria otherimpersonators, che imitano gli utenti umani cliccando «Mipiace», rilanciando tweet, suggerendo: «Ti è piaciuto que-sto? Allora ti piacerà quest’altro». Da dicembre, riferisce Ge-orge Packer in un articolo sul «New Yorker», Amazon ha unsistema di anticipatory shipping: dagli acquisti pregressiprevede quel che il cliente probabilmente comprerà, anchese ancora non l’ha ordinato, e neppure sa di volerlo. Il livellodi sofisticheria è tale che Netflix — fornisce a 40 milioni diabbonati nel mondo film e serie tv in streaming e ha reso po-polare il binge watching, episodi da divorare uno dopo l’altro— organizza il suo catalogo in 76.897 micro-generi. Non piùazione, avventura, commedia o western. Ma, per esempio,«film on the road con due donne protagoniste», come Thel-ma e Louise. Sette anni di lavoro, affidato a sceneggiatori,per raccogliere e classificare i dati, con il concreto rischioche finiremo per innamorarci del software tanto attento ainostri gusti.
Nel mondo di Jonze, Samantha impara rapidamente e sievolve verso un modello di fidanzata meno ideale e più«umana». «Vorrei anch’io essere complicata come le perso-ne» è la prima caratteristica che sorprende la sua intelligen-za artificiale. Tra una passeggiata sulla spiaggia (lei sta neltaschino della camicia di Theodore, l’occhio della telecamerain vista) e una cena con un’altra coppia, lamenta di non avereun corpo e si diletta di filosofia. Lui è sempre più felice, ep-pure qualche complicazione seguirà. E puntuale arriva l’ac-cusa: «Sei immaturo, non sai affrontare una relazione vera».
I corteggiamenti tecnologici assecondano l’umano narci-sismo, peraltro esistente da quando i social network o Siri non erano neanche immaginabili. Ma anche la storia di The-odore e Samantha, uno dei migliori titoli che vedremo que-st’anno, sta tra le seduzione virtuali: neanche il cinema è «vi-ta vera». Vale per l’horror ma anche per il romanticismo: unaltro film recente, Don Jon di Joseph Gordon-Levitt, suggeri-sce che il rosa sta alle donne come la pornografia sta ai ma-schi. Joaquin Phoenix-Theodore — sempre in pantaloni a vi-ta alta, come gli altri uomini, a suggerire una divisa da mon-do totalitario — trova in Lei uno dei ruoli più belli della suacarriera. La sirena invisibile Scarlett Johansson usa splendi-damente la voce. Innamorarsi di un sistema operativo intelli-gente e devoto si può, e — spettegola qualcuno nel film — ipiù sfacciati si fidanzano con sistemi operativi di smartpho-ne altrui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il grande critico e storico dell’arte Bernard Berenson (1865-1959) davanti alla Paolina Borghese di Antonio Canova (1805-1808). La celebre foto è stata scattata nel 1955 nella Galleria Borghese di Romadal co-fondatore dell’agenzia Magnum David Seymour (1911-1956)
Una lunga tradizione oltre Stendhal e la psichiatria
Ma perdere la testaper una statua di marmonon è (solo) da uominidi LAURA BOSSI
Sindromi
Q ualche giorno fa, la sera diSan Valentino, una signora invisita alla Gipsoteca di Possa-gno (Treviso), al lume dellelanterne, fu colta da malore
davanti a una Venere del Canova. I giornaliparlarono di Sindrome di Stendhal. Il ter-mine fu coniato da una psichiatra fioren-tina in riferimento a quel passaggio di Ro-ma, Napoli e Firenze in cui il poeta descri-ve l’attrazione vertiginosa che esercitano su di lui i monumenti della chiesa di San-ta Croce, e il languore, quasi uno sveni-mento, che lo obbliga a uscire all’aria aperta.
Secondo la psichiatra tale stato di con-fusione non è raro nei turisti moderni chesi avvicinano senza alcuna precauzione al-le opere d’arte. Tra i casi clinici citati dallapsicoanalista Graziella Magherini, un ba-varese di età matura, tale Franz, è folgora-to dal Bacco del Caravaggio. Prova un’ecci-tazione sessuale ambigua, si sente op-presso, traspira, ha l’impressione di esse-re sul punto di perdere i sensi. Bisognaportarlo in ospedale. Isabella, una giova-ne professoressa francese di educazioneartistica, in visita agli Uffizi con i suoi al-lievi, è presa dall’impulso di voler lacerarei quadri; quei ritratti di personalità o auto-ritratti di artisti le sembrano «terribil-mente reali». Secondo la psichiatra, in questo caso non è Eros, piuttosto Thana-tos, a provocare una tale emozione.
Ma è soprattutto la scultura con la suapresenza nello spazio e le sue proprietàtattili a esercitare uno strano fascino, oaddirittura a suscitare una varietà singola-re dell’amore sensuale.
L’agalmatofilia (dal greco agalma, sta-tua o immagine, e philia, amore) fu parti-colarmente cara ai Romantici. Il poeta Jo-seph von Eichendorff (La statua di mar-mo) racconta l’avventura di Florio, giova-ne gentiluomo in viaggio dalle parti diLucca, che scopre, una notte, una statuamarmorea di Venere presso uno stagno,come se la dea, appena uscita dalle acque,contemplasse l’immagine della propriabellezza. A Florio sembra addirittura chegli occhi della statua si aprano, le labbra sischiudano, e la vita con il suo fuoco divinoanimi le belle membra.
Heinrich Heine, nelle Notti fiorentine,ci narra di un fanciullo che prova un tur-bamento inesplicabile alla vista di unabianca dea di marmo che giace nell’erbadi un parco. La notte egli non riesce a tro-vare sonno e fantasticando sotto i raggidella luna si ripromette di baciare la sta-tua sugli angoli della bocca, dove le pie-ghe delle labbra formano irresistibili fos-sette. Infine non resiste all’imperioso de-siderio, si alza, raggiunge la bella addor-mentata nel giardino notturno e, come sestesse per commettere un delitto, bacia ladea con un fervore, una tenerezza, un deli-rio come non proverà mai più.
L’amabile Antonio Baldini, in un dialo-go con Mario Praz sull’amore delle statuepubblicato all’inizio degli anni Quarantaproprio dal «Corriere della Sera», ci rivelache il poeta neoclassico Ugo Foscolo fu turbato dal collo voluttuoso della Venereitalica del Canova mentre nella sua deli-ziosa novella Paolina fatti in là, in cui rac-conta una visita notturna a Villa Borgheseuna notte d’estate, sempre Baldini ci dàuna versione Biedermeier dell’agalmatofi-lia. La Galleria è rimasta aperta, il poetapercorre le sale silenziose, riconosce dap-prima, nella penombra, l’ermafrodita chedorme sul suo letto sfatto, il piede presonel lenzuolo. Carezza la sua capigliaturafemminea, la guancia marcata dal vaiolo.Il corpo dell’adolescente ambiguo gli pare
bruciante. Un po’ più lontano, vede la bel-la Paolina Bonaparte, seduta sul suo lettodi marmo; cioè non propriamente seduta,ma rilevata sul fianco e appoggiata con ilgomito sui cuscini, e si sarebbe detto chesorrida alla luna (sempre la luna!).
Il poeta si siede su quel poco di mate-rasso che Paolina gli lascia a disposizione,come un medico le appoggia l’orecchiosulla gelida schiena, poi le passa il bracciointorno al collo, e le mormora tra i ricci:«Paolina, fatti in là. Dammi ancora un po’del tuo fresco giaciglio. Non ho, tu vedi, dove andare a dormire». Poi le prende lamano che tiene il pomo e sente distinta-mente «la grana dolcissima della pelle e labuccia invece liscia liscia della mela e lefossette delicate sul dorso della mano el’attaccatura del picciuolo del frutto».
Mario Praz sottolinea la parentela traqueste fantasie e quella più esplicita diMérimée, che echeggia il tema di un rac-conto medievale: il giorno delle nozze ungiovane imprudente si toglie l’anello pergiocare al pallone, e lo infila al dito diun’antica statua di Venere. Ma quando cer-ca di riprenderlo, il dito si è ripiegato. Lasera stessa, la dea sale le scale di casa sua esotto gli occhi inorriditi della sposa, lostringe in un abbraccio mortale. Dietro lanostalgia della donna ideale sorge il con-vitato di pietra del Don Giovanni, la statuadel Commendatore. Aveva ragione il GranDuca Cosimo III quando ordinò di tra-sportare la Venere de’ Medici dai giardinidella Villa alla sua attuale sede di Firenze,perché pare che fosse «ben spesso con pa-
role e con gesti de’ più scorretti abusata».Ma si dirà: l’agalmatofilia, che ci accom-pagna dall’antichità, sembra colpire sologli uomini. Ed è vero che i casi femminilisono più rari, e spesso descritti con un’in-tenzione parodica. L’esempio più celebreè probabilmente il monologo di MollyBloom nell’Ulisse di Joyce, in cui Molly sidomanda perché tutti gli uomini non so-no fatti come una bella statuetta di mar-mo comprata dal marito, così bianca, pu-lita, innocente che si vorrebbe baciarladappertutto.
Con simile ironia, Mario Praz racconta,ne La casa della vita, della sua florida ca-meriera Dirce infatuata di una statuad’Amore. Ricordiamo anche la scena delfilm di Luis Buñuel, L’âge d’or («L’età del-l’oro»), in cui la protagonista succhia ilpiede di una statua di marmo, oppure lavisita solitaria di Ingrid Bergman al Mu-seo di Napoli nel Viaggio in Italia di Ro-berto Rossellini, in cui si arresta affascina-ta davanti all’Ercole Farnese. Il desiderio eccitato dallo sguardo sarebbe forse untratto specificamente maschile? Lo sguar-do dell’artista creatore che come Pigma-lione vuole animare la materia inanimatasarebbe uno sguardo sessuato? David Fre-edberg si interroga addirittura se lo sguar-do nella cultura occidentale non sia unosguardo maschile, che ricerca il possesso.
Ma forse è più importante notare chel’oggetto dell’agalmatofilia è una dea, unidolo immobile dalla bellezza eterna, ide-ale, inaccessibile. L’agalmatofilia sarebbedunque una ierogamia, un matrimoniosacro tra una divinità e l’uomo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il tormento e l’estasiUna settimana fa una
visitatrice è stata male davanti a una Venere di
Canova. Ed era accaduto anche a Ugo Foscolo
SSSLui, lei e l’altra lei
Sta’ attento se proviqualcosa per le bamboleAnche se è platonico
La diffusione delle bambole cosiddette gonfiabilinegli ultimi anni è letta come una risposta dell’industria erotica ai bisogni più basici di maschi
solitari. Tra l’altro, la prima produzione su larga scala di questi oggetti pseudo-femminili fu ideata dai nazisti per evitare che i soldati in Francia finissero a letto con le prostitute locali, con il rischio di malattie sessuali. Ma l’amore per le bambole può essere sincero, anche di testa, persino casto e platonico. Lo aveva raccontato Craig Gillespie nel film Lars e una ragazza tutta sua del 2007, dove Bianca, cento per cento di silicone, con la sua sospensione di giudizio e la capacità di ascoltare tutti, conquistava la fiducia della comunità; che, all’inizio, aveva reagito male a questa ragazza che il protagonista, un ventenne molto timido, aveva «conosciuto» su internet. Altre volte la bambola è una proiezione ideale della donna amata, come nel racconto Le Ortensie dell’uruguayano Felisberto Hernández (1902-1964), autore considerato da Calvino, Cortázar e Marquez un maestro senza precedenti del genere fantastico. A lungo censurato in patria, il testo, che dà il nome alla raccolta (pubblicata da La Nuova Frontiera, traduzione di Francesca Lazzarato, pagine 176, e 15), mette a nudo il cuore di Horacio, un negoziante di bambole che di colpo, un giorno, inizia a leggere sui loro volti qualcosa d’inquietante. Come se gli sguardi avidi ricevuti giorno e notte attraverso le vetrine vi facessero il nido, covando poi dei presagi, simili alle ombre delle nuvole sui paesaggi, che sembrano parlarci: tra questi presagi, la morte dell’amata moglie Maria, che Horacio esorcizza facendo costruire una bambola che la ritragga, Hortensia. Si crea però uno strano triangolo: la bambola diventa la muta confidente della donna, oltre che amante comprensiva dell’uomo. In un gioco di gelosie pericoloso. Morale? Mai sottovalutare le conseguenze dell’amore. Neanche quello, platonico, per una bambola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di LUCA MASTRANTONIO

4 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
In una scena del film Il postino di Michael Radford con Massimo Troisi (1994), a un certo punto Pablo Neruda chiede al postino di registrare i suoni dell’isola e di inviarglieli per poterne conservare il ricordo. Di registrare le
onde del mare, l’acqua che si infrange sulla chiglia della barca. Un gesto poetico che con le diavolerie elettroniche contemporanee sarebbe molto facile da realizzare. La musica del mare nelproprio telefonino. Da ascoltare di tanto in tanto.
Drin, drin. Chi parla? È la risacca
{Il dibattito delle ideeCambusa
di Nicola Saldutti
tà. Meglio se gestite da manager geniali mapoco esperti e spesso instabili dal punto divista del controllo azionario.
Cresciuto in un ambiente sociale difficile,spinto dalle sconfitte del padre (cantanteoperistico fallito finito a insegnare comesupplente in una scuola) a cercare con osti-nazione il successo fin da ragazzo, Carl Icahna Wall Street arriva per caso. Laureatosi in fi-losofia a Princeton, comincia a studiare me-dicina, ma dopo un paio d’anni molla tutto esi arruola nell’esercito. Altri due anni e ab-bandona la divisa per andare a lavorare co-me stockbroker a Wall Street. Il ragazzo èsveglio: sette anni dopo, nel 1968, ha già for-mato la sua azienda, la Icahn & Co., specia-lizzata in arbitraggi e opzioni nel mercato,allora pionieristico, dei derivati. Ancora die-ci anni e lo ritroviamo, sempre più spregiu-dicato e finanziariamente solido, pronto adattaccare aziende importanti. Lo squalo èvorace e, anno dopo anno, non farà distin-
zione tra prede di di-verso sapore: azzan-nerà cosmetica (Re-vlon) e acciaio (Usx),petrol io (Texaco,Phillips) e pneumati-ci (Uniroyal), biscotti
(Nabisco), farmaci biotech (ImClone) e fu-metti (Marvel Comics). La tecnica che svi-luppa insieme ad altri finanzieri rapaci co-me quelli di Kkr è quella dei leveragebuyout: conquisti il controllo di un’aziendacon denaro preso a prestito, la ristrutturi,vendi, a pezzi, guadagnandoci, i suoi busi-ness più ricchi. Poi la abbandoni, agonizzan-te, a gestire le attività meno redditizie,schiacciata sotto una montagna di debiti.
Il caso da manuale è quello della TransWorld Airlines (Twa), la compagnia aereadell’eccentrico miliardario Howard Hughes,gioiello del trasporto intercontinentale.Icahn ne prende il controllo nel 1985. Capi-sce subito che i tempi stanno cambiandocon la concorrenza delle prime compagnielow cost. Taglia, ristruttura, comincia a ven-dere pezzi dell’aviolinea per ripagare i debitifatti per scalarla. Quando, nel 1991, vende idiritti di volo sull’Atlantico all’American Air-lines per 445 milioni di dollari, per la Twa èl’inizio della fine. Icahn a quel punto è già datempo l’incarnazione della greed: avidità, voracità. Lo è da quando, a fine 1987, arrivanei cinema Wall Street di Oliver Stone nelquale Michael Douglas, lo spietato Gordon
T rent’anni dopo le sue prime scalatecome quella alla Twa del 1985, edopo aver ispirato insieme a IvanBoesky e agli «avvoltoi» di Kkr (i fi-nanzieri Kohlberg, Kravis e Rober-
ts) film come Wall Street e libri come Barba-rians at the Gate, Carl Icahn potrebbe tran-quillamente essere scelto da registi e scritto-ri come figura-simbolo di una nuovastagione della finanza d’assalto: quella deiraider digitali che incalzano le imprese dellaSilicon Valley.
Archiviata qualche anno fa la prima in-cursione, l’assalto a Yahoo!, dalla metà del2013 Icahn ha infatti lanciato offensive a raf-fica contro Apple, eBay, Dell Computers eNetflix, gigante del video on demand e deifilm trasmessi in streaming. Attacchi di vol-ta in volta diversi: nel caso della Apple, adesempio, Icahn ha preso di mira le enormi riserve del gruppo fondato da Steve Jobs chedispone di 159 miliardi di dollari di liquidità.Il finanziere ha cercato di obbligare il capoa-zienda Tim Cook a distribuire una parte diquesta ricchezza agli azionisti anche attra-verso un imponente piano di riacquisto diazioni proprie, mentre nel caso della Dell si èbattuto contro i tentativi del fondatore delgruppo, Michael Dell, di ritirarlo dal merca-to azionario. A eBay, invece, il tycoon di NewYork aveva chiesto di «creare valore» tirandofuori dal gruppo e vendendo PayPal, la suasocietà di servizi di pagamento online.
Motivazioni diverse e anche esiti diversi.Non sempre Icahn riesce a centrare gli obiet-tivi strategici che si prefigge, ma le sue mos-se in genere costringono le società attaccatea cambiare rotta, ad aprirsi (e a volte anche aimpoverirsi) facendo concessioni agli azio-nisti e allo stesso Icahn. Che, anche quandofinisce per mollare l’osso, quasi sempre por-ta a casa un bel bottino: nel caso di Netflix,ad esempio, quando ha deciso di vendere ilsuo pacchetto di azioni visto che non riusci-va a conquistare la società, Carl ha guada-gnato 825 milioni di dollari in quella che èconsiderata una delle transazioni più reddi-tizie della storia della finanza.
Ma perché a portare lo scompiglio tra igeni visionari della Silicon Valley deve essereun finanziere 78enne che anno dopo annoha messo nel suo mirino industrie siderur-giche e casinò di Las Vegas, compagnie aereee petrolifere come Texaco, ma ha di certo di-mestichezza con le tecnologie digitali? A dif-ferenza di Warren Buffett, l’altro grande vec-chio della finanza americana, che preferiscenon investire nei business che non capiscefino in fondo, Icahn, oltre che spregiudicato,è un amante delle sfide temerarie, un esplo-ratore. Uno che l’anno scorso ha sorpresotutti dimostrando di saper usare con abilitàdiabolica i social media per gonfiare i valoridi un titolo in Borsa: quando ha deciso diprovare a mettere le mani sulla Apple, gli èbastato annunciare via Twitter che avevacomprato un miliardo di dollari di azioni eche considerava la società molto sottovalu-tata, aggiungendo di aver avuto un cordialecolloquio con il suo capo, Tim Cook, per faraumentare del 10 per cento il titolo.
Qualche giorno fa Icahn ha tolto l’assedioalla Apple dopo che Iss, una società di con-sulenza molto ascoltata dagli investitori, aveva invitato gli azionisti Apple a non asse-condare il tentativo del finanziere di obbli-gare il vertice della società a effettuare unbuy back (il riacquisto di azioni proprie) da50 miliardi di dollari. Una ritirata, certo, maIcahn fa un passo indietro dopo aver realiz-zato lauti guadagni e aver costretto Cook alanciare un buy back da 32 miliardi (14 deiquali già spesi) che altrimenti non avrebbemai nemmeno preso in considerazione.
Insomma, il motivo per il quale questoebreo di Rockaway, il rione del Queens af-facciato sull’Atlantico, si è dedicato con tan-ta determinazione ai giganti della tecnologiaè che nella Silicon Valley abbonda la materiaprima della quale ha bisogno ogni specula-tore che si rispetti: aziende piene di liquidi-
Carl Icahn, il broker che ispira film e libri, torna per spolpare le società digitali. Così apre una nuova stagione della finanza d’assalto, ma questa volta si trasforma in Robin Hood e piace agli azionisti
Lo squalo di Wall Street nella Silicon Valley
Strategie
dal nostro inviato a New York MASSIMO GAGGI
Gekko, compra e svuota la compagnia aereaper la quale lavora il padre del suo brokerpiù aggressivo.
Passano gli anni, Icahn continua a maci-nare affari, lavora come un matto, accumulafortune immense. Secondo «Forbes» ha unpatrimonio personale di oltre 20 miliardi didollari, ma non si ferma mai: vende il suo yacht di 53 metri e a chi non capisce il suoattivismo spiega che vacanze, crociere, cock-tail e cene di gala lo annoiano. Meglio gli af-fari. Anche perché, anno dopo anno, lo spe-culatore senza scrupoli ha cambiato pelle eora gli storici della finanza gli riconosconouna certa dignità: Icahn non attacca più leaziende usando solo denaro preso a prestito.Ormai è il finanziere più liquido di Wall Stre-et, capo di un gruppo, Icahn Enterprises LP,che ha in cassa 24 miliardi di dollari.
L’avvoltoio si è trasformato in activist in-vestor: uno che entra in aziende redditizie icui manager sono abituati a usare la ricchez-za prodotta per ampliare il gruppo (e i lorostipendi) anziché redistribuirla tra gli azio-nisti. E batte i pugni sul tavolo. A quel puntola metamorfosi di Icahn diventa un gioco daragazzi: il raider senza scrupoli adesso vestei panni del Robin Hood dei diritti degli azio-nisti troppo a lungo compressi. E il suo arri-vo nella Silicon Valley diventa un fatto quasinaturale. Non solo perché qui ci sono impre-se ricchissime gestite con pugno tutt’altroche ferreo dai giovani imprenditori libertaridell’economia digitale, ma anche perché,gratta gratta, la cultura della comunità tec-nologica californiana, benché intrisa di am-bientalismo e impegno per i diritti civili, allafine non è molto diversa da quella di WallStreet quando si parla di greed, voglia di ar-ricchirsi: bonus milionari non meno gene-rosi di quelli concessi ai finanzieri diManhattan e ampio ricorso ai più spregiudi-cati meccanismi di elusione per non pagarele tasse dovute allo Stato.
Così Icahn, un tempo considerato unaspecie di ricattatore, visto che molti, pur ditoglierselo di torno, ricompravano a prezzomaggiorato le azioni che lui aveva rastrellatosul mercato, ora viene presentato come ilprotagonista più disruptive della finanza americana: demolitore certo; ma quel termi-ne nella Silicon Valley piace, viene usato perindicare il modello di distruzione creativa alquale si ispirano le imprese delle tecnologiedigitali. Icahn, il vecchio raider che vuole ri-sorgere tra i nuovi leoni dell’hi-tech indos-sando i panni del rottamatore dei vecchi ritidel capitalismo americano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La biografiaCarl Celian Icahn è nato nel
1936 e cresciuto a FarRockaway nel quartiere di
Queens a New York,discendente da una famiglia
di origini ebraiche, ma conun padre che si definiva
«ateo dogmatico».Il giovane Carl, figlio diinsegnanti, dopo aver
frequentato la scuola di FarRockaway si diploma a
Princeton nel 1957 infilosofia, e frequenta per
qualche tempo la scuola dimedicina della New York
University, lasciando peròdopo soli due anni per
entrare nell’esercito. Inizia alavorare a Wall Street nel
1961 e già nel 1968 fondala Icahn & Co., mentre a
partire dal 1978 dà il via allasua scalata a importanti
compagnie e corporation.Si è sposato due volte: laprima nel 1979, con una
ballerina dell’exCecoslovacchia, Liba Trejbal,
da cui ha divorziato nel1999, dopo un ménage
alquanto agitato e due figli,Brett e Michelle. Nello stessoanno del divorzio ha sposato
la sua assistente ed exbroker, Gail Golden. La suabiografia, scritta nel 1993
da Mark Stevens ed edita daDutton, si intitola, in modo
significativo, King Icahn
i
U na vecchia scienza, l’antropologia, correin soccorso di una nuova, la cibernetica.Da Intel a Ibm, da Microsoft a Google, le
regine del software cercano di divinare dove gli utenti trovino la massima «computer and smartphone happiness», ossia la massima gratificazione nelle più alte tecnologie della comunicazione. E a questo scopo, si servono di équipe non più di soli programmatori ma anche di antropologi e futurologi, spesso centinaia di persone, che girano il mondo visitando le famiglie e le loro case per
individuarne e soddisfarne le esigenze. Così importante è la nuova disciplina, antropologia digitale o applicata, che essa modifica i progettidelle regine del software. Una svolta cruciale, dice Genevieve Bell, l’antropologa capo di Intel, ex docente a Stanford. Un esempio. Sinora, nella Silicon Valley si pensava che l’automobile dovesse essere un robot capace di guidare da sola, di comunicare coi garage, di eseguire comandi a voce. E invece le famiglie vogliono che sia anche il loro salotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tecnologie che rendono feliciAntropologia cibernetica
Il «capolavoro»Il caso da manuale fu la
Twa: comprata, frazionata, venduta. Un’azione
spregiudicata che raccontò Oliver Stone al cinema
SSS
da Washington ENNIO CARETTO
Sipho Mabona (1980), The Plague (2012): l’artista svizzero ha realizzato le cavallette del suo sciame con banconote da 1 dollaro

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 5
I l linguaggio New Age degli anni 60 èancora in circolazione, e uno deisuoi lasciti è la parola mindfulness,che è subentrata a «sostenibilità»:nessuno sa esattamente cosa sia, ma
tutti la cercano. Recentemente campeg-giava sulla copertina della rivista «Time»,e un lungo elenco di celebrità — AriannaHuffington, Deepak Chopra, Paulo Coe-lho — ne predicano instancabilmente levirtù, spesso in conferenze con titoli co-me «Wisdom 2.0». L’ultimo World Eco-nomic Forum di Davos ha anche organiz-zato un gruppo di lavoro sul tema. La rina-scita della mindfulness è in gran parte so-spinta dai progressi della tecnologia, conapplicazioni e activity tracker per smar-tphone che offrono nuove opportunitàper praticare meditazione, training men-tale e controllo dello stress. Il caso di Huf-fington, una delle maggiori promotricidella (il quotidiano online che porta il suonome ha anche lanciato una app per rile-vare lo stress, dal poetico nome di «Gpsfor the soul», Gps per l’anima), è partico-larmente curioso, perché la minaccia allaviene proprio dai social media, dai gadgetelettronici e dalle app, che sono il mondoin cui Arianna Huffington è di casa.
Anche il presidente di Google Eric Sch-midt ha aderito a questo club, sostenendoche dobbiamo stabilire degli orari in cuisiamo «on» e altri in cui siamo «off», eannunciando la sua scelta di lasciar da parte i gadget tecnologici durante i pasti.Ci sono anche applicazioni e aziende che,a pagamento, ci aiutano a rispettare lapausa del «sabato digitale», o a intra-
prendere una «disintossicazione digita-le», o ancora a unirci a gli «obiettori digi-tali» che si incontrano in luoghi privi didispositivi elettronici. Mai prima d’ora laconnettività ci ha offerto tanti modi perdisconnetterci. Ci viene chiesto di discon-netterci per poter riprendere le nostreconsuete attività con rinnovata energiaquando torniamo nel «paese della distra-zione». La ricerca della svolge in questocaso lo stesso ruolo del buddhismo — piùesattamente una versione Davos del bud-dhismo, quella abbracciata dal mondoimprenditoriale.
Nel nostro mondo follemente com-plesso, dove tutto è in continuo cambia-mento e spesso poco comprensibile,l’unico atteggiamento ragionevole sareb-be rinunciare a ogni tentativo di controlloe adottare un comportamento Zen: accet-tare il mondo così com’è e cercare la pro-pria pace al suo interno. È facile capire co-me questo modo di pensare sia reaziona-rio. Come ha detto una volta scherzosa-mente il filosofo sloveno Slavoj Zizek, «seMax Weber fosse vivo oggi, sicuramentescriverebbe un secondo trattato, comple-mentare alla sua Etica protestante e lospirito del capitalismo, intitolato “L’eticataoista e lo spirito del capitalismo globa-le”». I manager abbracciano la come ac-colgono le altre forme del «nuovo spiritodel capitalismo», che si tratti di yoga sulposto di lavoro o di infradito alle riunioni:è un modo di ri-confezionare l’alienazio-ne come emancipazione, e intanto incen-tivare la produttività.
Non sorprende che Arianna Huffin-gton speri che la ricerca della mindful-ness da parte della gente di Davos riesca ariconciliare finalmente la spiritualità e il capitalismo: «Una quantità crescente diprove scientifiche dimostra che questi
Film che si aprono come libri da sfogliare. Nei primi anni del cinema era un espediente per affermarne l’autorevolezza culturale: come in Malombra di Carmine Gallone (1917). Nei film Disney trasportava nell’atmosfera
fantastica della favola narrata da una voce fuori campo. Il libro accompagna lo spettatore in un mondo immaginario. Anche quando le sue pagine vengono strappate da un orco verde di nome Shrek (2001).
Un po’ di carta dentro il film
{Il dibattito delle ideeCiak, si legge
di Cecilia Bressanelli
scono lo stress causato dalla distrazione edall’essere in rete a una qualche forza au-tonoma e inesorabile — modernità, pro-gresso, tecnologia — o danno la colpa allanostra incapacità di reagire o, peggio an-cora, al fatto che non abbiamo app controlo stress sui nostri iPad.
Ma i «disconnessionisti» — come uncritico ha recentemente chiamato questofenomeno sociale emergente — non po-trebbero avere uno scopo un tantino piùradicale della «disintossicazione digita-le»? Intanto, il termine «disintossicazio-ne» ci fa pensare che il desiderio di essereperennemente collegati sia una patolo-gia. I promotori della disconnessionesembrano poi avere una visione piuttostoconfusa della politica. «Scollegarsi indivi-
È reazionario e sterile disconnettersi per ricaricare le pile o fare meditazione in stile mindfulnessMeglio disintossicarsi consapevolmente, sabotando gli strumenti di distrazione di massa digitale
I social media sono come le slot machine
Società
di EVGENY MOROZOV
dualmente, in realtà, non è una risposta aimaggiori problemi tecnologici del nostrotempo, proprio come mangiare cibi localie organici non risolve i problemi dell’agri-coltura globale», ha scritto Alexis Madri-gal su «The Atlantic». Si noti che è l’attodel disconnettersi — staccare la spina —a essere il bersaglio delle critiche, comese non ci fossero buone ragioni per vede-re con sospetto la pressione a essere sem-pre connessi che arriva da Silicon Valley.Nel tentativo di rivelare le ansie d’élite dichi propone la «disintossicazione digita-le» — sostenendo, ad esempio, che scol-legarsi equivale a indossare abiti vintage emangiare formaggio artigianale — i criti-ci come Madrigal rischiano tuttavia di ap-provare le strategie di sfruttamento di Twitter e Facebook.
Si parla tanto di economia dell’atten-zione, ma dobbiamo anche pensare al-l’economia dell’attenzione in termini po-litici — ed è qui che scollegarsi potrebbeessere di qualche utilità. Dopo tutto, checosa c’è di così naturale nel modo in cuiTwitter ci spinge a controllare quantepersone hanno interagito con i nostritweet? Che a Twitter interessi è ovvio:quanti più dati mettiamo in circolazione— cliccando all’infinito — tanto più gli inserzionisti saranno interessati a Twit-ter. Ma gli interessi di Twitter non sononecessariamente i nostri. Perché dovrem-mo aderire al credo del «tempo reale» —all’idea che dobbiamo sapere, non appe-na i dati sono disponibili, quel che ilmondo pensa di ogni nostro tweet? Dob-biamo sapere che le piattaforme dei so-cial media sono state progettate per asse-condare i loro interessi commerciali, ed èper questo che ogni nostro click viene re-gistrato. La fastidiosa tentazione di segui-re il destino di ogni nostro tweet, all’infi-nito e nel modo più accurato possibile, ètutt’altro che scontata.
Dobbiamo sottoporre i social media aquell’esame critico che è stato applicatoalla progettazione delle slot machine deicasinò di Las Vegas. Come ha mostratoNatasha Dow Schüll nel suo eccellente li-bro Addiction by Design: Machine Gam-bling in Las Vegas, mentre gli operatori dei casinò vogliono farci credere che la di-pendenza dal gioco sia il risultato di unanostra debolezza morale o di qualchesquilibrio biologico, sono loro ad averprogettato le macchine in modo da crearedipendenza. Nei social media — comenel caso delle slot machine o del fast food— la dipendenza è indotta, non è natura-le.
Non dobbiamo confondere la strategiadella disconnessione nella sua forma ra-dicale e proiettata verso l’esterno, conquella reazionaria, ripiegata su se stessa.Il perché ci scolleghiamo è importante:possiamo continuare a pensare — secon-do la tendenza attuale — che sia un modoper ricaricarsi e recuperare la produttivi-tà, o che sia invece un modo per sabotarele tattiche di induzione alla dipendenzamesse in atto da quel motore dell’accele-razione-distrazione che è Silicon Valley. Ilprimo atteggiamento è reazionario, ma ilsecondo può portare all’emancipazione,soprattutto se questi atti di rifiuto dannoluogo a veri e propri movimenti costruitiattorno ai temi della temporalità e dell’at-tenzione, lontani dai programmi di busi-ness delle brigate spirituali di Davos. Spe-riamo che questi movimenti producanopratiche alternative, istituzioni e progettiche ci permettano di abbandonare i dictatdel «tempo reale» e di abbracciare unmodo di comunicare migliore. Se per ar-rivarci dobbiamo staccare la spina, faccia-molo. Ma non per poi poterci ricollegarecome prima. Non bisogna farsi oscurare la mente dalla mindfulness.
(traduzione di Maria Sepa)© RIPRODUZIONE RISERVATA
I l premio Pulitzer Julia Angwin è una specialista della privacy. Dopo anni di inchieste — prima per il «Wall Street
Journal», oggi per il sito non profit «ProPublica» — ha deciso di sperimentare in prima persona alcune tecniche contro la nuova sorveglianza di Stato «computerizzata, impersonale, diffusa e insospettabile». Il risultato è Dragnet Nation (Times Book), libro presentato in anteprima alla Social Media Week di New York in cui l’autrice descrive un anno trascorso nel tentativo di cancellare le proprie tracce digitali. La giornalista
ha utilizzato molteplici identità online, carte di credito e cellulari usa e getta; evitato i social network e abbandonato piattaforme e servizi che conservano i dati personali (Google, ad esempio) in favore di siti più sicuri come DuckDuckGo per le ricerche e Riseup per la posta. Il libro contiene una lista di 200 «data broker» — aziende che vendono le informazioni degli utenti — e metodi per criptare conversazioni e messaggi. La cattiva notizia è che, nonostante tutto, su internet esistono ancora tracce di Angwin.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Modelli di difesa della privacyIl manuale di Julia Angwin (con una cattiva notizia)
Contro le dipendenzeLa strategia da utilizzare
è l’esame applicatoalla progettazione
dei giochi automaticinei casinò di Las Vegas
SSS
due mondi sono alleati — o almeno chepossono e dovrebbero esserlo», ha scrittoin un recente articolo. «Quindi sì, voglioparlare di massimizzazione dei profitti edi risultati oltre le aspettative, e sottoline-are l’idea che quel che va bene per noi co-me individui funziona anche per i contidelle aziende americane».
Quel che rende politicamente interes-sante questa ricerca della mindfulnessamica del capitalismo è che incoraggia —forse inconsapevolmente — gli atti di vo-lontaria disconnessione dal mondo di Fa-cebook e Twitter. È vero che i predicatoridella mindfulness li presentano comeuna pausa necessaria, di cui tutti abbiamobisogno, per poi riconnetterci e mantene-re lo status quo. In questo modo attribui-
«Mindfulness»Su «la Lettura»
del 2 febbraio scorso,lo psicoterapeuta
Giancarlo Dimaggioè intervenuto per raccontare
la nascita e la diffusionedella mindfulness,
una particolare tecnicadi meditazione.
La parola, difficilmentetraducibile, significapienezza mentale o
consapevolezza intenzionale.Secondo i suoi sostenitori,
può avere applicazionicliniche contro stati di ansia,
stress e depressione. Recentistudi analizzano come aiuti
a sviluppare la capacitàdi calmare le emozioni
negative per migliorarel’empatia.
Tra i cultori di questa intensaarte del silenzio ci sono
Ricky Martin, NovakDjokovic, The Edge, Oprah
Winfrey, Kobe Bryant.Il pioniere di questi studiè Jon Kabat-Zinn, dirige
il Centro per la mindfulnessdella University of
Massachusetts MedicalSchool. È autore dei libri
Vivere momento per momento(Tea) e Dovunque tu vada,
ci sei già (Tea)
i
di SERENA DANNA
ILLUSTRAZIONE DI PIERLUIGI LONGO

6 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
OrizzontiNuovi linguaggi, scienze, religioni, filosofie
Lo storico Claudio Venza, docente all’ateneo di Trieste, ha insegnato anche all’Università Autonoma di Barcellona. Condirettore della rivista «Spagna Contemporanea», ha promosso, con Giampietro Berti, il Dizionario biografico degli anarchici italiani (Bfs,2004-05, 2 voll.). Tra i suoi libri: Anarchia e potere nella guerra civile spagnola (Elèuthera, 2009). Da oggi consiglia un libro al giorno ai follower de @La_Lettura.
Claudio Venza è il #twitterguest
L’intervista Colloquiocon Yuri Manin, uno dei maggiori matematici viventi, docente a Bonn e a Mosca, che per primo proposedi sostituire la «macchinadi Turing». Ma violare i codici cifrati (operazione che oggi richiede anni) diventerebbe un gioco da ragazzi
Il computer che batte il computerLa fisica quantistica riuscirà a cambiare tuttoVelocità di calcolo enorme, sicurezza a rischiodi STEFANO GATTEI
I l Novecento si apre con una profondacrisi della fisica, segnata dalla nascitadi due grandi teorie: la relatività gene-rale, che sostituisce la teoria della gra-vitazione universale di Newton; e la
meccanica quantistica, basata sull’idea chel’energia sia trasmessa in modo non conti-nuo, ma per pacchetti discreti (i quanti).
Entrambe le teorie hanno conseguenzespesso inaspettate e controintuitive: in basealla meccanica quantistica, per esempio, siala radiazione sia la materia hanno caratteri-stiche tanto ondulatorie quanto particellari,al contrario della meccanica classica, in basealla quale la luce è trattata come un’onda el’elettrone come una particella. Entrambe,tuttavia, hanno avuto importanti riscontrisperimentali, rivoluzionando l’impianto te-
orico della fisica e la nostra vita di tutti igiorni (basti pensare alla risonanza magne-tica o ai telefoni cellulari).
Nei primi anni Ottanta Richard Feynmanosservò che non sarebbe stato possibile si-mulare alcuni fenomeni governati dallameccanica quantistica per mezzo di uncomputer classico. D’altra parte, i continuiprogressi della tecnologia portavano a unacrescente miniaturizzazione dei circuiti, e inun tempo relativamente breve ogni compo-nente si sarebbe ridotto alle dimensioni dipochi atomi. Su scala atomica, i fenomenisono governati da leggi che non seguono lafisica classica, ma quella quantistica; Feyn-man suggerì allora di sostituire la «macchi-na di Turing», proposta nel 1936, con la suaversione quantistica che, a differenza della
precedente, era in grado di simulare i feno-meni previsti dalla fisica dei quanti senzasubire un calo esponenziale di velocità.
Ne discutiamo con Yuri Manin, che pro-pose per primo l’idea, nel 1980, anche se ilsuo lavoro divenne noto solo successiva-mente a quello di Feynman, in quanto ap-parso originariamente in russo. Tra i mag-giori matematici viventi, Manin divide oggila propria attività tra la Germania, dove è professore al Max Planck Institut für Mathe-matik di Bonn, e la Russia, dove insegna alcelebre Istituto Steklov di Mosca. Lo contat-tiamo in una pausa di lavoro e gli chiediamocome sia giunto all’idea di un computerquantistico.
«Negli anni Settanta tenevo un corso dilogica matematica a Mosca, e al medesimo
tempo avevo intrapreso alcune ricerche difisica matematica: volevo trovare un pontefra le due discipline, solitamente considera-te disgiunte. Nel 1977 le mie lezioni conflui-rono in un libro, edito da Springer, in cui unintero capitolo era dedicato alla logica quan-tistica. L’edizione russa del testo apparve indue volumi, nel 1979 e nel 1980. Nell’intro-duzione che scrissi per il secondo proposi l’idea di un computer quantistico. Fui sti-molato da due ordini di problemi: compren-dere la fisica alla base della replicazione delDna e calcolare in modo efficiente le caratte-ristiche fisiche di un sistema quantistico».
Quali sono le differenze tra la sua pro-posta e quella avanzata da Feynman nelcelebre articolo «Simulating Physics withComputers» del 1982?
ILLUSTRAZIONEDI FRANCESCA CAPELLINI

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 7
Una figura emergentenei gialli e nei thriller
Elementare, hacker Il pirata informaticoè il nuovo Watson
Tendenze
di PAOLO ROVERSI
A sociali e schivi ma anche ge-niali, abili con i numeri e a pro-prio agio davanti a una tastiera;sono gli esperti informatici, inuna parola, hacker. E non sono
mai stati numerosi come oggi nella lette-ratura thriller. Nel nuovo romanzo di Fre-derick Forsyth La lista nera (Mondadori),ad esempio, il protagonista, l’ex marineKit Carson, incaricato di trovare l’uomoche ha rubato la lista con i nominativi deiterroristi più pericolosi in circolazione, siavvale proprio di un giovane genio dellatastiera, il cui nome in codice è Ariel: unragazzo che trascorre il proprio temporinchiuso in soffitta per via di una sindro-me agorafobica, ma che in compenso co-nosce tutti i segreti dell’universo di inter-net.
Stessa vocazione per la determinata Ka-trine Bratt, membro della squadra capita-nata dal detective Harry Hole, l’eroe parto-rito dalla penna del norvegese Jo Nesbø dicui ad aprile Einaudi pubblicherà la pri-ma avventura — ancora inedita in Italia— Il pipistrello. A qualcuno potrebbesembrare un caso che personaggi conqueste specifiche caratteristiche ricorra-no tanto spesso nella narrativa di genere.Ma nei thriller due coincidenze costitui-scono un indizio.
Apripista e trendsetter di questa nuovatendenza è stato, nel 1998, Dan Brownquando, al suo esordio narrativo inventòGreg Hale, hacker e crittografo dell’Nsa (l’agenzia per la sicurezza americana, ilgrande fratello dello scandalo Datagate diEdward Snowden), che nel romanzoCrypto (Mondadori) aiuta la protagonistaSusan Fletcher a impedire che un codicesegreto cada nelle mani sbagliate. Qual-che anno più tardi, nel 2001, un altro mae-stro come Jeffrey Deaver in Profondo blu(Rizzoli), dove il blu è appunto il web piùoscuro, dà vita a un cracker (appellativoattribuito in gergo a un hacker che sfruttale proprie conoscenze tecnologiche perfare il guastatore) di nome Pathe, che siinfiltra nei computer delle vittime, trami-te un software di sua invenzione, per atti-rarle in una trappola mortale. Questo co-stringe il detective Frank Bishop a ingag-giare un altro esperto informatico, dete-nuto per reati analoghi a quelli del serialkiller, scatenando così la lotta fra l’hackerbuono e quello cattivo.
La consacrazione di questo personag-gio, tuttavia, si ha nel 2005 e arriva dallaSvezia. «Era la persona più asociale cheavesse mai incontrato, (…) aveva la capa-cità di infilarsi sotto la pelle della personasu cui stava indagando. Se c’era del mar-cio da scovare, ci zoomava come un missi-le da crociera programmato». Questa de-scrizione si riferisce all’intrigante LisbethSalander, donna complessa e indecifrabi-le, amatissima dai lettori, protagonista in-sieme al giornalista Mikael Blomkvist del-la trilogia Millennium scritta dallo svede-se Stieg Larsson (edita in Italia da Marsi-lio). Da allora il fenomeno è in costantecrescita, al punto che nel 2013 molti auto-ri hanno pubblicato romanzi in cui l’hac-ker riveste un ruolo fondamentale, diven-tandone, in alcuni casi, il protagonista as-soluto; come in Alif l’invisibile di WilsonWillow (Il Saggiatore) dove Alif è un inaf-ferrabile pirata del web o in Blackout diMarc Elsberg (Nord) in cui il protagonistaPietro Manzano è un ingegnere informa-tico. Perfino Isabel Allende nel recente Ilgioco di Ripper (Feltrinelli) ha inserito un
personaggio con queste caratteristiche. Ormai è diventato quasi mainstream. Manon è una questione di moda, l’hackersvolge spesso una precisa funzione narra-tiva.
Una volta era la battuta distratta deldottor Watson a fornire a Sherlock Hol-mes l’illuminazione giusta per risolvere ilcaso. Nel passato recente, questo ruolo era interpretato dagli esperti della Scien-tifica i quali, grazie a microscopi e provet-te, incastravano i colpevoli con il Dna e al-tre prove schiacciati, che non lasciavanospazio a dubbi; ma anche queste figure —che continuano a popolare molte riusciteserie televisive — sono state scavalcate daquella dell’hacker, o in senso più largodall’esperto informatico.
Il motivo è semplice: la tecnologia èparte integrante della nostra vita. Tuttipossediamo un pc, un tablet o un telefo-nino e quindi diventiamo tracciabili, in-tercettabili, individuabili. Quando avvie-ne un delitto basta un controllo sui cellu-lari agganciati alla cella telefonica di quel-la zona e, voilà, il cerchio dei sospetti èsubito circoscritto. Se poi nelle vicinanzec’è una banca o un distributore di benzi-na, una gioielleria o una telecamera disorveglianza del traffico l’hacker potrà fa-
cilmente trovare il video del sospetto chefugge dopo il misfatto. Ad abilità maggio-ri, come queste, corrisponderanno in-trecci e colpi di scena maggiori.
In molti casi l’hacker ricorda il misterWolf di Pulp Fiction, film di Quentin Ta-rantino dove il personaggio interpretatoda Harvey Keitel risolveva, di professione,i problemi.
Anche in Italia sta prendendo piedequesto Watson 2.0. Vanno ricordati i re-centi romanzi di Federico Tavola Uccide-rai corrotti e infedeli (Mursia) e, soprat-tutto, L’ultimo hacker (Marsilio) di Gio-vanni Ziccardi, il cui protagonista Ales-sandro Correnti è un cracker redento chesi vedrà costretto, per risolvere un caso dipedo-pornografia, a rimettersi dietro allatastiera e a rispolverare i vecchi metodi.
Per chi vuole mettere un hacker nel suoromanzo, è fondamentale leggersi quellache è considerata la bibbia in questo cam-po: L’arte dell’inganno (Feltrinelli) di Ke-vin Mitnick, uno dei più grandi cracker ditutti i tempi. Pentito, in queste pagine rac-conta come difendersi da quelli come lui.Spiega, ad esempio, come i cyberpiratiestorcano informazioni per impossessar-si delle password; come entrino nei com-puter di ignari utenti tramite un allegatomaligno o inducendoli a navigare su unsito civetta che infetterà il loro pc; comeriescano a «bucare» anche il sito azienda-le più sicuro sfruttando la «componenteumana» che sta dietro al sistema. E cherende l’hacker così imprevedibile.
@paoloroversi© RIPRODUZIONE RISERVATA
trattano anche processori con dimensioni“consistenti”, ma i successi ottenuti, in pra-tica, sono molto pochi. Già alcune dozzinedi qubit sono considerate un successo (la D-Wave, nel 2012, aveva per esempio sostenuto
di utilizzare 84 qubit). I proces-sori quantistici lavorano sottol’attenta supervisione di com-puter classici che svolgono al-cuni compiti di base: fornire gliinput, misurare gli output, ripe-tere più volte la medesima ope-razione. Anche per la memoriz-zazione dei dati si ricorre allememorie di computer classici».
Molti codici cifrati attual-mente in uso funzionano nonperché teoricamente impene-trabili, ma perché violarlicomporterebbe tempi estre-mamente lunghi anche per i
computer più potenti. Nel 1994 Peter Shordimostrò che il problema della fattorizza-zione dei numeri primi (classicamenteconsiderato intrattabile, e per questostrettamente legato ai sistemi cifrati di si-curezza) si può risolvere in un tempo ra-gionevole attraverso un algoritmo quanti-stico. Perché questo non è possibile su uncomputer classico?
«Uno dei modi per aumentare la velocitàcon cui si eseguono gli algoritmi classici èquello di ricorrere a calcoli in parallelo. Glialgoritmi quantistici, come quello di fatto-rizzazione di Shor, sostituiscono ai classicicalcoli in parallelo dei calcoli in paralleloquantistici. La cosa è resa possibile dal feno-meno noto come entanglement (o “correla-zione quantistica”): dal punto di vista mate-matico, significa che lo stato quantistico diun sistema è, in generale, la combinazionedi molti (o addirittura di un numero infinitodi) stati classici».
In altre parole: se anche i più potenticomputer classici potrebbero impiegaredecenni per violare un codice cifrato, icomputer quantistici potrebbero farlo nelgiro di pochi minuti. La loro introduzionecostituirebbe allora una minaccia per lasicurezza elettronica?
«Le minacce sono determinate dagli uo-mini, non dai prodotti della loro scienza e della loro tecnologia. E dato che gli esseriumani utilizzano invariabilmente le miglio-ri creazioni della loro mente collettiva perl’autodistruzione, non posso essere molto ottimista nemmeno per quanto riguarda i computer quantistici. Isaiah Berlin intitolò una raccolta dei propri scritti Il legno stortodell’umanità, con riferimento a Kant. Berlinvoleva dire che tutti i progetti sociali di am-pio respiro sono destinati a fallire: non èpossibile costruire un edificio su un legnostorto. Ma continuiamo a sperare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sembrano quadri. Disegnati con i piedi. Quelli dei runner che fanno registrare una traccia pubblica della propria corsa da una app. New York, Helsinki, Dallas, Venezia. Traiettorie sovrapposte del training di centinaia di persone creano un reticolo sulle mappe che, come immagini di neuroni, mostrano come tendiamo tutti a seguire linee usuali. Per una volta essere abitudinari può offrire agli urbanisti che sanno chi siamo e dove corriamo, i dati per migliorare le città.
Le tracce delle nostre corse
{Cittadinidi Edoardo Vigna
«Credo che la motivazione principale diFeynman fosse identica alla mia. Entrambiavevamo compreso che le potenzialità deicomputer classici non potevano essere suf-ficienti, realisticamente, per dare conto an-che dei calcoli più semplici di meccanicaquantistica. Potremmo dire che, ogniqual-volta osserviamo un sistema quantistico, co-me per esempio nel caso della misura dellospettro di emissione dell’atomo di idroge-no, utilizziamo tale atomo come un compu-ter quantistico per risolvere un problema matematico concreto. Certo, dal punto di vi-sta storico, il cammino è stato inverso: è sta-ta l’osservazione dei sistemi fisici a contri-buire alla realizzazione dell’apparato mate-matico della meccanica quantistica».
Sfruttando alcune peculiarità dellanuova fisica, non disponibili in un quadroclassico, si arriverebbe a una crescitaesponenziale della velocità di computa-zione, con ovvi vantaggi per la trattazionedi problemi complessi. La realizzazione diun computer quantistico universale, sulmodello della macchina di Turing, è peròmolto lontana.
«Non disponiamo ancora di una correttacomprensione teorica di quella che potreb-be essere la versione quantistica della mac-china di Turing. Il punto è che negli anniTrenta e Quaranta, quando fu creata la mo-derna teoria della computabilità, venneroproposte varie definizioni degli algoritmi dicomputazione, alquanto diverse fra loro.Molto presto ne venne dimostrata l’equiva-lenza, e si arrivò alla cosiddetta “tesi diChurch”: qualunque schema di computazio-ne immaginabile in futuro sarà equivalentea quelli che già esistono. È un esempio diquella che mi piace chiamare “una scopertasperimentale nel mondo delle idee”. Nientedi tutto questo si è ancora verificato per icomputer quantistici, ed è improbabile chesi verifichi in tempi brevi».
Per i computer tradizionali, basati suitransistor, il costituente di base dell’in-formazione è il bit, mentre per i computerquantistici è il qubit (o quantum bit). Se un bit può assumere uno solo di due statidifferenti (sì o no, vero o falso, zero ouno), un bit quantistico può essere codifi-cato come combinazione di due stati, tipogli stati di spin 1/2 o i differenti stati elet-tronici di un atomo. In questo modo icomputer quantistici hanno la possibilitàdi essere in più di uno stato simultanea-mente, con vantaggi enormi dal punto divista della velocità di elaborazione delleinformazioni.
«In senso proprio, le computazioni quan-tistiche sono processi fisici che si sviluppa-no su uno o più dispositivi. Teoricamente, si
Il personaggioNato nel 1937 a Sinferopoli,
in Crimea, lo scienziatorusso Yuri Manin (nella foto
qui sopra, courtesy DenisMironov/Simons Foudation)
è uno dei matematici piùnoti a livello internazionale.
Docente al Max PlanckInstitut für Mathematik di
Bonn e all’Istituto Steklov diMosca (dove ha ottenuto il
suo dottorato nel 1960), hainsegnato anche in Usa, alla
Northwestern UniversityUn’ipotesi rivoluzionaria
Nella introduzione a un suolibro uscito nel 1980, Maninavanzò per primo l’ipotesi di
utilizzare i fenomeni tipicidella meccanica quantistica
per l’elaborazione delleinformazioni. Due anni dopo,
del tutto autonomamente,una proposta analoga venne
avanzata dallo scienziatoamericano Richard Feynman(1918-1988), premio Nobel
per la fisica nel 1965, in unarticolo apparso nel 1982sulla rivista «International
Journal of TheoreticalPhysics»
La macchina di TuringIntrodotta negli anni Trenta
dal matematico inglese AlanTuring (1912-1954),l’omonima macchina
manipola i dati contenuti suun nastro di lunghezza
infinita. Ha fornito unmodello astratto di calcoloautomatico, essenziale perlo sviluppo dell’informatica
i
Corsari della tastieraDan Brown nell’esordio
«Crypto» mette un agente crittografo dell’Nsa, mentre
Larsson in «Millennium» dà vita a Lisbeth Salander
SSS

8 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 9
Luciano di Samosata ritorna con i suoi brevi quindici Dialoghi delle cortigiane (a cura di Francesco Chiossone, Il Melangolo, pp. 112,e 8). Scritti con uno stile semplice, restano un ritratto immortale della categoria esaminata,
tra amori, gelosie, interessi, cattiverie varie. Esemplare il dialogo tra la madre Crobile e la figlia Corinna. La avvia al più antico dei mestieri utilizzando parole attualissime: «Tu devi sempre mirare a chi paga meglio».
Chi paga meglio
{Orizzonti Visual dataVa pensiero
di Armando Torno
TIPI DI VELO
1. BURQA
VELO
PIÙ CONSERVATORE MENO CONSERVATORE
2. NIQAB 3. CHADOR 4. AL-AMIRA 5. HIJAB 6. SENZA VELO
PELLE
FONTE: UNIVERSITY OF MICHIGAN’S INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH
TURCHIA
LIBANO IRAQ
EGITTO
TUNISIA
ARABIA SAUDITA
PAKISTAN
La barra grafica mostra quale velo, secondo gli intervi-stati di ciascun Paese, una donna dovrebbe usare nei luoghi pubblici. Si va dal più conserva-tore a quello che lo è meno, riportandone le percentuali. Si mostrano le tre opinioni prevalenti.
La donna raffigurata indossa i veli scelti in quel Paese, la loro ampiezza riflette la percentuale
IL VELO APPROPRIATO
PAESI CONSIDERATI
Al-Amira32%
Senza velo49%
Hijab12%
Senza velo32%
Al-Amira46%
Hijab17%
Iraq
Hijab10%
Chador32%
Al-Amira44%
Al-Amira24%
Niqab32%
Chador31%
Pakistan
Al-Amira10%
Niqab63%
Chador8%
A. Saudita
Hijab13%
Al-Amira52%
Chador20%
Al-Amira57%
Hijab23%
Senza velo15%
LibanoTurchiaEgitto Tunisia
H ijab, chador, burqa, ni-qab... «Per voi in Occiden-te sono simboli della sot-tomissione delle musul-mane, anche se molte li
portano per scelta. Ora, con l’avanzatadei fondamentalisti, anche da noi so-no un segno negativo, almeno per me.Ma i problemi delle donne dell’islamsono altri. E comunque quei veli sonosolo una faccia della medaglia». NawalSaadawi, la più famosa e radicale fem-minista araba, oggi ottantaduenne,
Hijab, burqa, niqab... Le diverse tipologie dicono qualcosa dei Paesi che seguono l’islam. Ma le vere discriminanti sono rappresentate da altro: diritti civili e personali, figli, religione
Il velo copre le donne. E nasconde il resto
Fede e società
come tutte le donne musulmane vela-te o meno (lei non lo è affatto, e si ve-ste pure di colori sgargianti), si irritaun po’ a sentirsi chiedere del velo.
Nell’ultimo nostro incontro al Cairoera anzi passata all’attacco contro la«visione superficiale e stereotipata» che in Europa e negli Stati Uniti si hadella questione femminile in terrad’islam e contro «l’ossessione tutta oc-cidentale» per il velo. E con «la Lettu-ra» aveva insistito su un punto: «Guar-date che chi impone l’hijab da noipunta allo stesso obiettivo di chi co-stringe le vostre donne a spogliarsi o a
usare la chirurgia plastica. Vuole ri-durci a solo corpo, merce per il liberomercato patriarcale. Gli uomini non sivelano né si spogliano». Poi era passa-ta a discutere di politica, diritti, rivolu-zione. Non deve così sorprendere cheuna recente ricerca dell’University ofMichigan, illustrata qui sopra, abbiaavuto ampio risalto sui media occi-dentali (poco o niente nei Paesi mu-sulmani) ma solo per il «capitolo ve-lo».
Condotto in sette Paesi di credo isla-mico, necessariamente limitato per-ché escludeva un’immensa parte del
mondo che crede in Allah, lo studio hail pregio di aver posto a migliaia dipersone domande dirette e molto con-crete su questioni normalmente tabù,come il rapporto fede-politica, la de-
mocrazia e i militari, le relazioni con lealtre religioni. Tutti temi caldissiminella regione. E anche nel capitolo«generi», la domanda sul velo («qual èil più appropriato per una donna inluoghi pubblici?») era solo la sedicesi-ma. Preceduta da quesiti sulla poliga-mia, l’indipendenza economica dellamoglie, la sua sottomissione, la custo-dia dei figli.
Questioni, direbbero Nawal e milio-ni di musulmane con lei (velate o no),mille volte più importanti del hijab, oburqa, chador o niqab che sia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di CECILIA ZECCHINELLI
L’autrice La visualizzazione dati di questa settimana è a cura di Monica Serrano Estepa, grafica spagnola residentea Buenos Aires, specializzata in design dell’informazione. Il suo portfolio è visibile online sul sito monicaserrano.com

10 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Una leggenda narra che Robert L. Johnson abbia stretto un patto con il diavolo a un incrocio stradale: la mia età in cambio di una musica inaudita per chitarra. Johnson, che era nato sul delta del Mississippi, morì nel 1938 avvelenato da un marito geloso: aveva 27 anni, primo artista del maledetto club di artisti morti a 27 anni (Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin...). Nel frattempo diede una mano a inventare il rock. Di lui restano 29 tracce, rimasterizzate nel 2011. E una musica sublime, la musica del diavolo.
Il diavolo suona la chitarra
{Incisionidi Renzo Matta
CaratteriNarrativa italiana, straniera, saggistica, classifiche
Incontri Il maestro della crime fiction americana apre le porte della casa di Manhattan Promuove Turow, boccia Dan Brown. Parla del nuovo romanzo (con Haller) e dell’Italia
Chandler, capitolo 13. Perciò scrivoAmori, passioni e crediti (letterari) di Michael Connelly«La sorellina» è pura poesia, io sogno di essere Marlowe dal nostro corrispondente a New York
ALESSANDRA FARKAS
«N on sarei mai diventatouno scrittore se nonavessi letto il tredicesi-mo capitolo de La so-rellina di Raymond
Chandler. Quel capitolo è poesia pura e an-cora oggi, prima di iniziare un romanzoambientato a Los Angeles, devo rilegger-lo». Il 57enne maestro della crime fictionMichael Connelly apre le porte del suo ap-partamento con vista mozzafiato su CentralPark South a Manhattan (una delle sue tan-te case, oltre a quelle di Los Angeles e Tam-pa) per parlare de Il quinto testimone — nelle librerie italiane il 25 febbraio, editoda Piemme —, nuova avventura dell’avvo-cato Mickey Haller con un cammeo del de-tective Harry Bosch, suo mentore e fratella-stro, protagonista di diciotto bestseller. Sfi-dando l’etichetta azzimata di uno degli in-dirizzi più costosi di Manhattan, Connellyostenta il look super-casual (pantaloni di felpa e maglietta grigi) che i newyorchesisnob chiamano «Florida style». E invece dipromuovere i suoi libri, ha voglia di parlaredel suo eroe. «In quelle meravigliose pagi-ne del tredicesimo capitolo — riprende —Chandler riesce a fondere in manieraesemplare il carattere di un luogo, la cittàdi Los Angeles, a quello del protagonista, ildetective Philip Marlowe. Fu dopo aver let-to il libro che dissi ai miei genitori: “Vogliofare il giallista, non l’ingegnere”». Il suoBosch debutta a marzo nell’episodio pilotadi Amazon.com, dove i suoi libri sono tra ipiù venduti. «Amazon dovrà decidere setrasformarlo in un serial che verrà distribu-ito sul web in America e Gran Bretagna. Nelresto del mondo, Italia inclusa, potrebbedebuttare già a fine anno sul piccolo scher-mo. Sarà il pubblico a decidere la sua sortee finora la reazione è stata straordinaria,con oltre 4 mila recensioni stellari in unasola settimana».
Pensa che il web sia il futuro della tele-visione?
«Ne sono convinto. Come moltissimiamericani, anch’io guardo la tv online per-ché è conveniente e flessibile. I miei librihanno già ispirato due film hollywoodiani,Debito di sangue con Clint Eastwood e TheLincoln Lawyer con Matthew McConau-ghey, ma la web tv è il formato migliore perun personaggio complesso che continua acrescere».
Quando è nata la sua passione per lanarrativa poliziesca?
«A 16 anni fui testimone di un crimineche mi portò a contatto con l’affascinantemondo dei commissariati di polizia.Un’esperienza che impressionò molto lamia giovane psiche, spingendomi ad iden-tificarmi col poliziotto buono. Oltre aChandler, le mie muse sono Ross Macdo-
nald, Joseph Wambaugh e i miei genitori».Sono stati loro a incoraggiarla? «Papà era un artista mancato. Dopo aver
frequentato la prestigiosa University of theArts di Filadelfia sognava di diventare pit-tore ma per sfamare la famiglia fu costrettoa mettere i sogni nel cassetto. Quando sep-pe che volevo fare lo scrittore mi ha appog-giato incondizionatamente ma è morto pri-ma che il mio primo libro fosse pubblicato.Oggi sarebbe orgoglioso e sorpreso delmio successo quanto lo sono io che ho ini-ziato a scrivere per passione, non certo perarricchirmi. Il destino è stato benevolo conme: alcuni dei miei 5 fratelli hanno moltopiù talento di me ma il mondo non li cono-sce».
Che ruolo ha svolto sua madre? «Era un’avida lettrice di gialli che mi ha
trasmesso l’amore per la letteratura hardboiled e fino alla morte fu sempre la primaa leggere i miei libri. Oggi il compito spettaa mia moglie Linda, pilastro della famiglia.Il prossimo aprile festeggeremo 30 anni dimatrimonio».
Come mai nessuno dei suoi romanzi èambientato in Florida, dove lei vive da quando aveva 12 anni?
«Pur essendo patria di grandissimi gial-listi, il Sunshine State non m’ispira. M’in-namorai di Los Angeles senza mai averci
messo piede prima attraverso Chandler, epoi grazie ai tanti libri e film ambientatinella Città degli Angeli negli anni Settantae Ottanta, come Il lungo addio di RobertAltman. Ancora oggi sogno di risvegliarminei panni di Marlowe».
È Marlowe che l’ha spinta a trasferirsia Los Angeles?
«Nel 1986 fui nominato per il Pulitzer in-sieme ad altri due giornalisti del “Fort Lau-derdale News” per un reportage sull’inci-dente del volo Delta 191. La notizia attirò l’attenzione del “Los Angeles Times” che,l’anno dopo, mi assunse come reporter dinera e per il quale seguii la drammatica vi-cenda di Rodney King».
Si è occupato anche del caso O.J. Simp-son?
«Accadde un mese dopo il mio addio uf-
ficiale al “Times”. Dalla mia casa in cima al-la collina godevo di un panorama fantasti-co della città e ricordo ancora come, alla vi-sta degli elicotteri che inseguivano la Bron-co di O.J., mi sentii felice di non essere neipanni del mio successore. Tornai a dedi-carmi a L’ombra del coyote, il preferito tra imiei libri perché il primo scritto come au-tore full time».
La sua attività di giornalista ha in-fluenzato quella di scrittore?
«Il giornalismo mi ha insegnato tutto:l’attenzione per i dialoghi, l’etica del lavoroche ti vieta di avere insulsi blocchi delloscrivano. Anche oggi scrivo tutti i giorni enon mi sognerei mai di mettermi a fumarela pipa guardando fuori dalla finestra incerca d’ispirazione. Il mio stile è molto di-verso dagli autori col phD in scrittura crea-
FascinazioniA sedici anni sono stato testimone di un crimine
che mi ha portatoa contatto con il mondo
dei commissariati di polizia
SSS
di MARCO ROSSARISSS
Scrittore e traduttore, nato a Milano nel 1973. Laureato con una tesi su Charles Bukowski. Il suo ultimo libro è L’unico scrittore buono è quello morto (e/o, 2012)
Mattina e sera percorro il vagone. Mi guardo intorno con calma. Uomini ipnotizzati dal display del cellulare, adolescenti coperti d’acne.La signora con la borsa firmata? No. Avanti.Giro sempre in giacca e cravatta: il decoromi aiuta a restare un’ombra. Due vecchietti.La cinese che dondola in preda a un colpo di sonno? La ragazza in tuta con l’iPod? No. Più
avanti. Sono il maschio minimo,il contrattempo squallido della giornata.«Indovina cosa m’è successo oggi?» Poi…Una biondina trasognata: gli occhiali,le unghie mangiucchiate, un berretto sciatto.Lei. Se si volterà di scatto, troverà il vuotoche sono.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’INEDITOUn romanzo
di cento parole
L’uomo che prendeva il metrò
CriticiMi sembra legittimo
che vengano ignorati autori di successo per dare
spazio a ignoti che hanno bisogno di farsi conoscere
SSS
Il brano
Avevo una ragione, per
tornare in ufficio. Un espresso che
conteneva uno scontrino color arancio doveva
esser già arrivato a destinazione,
ormai. La maggior parte delle finestre
del palazzo erano buie, ma non
tutte. In parecchi mestieri, oltre al mio, si lavora di
notte. L’uomo dell’ascensore tirò
fuori un «salve» dal fondo della
gola, e mi portò al mio piano. Nel
corridoio c’erano varie porte aperte, illuminate, dietro
le quali le donne di servizio stavano
ancora spazzando i detriti delle ore
perdute. Voltai l’angolo,
accompagnatodal ronzio
bavoso d’un aspirapolvere
entrai nell’ufficio buio e apersi
le finestre.
SSS
Raymond ChandlerLa sorellina (Feltrinelli, 1989,
traduzione di Ida Ombonicapitolo 13, pagina 78)

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 11
Il grande autore che sfidòle femministe: orgoglio macho
Mailer e quella sua artedi litigare con le donnedi LIVIA MANERA
Biografie
S ono cambiati gli scrittori america-ni. I vecchi leoni ormai sepolti co-me Mailer, Styron, Jones, Hemin-gway e Cheever erano anime tor-mentate che bevevano, si drogava-
no, andavano in guerra, andavano a donnee facevano a cazzotti, ma scrivevano libri ri-bollenti di energia che facevano girare latesta ai lettori. La generazione che li ha so-stituiti ha messo gli alcolici e le sigarettesotto chiave, beve acqua minerale, ha im-parato a scrivere nelle pettinate colonie perartisti e vive a un tiro di schioppo dalle co-stose università dove insegna corsi di scrit-tura creativa. Molti sono medi, alcuni sonobravi, tutti sono secchioni.
È la prima cosa che viene in mente leg-gendo la nuova biografia Norman Mailer: adouble life (Simon & Schuster), in cui J. Mi-chael Lennon racconta la storia di un mo-stro di energia e protagonismo che si è bat-tuto nel Pacifico e nei bar di New York, hasposato sei donne e ne ha accoltellata una,ha avuto nove figli e una carriera politicaabortita, ha scritto una valanga di romanzidiseguali, saggi controversi, alcuni straor-dinari pezzi di New Journalism e varie pes-sime poesie, ed è stato il primo intellettua-le ad abusare dei media mettendosi i guan-toni ogni volta che c’era da attaccare in tvuna qualche convenzione. A volte era bril-lante, spesso ubriaco. Come quando nel ’71dopo uno scambio di battute al vetriolo colsuo arcinemico Gore Vidal in un talk showdi Dick Cavett che ha fatto epoca, se l’è pre-sa con l’amabile conduttore: «E lei perchénon legge le sue domande?», indicandogliun foglio di appunti sul tavolo. «E lei per-ché non prende quel foglio, lo piega, e se lomette dove non batte il sole?», gli risposeesasperato Cavett, con una battuta che an-cora gira su YouTube.
Oggi, se salta all’occhio un capitolo inquesta nuova biografia, è quello su Mailer ele donne. Non per l’harem di mogli e i 56riferimenti nell’indice alla voce «infedel-tà». O per il clamoroso episodio dell’accol-tellamento della seconda moglie AdeleMorales durante una lite a un party, ubria-chi fradici tutti. Ma piuttosto per il modogeneroso in cui Mailer si è battuto quandoè diventato il nemico numero uno del mo-vimento femminista degli anni Sessanta eSettanta.
Esponente della controcultura pre-fem-minista e sbruffone, si era cacciato nei guaida solo quando nel 1959 in Pubblicità perme stesso aveva scritto di avere apprezzato iprimi libri di Mary McCarthy e di CarsonMcCuller — più tardi avrebbe aggiunto Jo-an Didion, Iris Murdoch e Erica Jong — madi trovare la narrativa femminile illeggibi-le. «Al rischio di farmi alcune dozzine didevote nemiche a vita» aveva scritto con unclamoroso errore di valutazione, «trovo glieffluvi emanati dall’inchiostro delle donnesempre esili, vecchiotti, lesbicamente psi-cotici, zoppi, sgradevoli, alla moda, baroc-chi, maquillé o brillanti e nati morti». E aveva concluso che «un buon romanzierenon può fare a meno di avere almeno un po’ di palle». Perse la metà dei suoi lettori.
La resa dei conti sarebbe arrivata nel1971, quando accettò l’invito della rivista«Harper’s» a scrivere un saggio in cui ri-spondeva al Movimento di liberazione del-le donne, opponendosi alle idee di BettyFriedan che ne La mistica della femminili-tà aveva sostenuto l’assenza di differenzebiologiche tra i sessi. Una tesi sposata subi-to dall’omosessuale Gore Vidal, il quale inuna feroce recensione sulla «New York Re-view of Books» scrisse che Il prigionierodel sesso — il saggio di Mailer su «Harpe-r’s» — aveva lo stesso appeal di «tre giornidi flusso mestruale». Nella famosa resa deiconti alla Town Hall di New York nel 1971— rimasta negli annali come «Town Bloo-dy Hall» — contro Mailer, unico uomo sulpalco, c’erano quattro intellettuali femmi-niste tra cui Germaine Greer; e in platea Su-san Sontag, Cynthia Ozick e Betty Friedan.
«Quella sera mi sono venuti i capellibianchi», disse Mailer. Intelligente, bella esexy, la giovane autrice dell’Eunuco femmi-na Germaine Greer lo attaccò in pubblico eflirtò con lui in privato. Portarsi a letto Mai-ler dopo il dibattito faceva parte del gioco.Ma il poveraccio era a pezzi. Finì in un liti-gio e in un niente di fatto. Lo sbruffone cheper amore della battuta aveva detto in tv aun Orson Wells sottomesso: «Ma dai, Or-son, lo sai anche tu che le donne sono be-stiacce che andrebbero tenute in gabbia»,non riusciva a credere che una battuta po-tesse adombrare ciò che aveva scritto neisuoi romanzi. «Ho passato tutta la mia vitaa scrivere di uomini e donne e dei lorocomplicati rapporti», si sarebbe sfogato inun’intervista. «E ora le femministe stannouccidendo il mio conto in banca, il mio egoe la mia reputazione».
Per carità: Mailer era un macho fatto e fi-nito e se l’era andata a cercare. Ma nonsembra un caso che Joan Didion e Joyce Ca-rol Oates, le uniche a difenderlo la sera del«Town Bloody Hall», siano anche quelleche come autrici hanno resistito al tempo.Che cosa ci dice Mailer: a double life sulmondo di oggi? Che gli argomenti del Mo-vimento delle donne degli anni Sessanta eSettanta sono stati assimilati e superati.Che il maschilismo continua imperterritoin forme più subdole. Che ovunque le don-ne continuano a essere meno pagate e piùostacolate nella carriera. Che in America lapolitical correctness ha ottenuto importan-ti risultati nella difesa delle minoranze, maha messo fuori legge il senso dell’umori-smo. E che in Italia la cultura del maschiomedio è attestata a livelli da bunga bunga.
Lasciatecelo dire: meglio uno come Mai-ler che sbagliava clamorosamente ma era capace di pentirsi e di non sottrarsi al con-fronto. Soprattutto, meglio una battutacciache l’ipocrisia del maschilismo maschera-to. Quando a una cena a casa di Lillian Hell-man in onore della coppia di guru letterariLionel e Diana Trilling, Mailer, giovanescrittore agli esordi che aveva bisogno del-la loro approvazione, si rivolse a Diana Tril-ling dicendo «E che mi dici di te, f...a intel-ligente», la sua vicina sobbalzò sulla sedia.«Di certo attirò la mia attenzione» avrebbescritto la Trilling nelle sue memorie. «Di-ventammo subito amici». Altri tempi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
tiva. Penso alla prosa straordinaria di Den-nis Lehane che scrive romanzi polizieschima in maniera ben più forbita e letterariadella mia. Siamo le due facce della stessamedaglia».
In un articolo per il «Corriere della Se-ra», Lehane ha suggerito che lei è il nipo-te di Chandler, il quale a sua volta è figliodi Dashiell Hammett.
«Non merito un complimento simile. Lacrime fiction sta vivendo l’età dell’oro e i ta-lenti si sprecano. Penso a George Peleca-nos, a Lehane e agli sceneggiatori dietroshow televisivi come Breaking Bad, The Wire, I Sopranos e True Detective. Ci sonoscrittori bravissimi ma poco conosciuti co-me Michael Lister e P. G. Sturges. Per nonparlare delle donne: Gillian Flynn, PatriciaCornwell, Lisa Scottoline, Janet Evanovich,Alafair Burke».
Conosce la letteratura noir del restodel mondo?
«Quella made in Italy è straordinaria. DaCarlo Lucarelli, autore di Almost Blue, aGiorgio Faletti con Appunti di un venditoredi donne, ad Andrea Camilleri e il suo La-dro di merendine. Se i gialli italiani fosseropiù tradotti, sfonderebbero in America.Proprio com’è successo agli scandinavi: do-po il trionfo di Stieg Larsson adesso è il mo-mento di Jo Nesbø. Gli europei mi attrag-
gono perché non interferiscono col mioprocesso creativo. La giornata di Montalba-no è diametralmente opposta a quella delmio Bosch e quindi non può influenzarmi.Mi chiedo cosa pensano gli italiani di scrit-tori anglosassoni che scrivono del Bel Pae-se come Donna Leon e Michael Dibdin».
Anche Dan Brown ha scritto di Firenzein «Inferno».
«Non l’ho letto e non lo farò. Le opere diBrown sono come puzzle e i puzzle non miinteressano. Preferisco libri come Act ofWar di Jack Cheevers, quello su Jfk di Vin-cent Bugliosi e Lost in Shangri-La di Mi-tchell Zuckoff. Amo leggere Stephen Kingche frequento quando sverna in Florida.Tra noi non esiste rivalità perché i nostrilettori sono talmente tanti e insaziabili chec’è spazio per tutti».
Che cosa pensa di James Patterson edella sua abitudine di avvalersi di colla-boratori per i suoi libri?
«È facile denigrare e attaccare Pattersonma nessuno è riuscito ad eguagliare il suonobile traguardo: avvicinare ai libri milionidi persone che altrimenti non leggerebbe-ro».
Chi preferisce tra John Grisham e ScottTurow?
«Quest’ultimo, perché ama i dettagliquanto me. In realtà Turow e Grisham sonoentrambi miei maestri, da loro ho impara-to moltissimo ben prima di iniziare questomestiere. Da piccolo ho letto anche AgathaChristie e Dashiell Hammett. Will Graham,protagonista de Il delitto della terza luna diThomas Harris, ha avuto un effetto ipnoti-co su di me».
Perché i romanzi polizieschi sonospesso ambientati nelle grandi città?
«Sono il luogo dove confluiscono disu-guaglianze sociali, corruzione, crimine edove sogni infranti e realizzati coesistono:una miscela potenzialmente esplosiva. Tut-to ciò è ben visibile a Los Angeles, città col-linosa dove si sale e si scende e dove dal pa-radiso puoi ritrovarti tra le fiamme dell’in-ferno. Proprio come in un quadro di Bosch.All’università passammo settimane a di-scutere i suoi quadri e quando potei per-mettermelo andai a vederli al Museo delPrado di Madrid e al Palazzo Ducale di Ve-nezia. Chi conosce Bosch comprende l’omonimia col mio detective».
Se Los Angeles è la sua musa perchépreferisce guardarla da lontano?
«Ho scelto Tampa affinché mia figliacrescesse vicino ai suoi quattro nonni eperché posso chiudermi in casa a scrivere,lontano dalle distrazioni. Quando lavoro,copro le finestre con tende nere, nascondogli orologi e bevo 15 litri di the freddo allasettimana. Ai party ci vanno i romanzieri difiction, non quelli di noir come me. Io poisono un tipo poco festaiolo».
Le donne apprezzano il genere polizie-sco quanto gli uomini?
«Molto di più. Sugli aerei gli uomini leg-gono manuali su come fare carriera, ledonne romanzi psicologici, molti dei qualipolizieschi. Le statistiche confermano ciòche vedo viaggiando molto».
Eppure la critica spesso snobba il vo-stro genere.
«Anche se i miei libri continuano ad es-sere recensiti dal “New York Times” e dal“Washington Post” ritengo legittimo cheun critico ignori scrittori di successo perdedicarsi a ignoti che hanno bisogno delloro aiuto per farsi conoscere. E comunqueil pubblico, l’unico che conti davvero, sabene che la detective fiction è l’unica che ri-specchia la realtà contemporanea, offren-do uno spaccato dell’America vera di oggi».
@afarkasny© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il romanzoIl quinto testimone
di Michael Connelly(traduzione di Mariagiulia
Castagnone, Piemme, pagine490, e 19,90) sarà in libreria
martedì 25 febbraio.Michael Connelly, nato a
Filadelfia il 21 luglio 1956,è ritratto in queste pagine nelsuo splendido appartamento
newyorchese affacciatosu Central Park (servizio
fotografico di DION OGUST)
i
J. MICHAEL LENNONNorman Mailer: a double life
Simon & SchusterPagine 961, $ 40
A sinistra: Norman Mailer(1923-2007) con la seconda
moglie Adele Morales
i

12 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Di origini inglesi, Louise Caico Hamilton (1861-1927) visse un periodo della sua vita a Montedoro (Caltanissetta), paese del marito, lasciando una straordinaria testimonianza fotografica della Sicilia dei primi
dell’Ottocento. Caltagirone la celebra con la mostra Sicilian Ways and Days fino al 23 marzo presso la Galleria Luigi Ghirri: 36 foto documentano usi, costumi e ritratti del tempo visti con gli occhi di una protofemminista.
Una Sicilia come non se ne fanno più
{Caratteri RecensioniScatti flessibili
di Fabrizio Villa
Secondo Vittorino Andreoli i ruoli si capovolgono, confondendosi È necessario rifondare i legami sul bisogno dell’altro, che li rafforza
Chi è padre di chi? Chi è figlio di chi?Serve un umanesimo della fragilità
Psicologia
di ANTONELLA LATTANZI
AlefBet
di Daria Gorodisky
ISRAEL ZANGWILLE L’ARTE SOTTILEDELLO «SCROCCO»
C entocinquanta anni fa nasceva aLondra da una famiglia povera diimmigrati russi Israel Zangwill, il
più attento e divertente narratore del mondo ebraico dell’East End londinese acavallo fra il XIX e il XX secolo. La sua cifra di scrittore mette insieme cronaca, humour, satira sociale, passione politica, acume oratorio, modernità, brillantezza, sentimento, grande cultura, raffinata comprensione della psiche umana (il figlio Oliver Louis sarà un influente professore di psicologia a Cambridge fino al 1987). Il successo arriva subito quando, a 28 anni, stampa la prima raccolta di racconti Children of the Ghetto, tradotto in tutto il mondo ma purtroppo mai integralmente in italiano. Mentre è ben conosciuto anche da noi il romanzo capolavoro di umorismo ebraico Il re degli schnorrer (Marietti). (Che cos’è uno schnorrer? Complessa parola yiddish di difficile traduzione, indica un appartenente alla mitica categoria comica degli artisti dello scrocco; però attenzione: qui si intende chi scrocca senza mai mendicare ma usando l’ingegno, chi lo fa non per sopravvivere bensì per vivere con la grandiosità che un animo aristocratico esige!). Zangwill è autore molto prolifico. Scrive diverse raccolte di short stories, testi teatrali, il diario di viaggio Italian Fantasies, saggi, articoli, ritratti di figure storiche caratterizzate come lui dal dualismo fra tradizione ebraica e richiami dell’ambiente esterno:da Benjamin Disraeli a Heinrich Heine, da Ferdinand Lassalle a Baruch Spinoza. Inoltre Zangwill è grande inventore letterario, perché gli si deve — oltre all’espressione ormai internazionale melting pot — il primo vero esempio di giallo «della camera chiusa», dove un delitto viene commesso appunto in un luogo inaccessibile: è Il grande mistero di Bow (riproposto da Polillo). Geniale, arguto, Zangwill partecipa attivamente alle grandi battaglie ideali della sua epoca (lui morirà nel 1926) sostenendo il suffragio femminile e il pacifismo. E restando sempre a fianco del suo popolo. È stato lui a dire che, se gli ebrei non ci fossero, andrebbero inventati «ad uso dei politici» in quanto «causa garantita di ogni male». E, se a «ebrei» si aggiunge «Israele», il sarcasmo zangwilliano non potrebbe essere più attuale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Stile UUUUU
Rigore scientifico UUUUU
Copertina UUUUU
VITTORINO ANDREOLIL’educazione (im)possibile
RIZZOLIPagine 216, e 18,50
i
I n principio erano i genitori, due figu-re atte, attraverso la mediazione diuno spirito che rendeva fertile la don-na, a generarne una terza. Poi, dieci-mila anni fa, la scoperta dell’agricol-
tura portò alla diversificazione dei ruoli:uno dei genitori divenne molto più poten-te dell’altro. Nacque il pater, maschio, chefaceva le veci di Dio e come lui «possede-va» la donna; unico detentore del patrimo-nio che lasciava in eredità al primogenito:maschio come lui. La «religione del pa-dre» sembrava indistruttibile. Ma il Ses-santotto vide i figli ribellarsi; il padre vacil-lava, e con lui barcollavano i ruoli e s’inver-tivano le domande: quali i doveri dei padriverso i figli?
Lo racconta lo psichiatra Vittorino An-dreoli in L’educazione (im)possibile, in-terrogandosi su padri, figli e sull’educazio-ne, dunque sulla società; dalla nascita deigenitori a quella dei padri ai nostri giorni,passando per Dea Madre, Positivismo eUmanesimo, famiglia, scuola e web, cer-cando di capire come e se sia ancora possi-bile educare. Cioè «insegnare a vivere inun mondo così vasto, così mutevole da ri-dursi a mistero. Educare un figlio miste-rioso a vivere dentro un mondo incom-prensibile».
Ci sono libri che anticipano le domandedegli uomini, altri che provano a indicareuna strada. È questo il caso del saggio diAndreoli, partorito in un momento in cuipadri e figli sono protagonisti delle storiecome della cronaca. Per esempio nel filmNebraska di Alexander Payne, in cui un fi-glio adulto accompagna il vecchio padre lungo territori in bianco e nero, verso unameta tanto illusoria quanto futile (una fal-sa vincita alla lotteria), ma molto più versoil traguardo scivoloso e instabile delle rela-zioni parentali: l’accettazione della morali-tà, degli ideali e del modo di vivere di chi ciha generato. O ne Gli sdraiati di Michele Serra, romanzo d’amore e d’ironia, di rab-bia e smarrimento tra padri e figli adole-scenti. O in Breaking Bad, serie tv cult ide-ata da Vince Gilligan in cui Walter, profes-sore di chimica padre di un ragazzo affettoda handicap, scopre che sua moglie aspet-ta la loro secondogenita proprio poco pri-ma che a lui venga diagnosticato un can-cro, mentre la situazione finanziaria dellafamiglia precipita. Dopo l’incontro con unex studente (una sorta di figlio altro?),Walter decide di usare le proprie compe-tenze per produrre metamfetamina di altaqualità, in modo da riacquistare — o con-quistare — il ruolo di capofamiglia, o me-
glio capobranco; oltre che di uomo. O ancora nella cronaca: è di queste setti-
mane la notizia che anche Palermo, dopoBologna, si apre agli affidamenti per lecoppie omosessuali.
In comune c’è il disordine dei ruoli, chesi sgranano sino a scomparire o ribaltarsi,confondersi: il padre di Breaking Bad as-sume comportamenti da adolescente ri-belle; il figlio di Nebraska si fa anche padreputativo che accompagna il proprio geni-tore (un vecchio figlio?) nel viaggio alla scoperta di sé; i padri de Gli sdraiati han-no bisogno dei figli per tentare di capire ilmondo — come fossero figli loro stessi.
Per Andreoli la confusione dei ruoli creaun’educazione confusa in cui padri e figlisi perdono, affogati da una crisi economi-ca e psicologica perenne che ingrassa lapolitica arraffona e strappa ai figli non solola speranza, ma pure la capacità d’immagi-nazione di un futuro. La storia contempo-ranea fa da reagente: a contatto con la real-tà il rapporto padre/figlio esplode e si pol-verizza. Perso il ruolo patriarcale, l’uomo sipercepisce ed è percepito sempre meno necessario e forte. Oscilla dal maschio li-berato che ha imparato a piangere all’uo-mo-eterno-figlio che piange troppo, dinuovo all’uomo-padrone che se non rico-pre un ruolo di maggior potere rispetto al-la sua donna perde l’orientamento e crolla,o sviluppa verso di lei una rabbia travol-
gente fino ad accusarla del proprio falli-mento. Nel momento in cui la legge sanci-sce — finalmente — che due padri posso-no fare una famiglia, come capire che pa-dre si vuole diventare, se non si ha idea diche uomo si è o si vuol essere?
Per Andreoli la risposta è la fragilità; ac-cettarla come attributo positivo vuol dire «fondare una civiltà che risponda all’uo-mo fragile, cioè a un uomo che (...) ha ne-cessità dell’altro». Un’educazione è possi-bile dunque, secondo Andreoli, solo riedi-ficando i legami d’amore, di amicizia, finoad arrivare a scuola, politica e società —Padre per eccellenza — su un «umanesi-mo della fragilità».
Mi torna in mente il Philip Roth di Patri-mony, storia vera della lunga malattia e poimorte di suo padre: «Se non nei miei librio nella mia vita, almeno nei miei sogni sa-rei vissuto in eterno come il suo figlio pic-colo, con la coscienza di un figlio piccolo,proprio come lui sarebbe rimasto vivo nonsoltanto come mio padre ma come il pa-dre, per giudicarmi qualunque cosa io fac-cia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sopra: Stephan Hillerbrand e Mary Magsamen, Our practise (2013): i due artisti texani noti come «Hillerbrand + Magsamen», marito e moglie nella vita, si sono ritratti con i figli per questo lavoro sulle nuove famiglie
Noir Il romanzo di Lorenzo Beccati, autore di «Striscia la notizia» e «Paperissima»
Genova, 1601. La rabdomante indagadi MARISA FUMAGALLI
D a tempo Lorenzo Beccati,genovese di periferia (è na-to a Cornigliano 58 anni or
sono), cittadino di Alassio ma datre decenni abitante a Milano 2per motivi di lavoro, regala al suopubblico, che forse non coincidecon i fan di Striscia la notizia e diPaperissima, libri avvincenti, ori-ginali. I cui protagonisti soventeriemergono da mondi passati,quasi in contrasto con la realtàquotidiana odierna, fatta di torti,soprusi, ordinari disservizi e altro,denunciata e portata sotto i riflet-tori dal suo giustiziere preferito, ilGabibbo: deus ex machina di Stri-scia, il programma di Antonio
Ricci, del quale Beccati è il primocollaboratore-amico.
In verità, anche la figura centra-le del suo ultimo romanzo noir,Pietra, povera, cenciosa ma affa-scinante, dotata di fine intuito femminile scambiato per rabdo-manzia (e a lei sta bene così), èuna giustiziera. Di altra epoca,certo. Siamo ai primi del Seicento,nel ventre di Genova, tra carruggi,piazze, fontane, palazzi nobiliari,giardini in rovina. Città familiareall’autore, segnata dai chiaroscuridei marmi e dell’ardesia. In questoambiente gotico, sfuggente, bentratteggiato negli elementi natu-rali e nelle atmosfere, talvolta
granguignolesche, si aggira la gio-vane orfana, detta la «Tunisina»;soprannome riconducibile a una drammatica parentesi di vita nelPaese nordafricano. È temuta e di-sprezzata, Pietra. Eppure utile ai genovesi per i suoi particolari ser-vigi. Guidata, solo in apparenza,dalla bacchetta di legno biforcutae flessibile, riesce, infatti, a trova-re bimbi scomparsi, acque sorgi-ve, a recuperare gioielli rubati.
Pietra è il mio nome s’intitola ilnoir di Beccat i . Ed è anchel’espressione ricorrente sulle lab-bra della protagonista quando in-tende suggellare il compimento diogni «buona» azione. Si dà il caso,
dunque, che nel 1601, durante lafrenesia carnevalesca che non ri-sparmia la città neppure da un ter-ribile incendio — e tra le fiammela giovane si getta, su commissio-ne, riportando alla madre, la con-tessa de Negri, il pargoletto vivo— venga ritrovato il cadavere diuna donna, picchiata a morte. Ac-canto, la bacchetta da rabdoman-te.
Qui, Pietra diventa la principaleindiziata dell’omicidio. E qui si èconsumato il primo delitto di unaserie che dovrebbe chiudersi conl’uccisione di lei, la «Tunisina»,ultima vittima predestinata. Pietralo intuisce ben presto. Quindi, in-daga, scavando anche tra i fanta-smi del passato, con l’abilità di undetective provetto e quella marciain più che possiede per incastrarel’insospettabile assassino. Riesce,infine, a dimostrare la sua inno-cenza e a sfuggire alla morte met-
tendo in campo non solo l’arguziama sprigionando una forza gigan-tesca che la rende invincibile.
L’abilità, la potenza e la tenutanarrativa di Beccati sono fuori di-scussione. Pur se convincono unpo’ meno le pagine digressive cheaffrontano il periodo tunisino del-la storia. Dettaglio trascurabile,però. La figura di Pietra, emanci-pata ante litteram con i mezzi a di-sposizione nel suo tempo, com-preso quello di lasciarsi conside-rare una strega, è davvero il piattoforte del romanzo. Siamo di fronteal ritratto geniale di una donna to-sta, avventurosa, ribelle, fragile edura insieme. Sfida vinta, Pietra èil mio nome. E per riprendere il giudizio di Giorgio Faletti, collegadell’autore: «Beccati è uno che sache cosa vuol dire scrivere. Questolibro dimostra che cosa vuol direleggere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Lorenzo BeccatiPietra è il mio nome
NORDPagine 312, € 14,90

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 13
Dziga Vertov negli anni Venti progettava un nuovo linguaggio per il cinema, il cine-occhio come superamento del punto di vista del singolo autore. L’uomo con la macchina da presa: global remake riprende scena per scena il suo famoso
film del ‘29, ma il girato proviene da filmmaker di tutto il mondo. Ogni giorno un programma ad hoc lo combina in modo diverso, creando un nuovo film. L’idea di cinema di Vertov ripensata nell’era di internet (dziga.perrybard.net).
L’occhio globale dell’uomo-cinepresa
{Caratteri RecensioniDocumenta
di Chiara Campara
Stile UUUUU
Storia UUUUU
Copertina UUUUU
GIUSEPPE CATOZZELLANon dirmi che hai paura
FELTRINELLI, pp. 236, € 15
iQ uella raccontatada Giuseppe Ca-tozzella in Nondirmi che hai pa-ura è la s toria
d’una grande passione ed’una sconfitta. La storiad’un grande sogno sconfittodalla follia umana che ha ilvolto dell’integralismo, do-po esser sopravvissuto al-l’idiozia del razzismo etnico-sociale. Ma è anche la storiadi amicizie salde, tra fami-glie che decidono di condi-videre il poco spazio abitati-vo vivendo nel segno d’unasalda fraternità a dispettodell’odio tra i rispettivi clandi appartenenza. Ed è pure lafotografia d’una nazione,riassuntiva di tante analo-ghe situazioni, nelle qualigiovani come Samia e il suocompagno di giochi Alì ve-dono infrangersi i propri so-gni.
Perché è soprattutto lastoria d’un sogno che il de-stino ha voluto infrangere,nella realtà, un 2 aprile 2012;anche se nel romanzo Catoz-zella ha purtroppo deciso difarlo realizzare, quasi a com-pensare quanto la sorte nonha voluto, chiudendo il rac-conto con due pagine da fi-nale positivo davvero ditroppo, anziché fermarsi suimmagini da dissolvenza delsogno mentre il mare in-ghiotte la protagonista, o ar-restarsi nel momento dellafine di lei.
Perché la Samia di Nondirmi che hai paura — titoloripreso dalle continue esor-tazioni di suo padre — èdavvero esistita: morta allavigilia della possibilità diconcretizzare il suo sogno,mancando la fune dei soc-corritori al momento dell’ar-rivo nelle acque di Lampe-dusa su una delle note car-rette del mare. È la storiad’una bambina nata per cor-rere, in una Mogadisciomartoriata dagli integralistidi Al-Shabaab, in cui per lalegge coranica sempre piùrestrittiva nulla si deve muo-vere: uno scricciolo, «magracome un’acacia appena
piantata e con due gambineche sembravano ramoscellidi ulivo», che coltiva il so-gno, nato in lei a otto anni,di poter partecipare alleOlimpiadi, nel quale includeanche l’aspirazione del ri-scatto delle donne dell’Afri-ca e della sua Somalia deiclan.
Ed è la storia anche di unafraterna amicizia con Alì, uncoetaneo che, cosciente del-la sua inferiorità nella corsa,decide di farsi allenatore diSamia, portandola a vinceregare locali e nazionali, riu-scendo alfine — tra difficol-tà economiche e sociali, ri-
trovandosi negli allenamen-ti a dover correre «con il bur-qa calcato in testa e sotto lafascia elastica di spugna chesi impregnava di sudore»,inciampando di continuo inquella «impalcatura nera»— a qualificarsi a 17 anni perle gare dei 100 e 200 m al-l’Olimpiade di Pechino. Cer-to, arrivando ultima, ma co-sciente del valore simbolicodi quella partecipazione, colsogno di vincere alla Olimpi-ade di Londra del 2012. Unsogno coltivato con ostina-zione, per il quale — anchein seguito alla rivelazione daparte di Alì, arruolatosi tra
Giuseppe Catozzella racconta la storia della ragazza somala che corse all’Olimpiade di Pechinoe morì cercando di attraversare il Mediterraneo. Ma la tradisce (purtroppo) nella conclusione
Il sogno di Samia non può avere un lieto fine
Narrativa
di ERMANNO PACCAGNINI
gli integralisti, d’esser statocomplice nell’uccisione pu-nitiva del padre di lei, peraver insegnato ai figli, e inparticolare a Samia per lacorsa e a sua sorella Hodanper il canto, il valore della li-bertà delle scelte — lascia lasua terra per Addis Abeba,onde potersi meglio allena-re. Sino alla scelta estrema dicorrere il rischio della vitaper poter correre a Londra.Ed è il Viaggio, attraversoSudan, Sahara, Libia e Medi-terraneo, verso la terra pro-messa di Lampedusa, giàsperimentato e felicementecompiuto da Hodan ora mo-glie e madre in Finlandia; ilgrande buco nero del so-pravvivere da parte di mi-granti insultati come tahrib(clandestini) e hawaian(animali) dagli avidi mer-canti di carne.
Un racconto che Catozzel-la, raccogliendo varie testi-monianze, tra cui quella diHodan, ha scelto di rievoca-re con la voce narrante di Sa-mia. Una scelta davvero feli-ce sin quando egli si tienedentro il suo personaggio:quando cioè vive la dimen-sione del sogno della corsa edella vittoria dentro la real-tà, come nella prima parte; eanche in vari momenti delViaggio, quando sono so-prattutto gli occhi interni anarrare emozioni, scora-menti, lotta con la avvolgen-te paura; e pure in certi mo-menti verso la fine (conclu-sione ovviamente esclusa).Si ha allora una scrittura lie-ve, candida, in cui commo-zione e pudore si equilibra-no fra levità poetica e inten-sità (pur con qualche cadutadi stile in espressioni da par-lato, e certi quadri cinema-tografici sia nei momentid’attraversamento del Saha-ra, come pure, prima, nellecomparse dei miliziani inte-gralisti).
Più altalenante quindi lascrittura del Viaggio, in cuimomenti di commozione sialternano ad altri più piatti.Pregnante quando la voceguarda dentro sé o si rap-porta ai compagni di viag-gio, si tratti della nuova ami-ca Nigist, della zia ritrovata,come pure degli anonimiautori di lettere mai speditedai migranti, trovate nellacasa prigione di Tripoli. Piùordinaria, quasi anonima,descrittiva quando lo sguar-do si fa circostanziato sul-l’esterno, soffermandosi sul-l’inferno sudanese e libico,in cui a prevalere è allora ilCatozzella giornalista e auto-re di romanzi-inchiesta.
Un racconto amaramenteemozionante, grazie a figurevive, come quelle di Alì colsuo isolarsi in cima a un eu-calipto nei momenti tristi,della mite madre, del saggiopadre e dei fratelli e sorelledi Samia, in particolare Ho-dan, e del padre di Alì.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Samia Yusuf Omar dopo la gara dei 200 m a Pechino (Ap)
AdolescenzaIl bianco e nerodi un’etàe i suoi colori Che colore ha l’adolescenza? Luccica quella di Geek Girl di Holly Smale (Il Castoro, pp. 330, e 15.50, da 11 anni). È gialla, a tinte cupe, in L’estate del coniglio nero di Kevin Brooks (Piemme, pp. 420, e 15, da 14 anni). L’adolescenza per chi la sta vivendo è un raccontoin bianco e nero. Come il Diario di un’autolesionista della 14enne Carla Torchia (Intento, pp. 134, e12,50, da 12 anni).
Severino Colombo

14 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Mister Scoop batte il dottor Sleep: in vetta il «Gattopardo» di Friedman Clara Sánchez e i braccialetti di Espinosa: le novità sono targate Spagna
La pagellaFrancesco Guccini Nuovo Dizionario delle cose perdute Mondadori
di Antonio D’Orricovoto
7,5La serenità di Gucciniun Proust a 45 giri
Q ualcuno di voi ricorda la pistolaSusanna? Qualcuno di voi sa direla differenza tra la Collamidina ela Gomma arabica? Qualcuno divoi ha mai bevuto o visto bere
l’infuso di fungo cinese? Qualcuno di voi sa dire la differenza tra la merenda e le merendine? Qualcuno di voi ha mai fatto merenda con lo zabaglione (o uovo sbattuto) corretto al marsala? Qualcuno di voi sa spiegare che cos’era un deflettore? Qualcuno di voi ha mai visto un’autoradio estraibile? Qualcuno di voi ha mai visto e sniffato (erano profumatissimi tanto da marchiare indelebilmente i turbinati del naso con la loro misteriosissima e persistentissima essenza) un calendarietto dei barbieri? E, rimanendo in barberia, qualcuno sa dire a che servivano le schedine della Sisal scadute? Qualcuno di
voi ha mai battuto untesto a macchina?Ancora più difficile:qualcuno di voi ha maibattuto un testo amacchina usando foglidi carta carbone?Qualcuno di voi sapreparare una idrolitina(prima la bustina rossao la blu?) come Dio e ilCavalier Gazzonicomandano? Qualcunodi voi ha mai fatto
l’autostop? Qualcuno di voi ha mai preso a bordo qualcuno che faceva l’autostop? Qualcuno di voi ha mai riflettuto sul fatto che una volta, andando in automobile, capitava frequentemente di vedere uno (o una, più raramente) che allungava il pollice per chiedere un passaggio, mentre oggi capita frequentemente di vedere uno (o una, e nemmeno raramente) che allunga il dito medio per avanzare tutt’altra richiesta? E se ci ha riflettuto a che conclusioni generali è pervenuto? Nella classifica dei libri dominano, questa settimana come tutte le altre settimane (per omnia saecula saeculorum), racconti di ammazzamenti, di spettri, di autopsie, di malattie, di padri che ce l’hanno con i figli, di banchieri che truffano i correntisti... E poi, per fortuna, c’è un libro sereno. Che è questo di Guccini. Un Proust a 45 giri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesco Guccini, 73 anni, modenese
Top 10Alan FriedmanAmmazziamoil gattopardoRizzoli, € 18
Stephen KingDoctor Sleep
Sperling & Kupfer, € 19,90
Patricia CornwellPolvere
Mondadori, € 20
Giampaolo PansaBella ciao
Rizzoli, € 19,90
Clara SánchezLe cose chesai di me Garzanti, € 18,60
Michele SerraGli sdraiati
Feltrinelli, € 12
Lucia VaccarinoII mio diario, un anno dopo. Violetta Walt Disney, € 14,90
Luis SepúlvedaStoria di una lumaca che scoprì...Guanda, € 10
Francesco GucciniNuovo dizionario delle cose perduteMondadori, € 12
Albert EspinosaBraccialetti rossi Salani, € 12,90
1(-)
N 100
2(1)
5 79
4(-)
N 49
5(-)
N 48
7(3)
5 44
9(8)
5 35
10(-)
N 35
8(6)
5 36
6(4)
5 45
3(2)
5 53
ebookdi Alessia Rastelli
Al comando i titoli dell’impegno Storia e politica. I titoli impegnati conquistano la classifica digitale. Ammazziamo il gattopardo, l’analisi della crisi italiana del giornalista americano Alan Friedman (dal 12 al 16 febbraio al prezzo di lancio di 6,99 euro), si aggiudica il primo posto su Ultima Books. Ovvero il negozio di libri elettronici della società Simplicissimus. Che, tuttavia, dal primo gennaio,dopo un cambiamento di strategia di Mondadori, non vende più gli ebook del gruppo di Segrate. La controstoria della Resistenza di Giampaolo Pansa, Bella ciao, occupa la quarta posizione. Quinta, laraccolta di articoli scritti tra la primavera del 2012 e oggi, Piccolo spaccato italiano. L’ebook è stato curato da Antonello Siti (pseudonimo di Antonio Tisi), che lo ha pubblicato con Narcissus.me, la piattaforma di self-publishing di Simplicissimus. Di diverso genere e argomento gli altri due libri nella Top Five. Al secondo posto il bestseller di Luis Sepúlveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, favorito anche dalla promozione l’11 febbraio a 1,99 euro. In terza posizione, il fantasy dell’americana Sherrilyn Kenyon, Il lato oscuro della notte.
@al_rastelliehibook.corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1 100 Alan FriedmanAmmazziamo il gattopardo
Rizzoli, e 9,99ePub con Adobe DRM
2 94 Luis SepúlvedaStoria di una lumaca...
Guanda, e 6,99ePub con Adobe DRM
3 86 Sherrilyn KenyonIl lato oscuro della notte
Fanucci, e 3,99ePub con Social DRM
4 80 Giampaolo PansaBella ciao
Rizzoli, e 9,99ePub con Adobe DRM
5 74Antonello Siti ( a cura di)Piccolo spaccato italiano
Narcissus.me, e 1,99ePub con Social DRM
(10-16 febbraio 2014)
La classifica
Narrativa italiana
1 (1) S 45 Michele SerraGli sdraiati
Feltrinelli, € 12
2 (3) 1 35Francesco GucciniNuovo dizionario delle cose perdute
Mondadori, € 12
3 (4) 1 29Fabio VoloLa stradaverso casa
Mondadori, € 18
Michele Serra perde due posizioni in top ten ma conserva la vetta negli Italiani davanti a Guccini e Volo, entrambi in salita. Spazio ai titoli romantici: l’esordiente Virginia Bramati e la sua favola di amore e lavoro; e Moccia che racconta di un ragazzosedotto e abbandonato. Entra la storia toccante e vera — di malattia e coraggio — di Chamed.
Narrativa straniera
1 (1) S 79Stephen KingDoctor Sleep Sperling & Kupfer, € 19,90
2 (2)S 53Patricia CornwellPolvere
Mondadori, € 20
3 (3)S 48Clara SánchezLe cose che sai di me Garzanti, € 18,60
Clara Sánchez superstar: il suo nuovo romanzo, già Premio Planeta in Spagna, vale il quinto posto in top ten, mentre il precedente libro scala undici posizioni nella classifica degli Stranieri guidata da Stephen King ed è sesto. A sorpresa in salita Dan Brown, più cinque posti e rientro nella prima decina, e l’intera trilogia delle Sfumature.
Saggistica
1 (-) N 100Alan FriedmanAmmazziamoil gattopardoRizzoli, € 18
2 (-) N 49Giampaolo PansaBella ciao
Rizzoli, € 19,90
3 (1)535Albert EspinosaBraccialetti rossi
Salani, € 12,90
Le rivelazioni su Napolitano e Monti lanciano il libro di Friedman, subito diventato il titolo più venduto della settimana. Sono da top ten anche la «controstoria della Resistenza» di Pansa e la testimonianza dello spagnolo Espinosa (con i braccialetti della speranza). Tra le novità: Claudio Magris sul segreto e Monuments men, sui salvatori dei tesori d’arte nell’Europa nazista.
Varia
1 (1) S 31 John P. SloanEnglish da zero
Mondadori, € 15,90
2 (2) 1 11Andre AgassiOpen.La mia storia
Einaudi, € 20
Ragazzi
1 (1) S 44Lucia VaccarinoII mio diario un annodopo. ViolettaWalt Disney, € 14,90
2 (2) S 36Luis SepúlvedaStoria di una lumaca che scoprì...Guanda, € 10
{Caratteri Le classifiche dei libriLegenda
(2) posizione precedente S stabile
1 in salita R rientro
5 in discesa N novità
100 titolo più venduto (gli altri in proporzione)
3Anna QuindlenStill life with bread crumbs
Random House, $ 26
2Sue Monk Kidd The invention of wings
Viking, $ 27,96
1Donna Tartt The goldfinch
Little, Brown, $ 30
Stati Uniti

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 15
4 (2) 5 27Marcello Fois (curatore)Sei per la SardegnaEinaudi, € 6
5 (7) 1 25Margaret MazzantiniSplendore
Mondadori, € 20
6 (5) 5 25AA.VV.Carnevale in giallo Sellerio, € 13
7 (6) 5 24Sara TessaL’uraganodi un batter d’ali
Newton Compton, € 9,90
8 (8) S 20Antonio ManziniLa costola di Adamo
Sellerio, € 14
9 (9) S 17Susanna Tamaro Illmitz
Bompiani, € 14
10 (10) S 15Chiara GamberalePer dieci minuti
Feltrinelli, € 16
11(11) S 13Alessia Gazzola Le ossadella principessa
Longanesi, € 17,60
12(-) N 13 Federico MocciaSei tu
Mondadori, € 16,50
13(12)5 12Mauro CoronaLa voce degliuomini freddi Mondadori, € 18
14 (13) 5 10Andrea CamilleriLa creaturadel desiderio
Skira, € 14,50
15(17) 1 10Virginia BramatiTutta colpadella neve! Mondadori, € 14
16(18) 1 10Massimo GramelliniFai bei sogni
Longanesi, € 14,90
17(15) 5 9Giuseppe CatozzellaNon dirmiche hai paura Feltrinelli, € 15
18(16) 5 8Gianrico CarofiglioIl bordo vertiginoso delle coseRizzoli, € 18,50
19(-) N 8ChamedSi è fermatoil cuore Newton Compton, € 9,90
20(14) 5 8Primo LeviSe questoè un uomo
Einaudi, € 11
4 (5)118Ronald H. BalsonVolevo solo averti accanto
Garzanti, € 14,90
5 (4)518Isabel AllendeIl giocodi Ripper Feltrinelli, € 19
6 (17)116Clara SánchezIl profumo delle foglie di limoneGarzanti, € 9,90
7 (9)115E. L. JamesCinquanta sfumature di grigio Mondadori, € 5
8 (14)115Dan BrownInferno
Mondadori, € 17
9 (11)114Valérie Tong CuongL’atelier dei miracoli
Salani, € 12,90
10(7)514Joël DickerLa verità sul caso Harry Quebert
Bompiani, € 19,50
11(13)114Tracy ChevalierLa ragazza con l’orecchino di perlaNeri Pozza, € 9,90
12(6) 5 14Georges SimenonI fratelli Rico
Adelphi, € 18
13(10) 5 14Khaled HosseiniE l’eco rispose Piemme, € 19,90
14(16)114E. L. JamesCinquanta sfumature di rosso Mondadori, € 5
15(8) 5 13Pierre LemaitreCi rivediamo lassù
Mondadori, € 17,50
16(15)513Guillaume MussoAspettando domani
Sperling & Kupfer, € 18,90
17(18) 1 13E. L. JamesCinquanta sfumature di nero
Mondadori, € 5
18(-)N13Rebecca DonovanUna ragione per amare
Newton Compton, € 9,90
19(12)5 12Ildefonso FalconesLa regina scalza
Longanesi, € 19,90
20(19) 5 12John GrishamL’ombra del sicomoro Mondadori, € 20
4 (-) N 15R. M. Edsel, B. WitterMonuments men
Sperling & Kupfer, € 16,90
5 (-) N 13Stefano LivadiottiLadri
Bompiani, € 16,50
6 (2) 5 12Vittorino AndreoliL’educazione(im)possibile
Rizzoli, € 18,50
7 (3) 5 12Martin SixsmithPhilomena
Piemme, € 18,50
8 (14) 1 11Mario BortolettoLa rivolta del correntista
Chiarelettere, € 10
9 (-) N 10Claudio MagrisSegreti e no
Bompiani, € 7
10(-) N 7Simone Cristicchi(con J. Bernas)Magazzino 18 Mondadori, € 16,50
11(11) S 7Aldo CazzulloBasta piangere! Storie di un’Italia...Mondadori, € 14,90
12(10) 5 6Don Andrea Gallo(con Vauro)Sopra ogni cosa
Piemme, € 15
13 (13) S 6Carlo RovelliLa realtà non è come ci appare
Raffaello Cortina, € 22
14(9) 5 6Nuccio OrdineL’utilità dell’inutile.Manifesto Bompiani, € 9
15(12) 5 6E. Berthoud, S. ElderkinCurarsicon i libri
Sellerio, € 18
16(4) 5 6Sam PivnikL’ultimo sopravvissuto
Newton Compton, € 5,90
17(6) 5 6Hannah ArendtLa banalità del male Feltrinelli, € 9,50
18(-) N 5Solomon Northup12 anni schiavo
Newton Compton, € 9,90
19(8) 5 5Mario CalabresiA occhi aperti
Contrasto, € 19,90
20(17)5 5Malala Yousafzai(con C. Lamb)Io sono Malala
Garzanti, € 12,90
3 (-) R 11M. De Donno, G. Navone L. LorenzoniInglese in 21 giorniSperling & Kupfer, € 12,90
4 (3)511Benedetta ParodiÈ pronto!Salva la cena...
Rizzoli, € 17,90
5 (4)58Jordan BelfortIl lupodi Wall Street
Bur, € 17
6 (8) 1 8Fabrizio CoronaMea Culpa
Mondadori, € 15
7 (-) R 8H. PomroyE. AdamsonLa dieta delsupermetabolismoSperling & Kupfer, € 16
8 (5)58A. Clerici, A. Romani S. BarzettiTutti a tavola!
Mondadori, € 16,90
9 (7)58Alex FergusonLa mia vita
Bompiani, € 19
10(9)57Carlo CraccoA qualcunopiace Cracco
Rizzoli, € 16,90
3 (3) S 34Jeff KinneyDiario di una schiappa. Guai in arrivo!Il Castoro, € 12
4 (4) S 15Suzanne CollinsII canto della rivolta Mondadori, € 13
5 (5) S 13Silvia D’AchilleColora con Peppa Pig
Giunti Kids, € 3,90
6 (7) 1 13AA.VV.Beauty book. Violetta
Walt Disney, € 12,90
7 (9) 1 13AA.VV.Fashion book. Violetta
Walt Disney, € 14,90
8 (8) S 12Suzanne Collins La ragazza di fuoco
Mondadori, € 13
9 (-) R 12Silvia D’AchilleLa macchina nuova
Giunti Kids, € 7,90
10 (10) S 12Suzanne Collins Hunger games
Mondadori, € 13
40%La quarta di copertina è l’anticamera dell’acquistoUno dei fattori oggi più importanti ai fini della vendita non è soltanto quello di fare bei libri, ma di come riuscire a comunicarli: a cominciare dalla comunicazione che passa attraverso la confezione del prodotto. A questo proposito, mi aveva sorpreso quanto avevo letto in un manuale di
marketing americano, e cioè che una persona che prende in mano un libro da un banco o da uno scaffale della libreriapassa circa il 40% del tempo che gli serve per valutarne l’acquisto guardando la quarta di copertina: ultima delle «soglie» di uscita del libro — come direbbe Genette — ma,
per il suo impatto comunicativo, anche la prima delle «soglie» di entrata. Se la quarta è come una vetrina che deve colpire l’occhio e invogliare ad entrare nel libro, allora è chiaro che una sbrodolata di parole e una quantità di elementi che disperdono la vista non giovano allo scopo.
di Giuliano ViginiIl numero
(Elaborazione a cura di GfK. Dati relativi alla settimana dal 10 febbraio al 16 febbraio 2014)
Il podio del criticodi Gianluca Borzoni
Gianluca Borzoni (Cagliari, 1972) è ricercatore presso l’Università di Cagliari dove insegna Storia delle relazioni internazionali. Si occupa di politica estera italiana e di relazioni mediterranee e transatlantiche. Tra i suoi lavori Renato Prunas diplomatico (1892-1951) (Rubbettino).
Inghilterra
1Robert GalbraithThe Cuckoo’s Calling
Little,Brown, £ 16,99
2Kate Atkinson Life after life
Black Swan, £ 7,99
3J. Patterson, M. WhitePrivate Down Under Arrow, £ 7,99
Germania
1Simon BeckettDer Hof
Wunderlich, € 19,95
2Jonas Jonasson Die Analphabetin,die rechnen konnteCarl’s books, € 19,99
3Graeme SimsionDas Rosie-Projekt
Fischer Krüger, € 18,99
Francia
1Katherine PancolMuchachas - Tome 1
Albin Michel, € 19,80
2Edouard LouisEn finir avec Eddy Bellegueule
Seuil, € 17
3R. Surzhenko, Yann L’oeil d’Odin- Les Mondes de ThorgalLombard, € 12
1Ennio Di NolfoIl disordineinternazionaleMondadori, € 16
2Liliana SaiuLa politica esteraitaliana dall’Unità... Laterza, € 10
3Pietro Pastorelli17 marzo 1861
Rubbettino, € 14

16 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Il racconto della vita di Francesco germoglia dal cuore e dalla memoria di frate Leone: sua è la voce che Nikos Kazantzakis (1883-1957) sceglieper narrare un’esistenza d’eccezione. Lo scrittore si nutre della storia ma la trasforma e la supera fino a renderla una favola, tanto poetica quanto vera. La nuova edizione di Crocetti (Francesco, traduzione di Valentina Gilardi, pp. 402, € 16) invita a riscoprire un testo poco noto di uno dei più grandi narratori della Grecia moderna.
La voce di Francesco d’Assisi
{Grechedi Alice Patrioli
SguardiPittura, scultura, fotografia, design, mercato
Il colloquio Il maestro contemporaneo, Bill Viola, che portò «The Greeting» alla Biennale del 1995,è a Firenze, dove lavorò negli anni Settanta, mentre si prepara la grande mostra di Palazzo Strozzi
Il colore Viola del Manierismo«Disprezzavo la pittura antica ma Pontormo mi cambiòCosì feci incontrare in video le donne della sua Visitazione»da Firenze
RANIERI POLESE
P iù di 80 opere di Pontormo e RossoFiorentino (tra cui 50 dipinti: ovve-ro, il 70 per cento della loro produ-zione), provenienti dai musei fio-rentini, ma anche da Venezia, Na-
poli, Londra, Parigi, Washington, Vienna,Francoforte, Hannover; disegni, arazzi, inci-sioni; e tavole di Andrea del Sarto e Fra Barto-lomeo che dei due massimi esponenti delManierismo furono maestri: sono i numeridella mostra Pontormo e Rosso Fiorentinoche si apre l’8 marzo a Palazzo Strozzi, a Firen-ze, a oltre mezzo secolo dalla mostra che nel1956 la città toscana aveva dedicato a Pontor-mo e il primo manierismo fiorentino. Prota-gonisti, i due maggiori esponenti di quellache Vasari chiamava la «nuova maniera», ar-tisti cioè che, liberatisi dall’obbligo di fedeltàall’osservazione della natura, creavano ununiverso figurativo popolato di immagini e colori fortemente antirealistici.
Nati entrambi nel 1494, l’anno della disce-sa in Italia di Carlo VIII re di Francia, i due pit-tori intraprendono percorsi divergenti: savo-naroliano, il Rosso viaggerà molto senza mailavorare per i Medici (morirà nel 1540, in Francia, dove era stato chiamato da France-sco I che gli aveva affidato la decorazione delcastello di Fontainebleau); agnostico, benvo-luto dai Medici ma abituato a vivere senza lussi, Pontormo muore nel 1557. Michelange-lo è fin dall’inizio l’ispiratore del Rosso, Pon-tormo invece passa dallo studio di Leonardoalla scoperta di Dürer per approdare, nellamaturità, a un recupero della lezione miche-langiolesca.
Curata dal direttore degli Uffizi AntonioNatali e da Carlo Falciani, Pontormo e RossoFiorentino. Divergenti vie della «maniera»ha come manifesto e simbolo la Visitazionedi Pontormo, conservata nella chiesa di SanMichele di Carmignano. Dipinta, probabil-mente, subito dopo la cappella Capponi diSanta Felicita a Firenze (la Deposizione, cheinsieme all’analoga opera di Rosso Fiorenti-no, custodita a Volterra, fu riprodotta da Pa-solini nel suo film La ricotta), la Visitazione,non citata da Vasari, deve la sua fortuna al No-vecento che, di volta in volta, vede in quelquadro l’ispirazione dell’Espressionismo,
della pittura metafisica, della Nuova Oggetti-vità.
Nel 1995, la Visitazione di Carmignano vie-ne rivisitata nel video di Bill Viola. Esposto al-la Biennale d’arte di Venezia in quell’anno, The Greeting sarà ospitato a Palazzo Strozzi. EBill Viola ha promesso che sarà a Firenze perl’inaugurazione.
La storia di un incontro«La Visitazione di Pontormo è stata la pri-
ma opera d’arte antica che mi ha ispirato. Eanche il primo set in cui abbiamo impiegatodegli attori», racconta Bill Viola. «La Lettura»lo incontra a Firenze, nello studio del restau-ratore Daniele Rossi, davanti al quadro in cor-so di restauro e ripulitura. Viola e la moglie ecollaboratrice Kira Perov non nascondono l’emozione di vedere da vicino e toccare quelcapolavoro, che grazie al lavoro di Rossi svelainattesi colori. Per esempio l’azzurro lumino-so del cielo, che invece finora appariva scuroe tempestoso. E anche le vesti delle quattrodonne assumono nuova lucentezza.
Conosceva già quel dipinto, l’aveva vistonegli anni passati a Firenze?
«No, in quegli anni pensavo solo ai video.Ero venuto a Firenze e lavoravo per lo studiodi videoarte Art/Tapes/22 di Maria Gloria Bi-cocchi, diciotto mesi, fra il 1974 e il 1976. Erogiovane, tutto quello che era passato non miriguardava. Il mio metro di giudizio era: se una cosa piace a tua madre, se per lei è com-prensibile, allora è per definizione bad. I mu-sei d’arte antica erano per me come ospedalitirati a lucido, fatti per conservare opere mor-te che interessavano solo vecchi studiosi. I pittori che mi piacevano erano Pollock, deKooning, Rothko: arte astratta».
Certo, in quei due anni a Firenze era im-possibile non imbattersi in testimonianzed’arte, in capolavori antichi.
«No, era veramente impossibile. Lo studiodove lavoravo era in via Ricasoli, fra il Duomoe il Museo dell’Accademia, quello in cui ci so-no il David e I Prigioni di Michelangelo. Peròil mio avvicinamento all’arte antica non è av-venuto nei musei, ma nelle chiese, dove c’èun gran viavai di gente, fedeli che accendonocandele, bambini che scorrazzano, comitive
di turisti molto rumorose. Come a Santa Cro-ce, dove ci sono gli affreschi di Giotto; quinon è come nei musei, che il quadro te lo tro-vi davanti, all’altezza dei tuoi occhi: gli affre-schi arrivano fino al soffitto, devi sforzarti pervedere qualcosa. È un ambiente vivo, le paretirinviano l’eco delle voci, dei passi. Una volta,mi ricordo, feci un nastro audio con i rumoridella chiesa».
E Pontormo?«Ero entrato nella chiesa di Santa Felicita,
subito dopo Ponte Vecchio, a vedere la Depo-sizione. Fui molto colpito dai colori. Uscendomi domandai, sinceramente, che cos’avesse fumato il pittore per dipingere quei rosa,quegli azzurri incredibili. Sembrava avesselavorato sotto l’effetto dell’Lsd. Ma la Visita-zione no, non l’avevo vista. Del resto stavafuori Firenze, a Carmignano. Il mio incontrocon quel quadro è avvenuto anni dopo, in Ca-lifornia. Una storia buffa».
Che cosa successe?«Ero andato in una libreria, cercavo un li-
bro: non ricordo più quale. Mentre stavo uscendo vedo con la coda dell’occhio un volu-me appoggiato sul banco, un nuovo testo suPontormo. Sulla copertina era riprodotta la Visitazione; mi colpirono i colori. Di quelquadro non sapevo niente, ma non potevosmettere di guardarlo. Ho comprato il libro el’ho portato a casa. Ma aspettai mesi prima diprenderlo in mano. Alla fine, apro il libro, loleggo, resto affascinato dalle idee, dai coloridi quel pittore. Nasce così l’idea di The Gree-ting: affittiamo uno studio a Los Angeles, cer-chiamo tre attrici. Abbiamo usato una cine-presa speciale, 300 immagini al secondo, perdare l’effetto di slow motion, di tempo rallen-tato: così 45 secondi di girato vengono espan-si fino a durare 10 minuti. All’epoca era qual-cosa che non potevi fare con la videocamera.Era un film, che poi è stato riversato. Lo portaiin prima mondiale alla Biennale di Venezia.Fu accolto subito con giudizi molto positivi».
Nel suo The Greeting noi vediamo il pri-ma e il dopo del quadro di Pontormo: Ma-ria ed Elisabetta che si avvicinano, si ab-bracciano, si parlano.
«La tecnica nuova, nata con il cinema, del-le immagini in movimento permette questa
Il personaggioBill Viola (New York, 1951)
è uno dei pionieri dellavideoarte. Dopo la laurea inVisual e Performing Art alla
Syracuse University, tra il 1973e il 1974 ha realizzato i primivideo. Viola (che nel 2004 ha
firmato un video per il Tristanoe Isotta di Richard Wagner,
regia di Peter Sellars) si è piùvolte cimentato nella
rivisitazione dei classicidell’arte: dagli affreschi di
Giulio Romano a Palazzo Te diMantova (The Raft, 2004) alla
Deposizione di Masolino(Emergence, 2002)
L’eventoPontormo e Rosso Fiorentino.
Divergenti vie della «maniera»,Firenze, Palazzo Strozzi
(dall’8 marzo al 20 luglio;Info Tel 055 26 45 155;
www.palazzostrozzi.org),a cura di Antonio Natali
e Carlo Falciani, CatalogoMandragora (pp. 320, e 40).
La mostra proponeper la prima volta insiemeuna cinquantina di dipinti
di due maestri della «manieramoderna», Jacopo Carrucci
detto il Pontormo (1494-1557) e Giacomo Battista diJacopo Rosso detto il Rosso
Fiorentino (1494-1540). Diecile sezioni dell’esposizione che
si apre con tre grandi affreschidella Santissima Annunziata
di Firenze staccati e restauratiper l’occasione (il Viaggio
dei Magi di Andrea del Sarto,la Visitazione di Pontormo,
l’Assunzione del Rosso)a cui verrà affiancata la Pala
Cambi di Fra’ Bartolomeo.In mostra anche il video
di Viola, The Greeting, ispiratoa Pontormo. In contemporanea
alla Strozzina (dal 14 marzoal 20 luglio) si tiene la mostra
Questioni di Famiglia, Viveree rappresentare la famiglia
con opere di dieci artisticontemporanei
Le immaginiSopra: Bill Viola (in maglia
rossa) accanto a Daniele Rossidavanti alla Visitazione
(foto di James O’Mara)
i
All’Espace VuittonE a Venezia si misuracon Vittore Carpaccio
Mentre a Firenze si confronta idealmente con Pontormo, all’Espace Culturel Louis Vuitton di Venezia (Calle del Ridotto 1353, www.louisvuitton.it, fino al 25 maggio, ingresso libero) Bill Viola ha scelto invece di misurarsi con Vittore Carpaccio (1465-1525), uno dei grandi maestri veneziani del XV secolo. L’occasione è Renaissance, la mostra sponsorizzata dalla maison francese e curata da Adrien Goetz con Hervé Mikaeloff. Da una parte: la Madonna con il Bambino (1487 circa) e la Pietà (seconda metà del XV secolo) di Carpaccio, entrambe a lungo conservate nei depositi del Museo Correr di Venezia e da poco attribuite al maestro (al loro restauro ha contribuito proprio Louis Vuitton in partnership con la Fondazione Musei Civici di Venezia). Dall’altra, due videoinstallazioni dell’artista americano: Emergence (2002, sopra) e Eternal Return (2000). Il terreno per questa ideale conversazione veneziana èla rappresentazione del confine che separa la nascita dalla morte.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 17
A Ferrara dipinti, sculturee grafica dal 1899 al 1952
I fauni, le ninfe e Matisse:ben più d’un pomeriggiodi SEBASTIANO GRASSO
Mostre
C i pensa un po’ su, Henri Matisse,prima di prendere un carboncinoe tradurre in immagini Il pomerig-gio d’un fauno di Mallarmé. Qual-che tempo prima l’editore Skira lo
ha incaricato di illustrare, con acqueforti altratto, le poesie di Stéphane. Il libro esce nel1932. Mallarmé è morto da 34 anni, ma i suoiversi lo hanno sempre incantato. Adesso,Matisse è preso come non mai da questo po-ema (che Paul Valéry giudica il più grandedella letteratura francese), fors’anche per-ché suggestionato dalla musica di Debussy,ascoltata più volte, o dal balletto di Vaslav Ni-zinskij.
In entrambi i casi, l’artista si ritrova nellefantasie del fauno, figura della mitologia ro-mana (satiro, in quella greca), che, in un po-meriggio estivo, incanta col flauto una ninfaaddormentata. Racconta il fauno: ricordo oimmaginazione («Un sogno ho amato»). Lasensualità si impossessa della natura e deipersonaggi mitologici. Disegni, ma anchedipinti (Ninfa nella foresta, vegetazione,1935). Tema cui Matisse si dedica sino al1943, sintetizzando le immagini, sino a ren-derle semplici contorni («Linee o valori spe-ciali — annoterà egli stesso in Note di un pit-tore — sparsi per tutta la tela o la carta, a for-marne l’orchestrazione, l’architettura. Manon tutti se ne accorgono. Forse si tratta divoluttà sublimata»). I lavori ispirati da Mal-larmé fanno parte della mostra, curata daIsabelle Monod-Fontaine, che Ferrara dedi-ca all’artista francese (1869-1954), con parti-colare riferimento alla figura (soprattuttofemminile) che tanta parte ha avuto nellapoetica matissiana. Un centinaio fra dipinti,sculture e grafica dal 1899 al 1952, due anniprima della morte.
A ninfe e fauni seguono le 20 tavole a co-lori di Jazz. Pubblicato nel 1948, sette annidopo essere stato «pensato» dall’editoreTériade, il lavoro di Matisse viene definito «il più ammirevole e memorabile libro d’ar-tista che mai sia stato creato, uno dei verticidel XX secolo». Il pittore vi lavora contempo-raneamente al Charles d’Orléans e al Pasi-phaé. Prima lo intitola Cirque, perché i sog-getti riguardano «i suoi ricordi del circo,racconti popolari o di viaggio», poi lo cam-bia in Jazz perché pensa che, in fondo, il cir-co e il jazz abbiano molto in comune.
Ovunque, ritmo sincopato e stilizzazionedelle figure ottenute con la tecnica del po-choir (stampino vuoto, all’interno del qualesi passa il pennello), cui Matisse aggiungeun testo manoscritto — rotondeggiante edecorativo — che definisce «sfondo sono-ro».
Ogni «figura» — dipinta, scolpita, dise-gnata o incisa — è sempre più semplificata.Anche se Matisse viene dall’accademia e i
suoi primi lavori consistono nel copiare icalchi delle sculture classiche, egli tentasempre di sintetizzare i volumi e di reinven-tare i soggetti.
La stessa operazione avviene quando pas-sa alle modelle (pose di ore) o si serve di fo-tografie. Si vedano alcuni autoritratti o ri-tratti di persone a lui care, come quelli dellamoglie Amélie e della figlia Marguerite. Ma-tisse scandaglia più volte lo stesso volto, an-che quando si dedica a un «ritratto d’insie-me». Le sue modelle erano mediterranee:Laurette (che posa per una quarantina diquadri); Antoinette (che d’estate accetta diseguirlo a Issy); Henriette («Una scultura vi-vente — ricorda Hilary Spurling — che avevala bellezza vigorosa di un’ex ballerina; la suapelle assorbiva la luce in una maniera parti-colare e lei sapeva assumere con facilità lepose michelangiolesche cui il pittore alloraera interessato e che gli avrebbero ispirato leodalische»).
Inoltre, Lydia: «La testa appoggiata allebraccia incrociate sopra lo schienale dellasedia, il busto in leggera torsione, offriva ilproprio volto e i suoi occhi azzurri nella cor-nice naturale dell’arabesco formato dallebraccia piegate».
Ma c’è qualcosa di insolito in questa russache posa per una serie di nudi di grandissi-ma resa (Il sogno, il Grande nudo disteso,Nudo rosa seduto e moltissimi disegni). Co-me se fosse capace di realizzare una sorta di«cinematografia dei gesti quotidiani». Ri-cordate la Danza?
Perché la figura diventa il tema principaledell’opera di Matisse? Quasi tutta l’opera gra-fica poggia su di essa. Non solo. È proprio lafigura che egli riprende verso gli ottant’anni.Soprattutto con i ritratti. Matisse traccia per-sonaggi realisti.
I modelli più ricorrenti sono i famigliari,principalmente i nipoti, che egli semplifica(con un procedimento di sintesi talvolta si-mile alla caricatura), riduce i visi a ovali vuo-ti, che appaiono come vere e proprie ma-schere. Verità del modello o dell’artista? Ma-tisse risolve la querelle coniugando entram-be. Come? Facendo sì che i volti si possanovedere, oltre che leggere.
Avviene anche una sorta di temporalizza-zione del ritratto. Disegni immediati. Scrit-tura rapida e di notevole resa. Da qui, secon-do Pierre Schneider, «una schiera di visi contro la solitudine, avanguardia della nottedefinitiva». Una notte che non tarda a venire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
continuità. In mancanza della quale i pittoriantichi nei loro cicli di affreschi (o nei politti-ci) mettevano in sequenza i diversi momentidella vita del santo raffigurato, episodi tem-poralmente distanti. Con il cinema (e poi la videocamera) l’arte ha vissuto una rivoluzio-ne altrettanto radicale di quella che ebbe luo-go nel Quattrocento a Firenze: allora, con la prospettiva, si creò la rappresentazione a tredimensioni. Occorreva studiare, disporre diconoscenze matematiche per padroneggiarela visione prospettica. Anche oggi scienza etecnologia sono necessarie».
Ma che cosa significava, che cosa signifi-ca per lei ispirarsi a un quadro di un pittorerinascimentale?
«Non mi è mai interessato fare una ripro-duzione, la replica di un’opera d’arte così co-me si fanno le rievocazioni in costumi stori-ci. Quello che mi importa davvero è cosa ac-cade quando queste immagini entrano den-tro di noi, ci vivono dentro, crescono, sitrasformano in qualcosa d’altro. Guardo alungo quelle immagini, lascio che penetrino,a volte faccio un disegno, ma non sempre,poi lo metto via, me ne dimentico. L’operache realizzo, così, è qualcosa che nasce daquello che si è prodotto dentro di me, in unluogo che precede la parola, qualcosa cheappartiene al mondo delle emozioni ele-mentari di ogni essere umano. Quando mimisi a lavorare a The Greeting, mia madre eramorta da poco, era nato il mio primo figlio,attraverso l’opera di quell’antico maestro miaprivo al rapporto con le emozioni comuni atutti, ai fatti fondamentali del vivere come lanascita e la morte».
Che non si tratti di copie fedeli, tableauxvivants, si vede già da The Greeting, doveper esempio le donne sono tre e non quat-tro, e i colori degli abiti non vogliono nem-meno lontanamente ricordare i colori diPontormo.
«Mi interessava questo incontro fra duedonne; una, Maria, giovane, in attesa di un fi-glio che, secondo il racconto dei Vangeli, nonha un padre. Sì, un angelo, una voce forse, leha detto che sarà madre. Ma lei è turbata, im-paurita, e nell’abbraccio con Elisabetta vuoletrovare conforto, una spiegazione. Forse le
due donne si dicono qualcosa. Qualche annodopo, in Encounter, ho filmato un altro in-contro: una ragazza e una donna più avanti negli anni. Camminano parallelamente su unterreno deserto, quando alla fine si incontra-no, la donna anziana dà alla giovane una sca-tolina. Cosa c’è dentro? Non si sa. È un dono, econ quel dono in mano la ragazza torna in-dietro. E anche l’altra donna riprende il cam-mino».
L’acqua, la morte, la vitaNelle scorse settimane Bill Viola ha donato
alla Galleria degli autoritratti degli Uffizi il suo autoritratto. È il primo video che entranel Corridoio vasariano. Camicia azzurra,pantaloni scuri, al collo un rosario buddista,l’artista è immerso nell’acqua con gli occhichiusi, in un atteggiamento di assoluta quie-te. Ha le braccia quasi conserte sul petto,mentre la camicia si increspa lentamente nelfluire dell’acqua. Ancora una volta l’acqua, co-me già in tanti altri video: Anthem del 1983,The Messenger, 1986, e finalmente Emergen-ce, 2002, ispirato dalla Pietà di Masolino, l’af-fresco conservato a Empoli. Qui, il giovanenudo e bianchissimo si erge lentamente dalsepolcro da cui fuoriesce l’acqua. Singolare ebellissima opera, che rovescia il senso del-l’originale (la Madonna e San Giovanni de-pongono Cristo nel sepolcro; qui inveceemerge dal pozzo-sepolcro).
Ma perché c’è sempre l’acqua nelle sueopere?
«Per me l’acqua è la morte e la vita. È anne-gare e riemergere, passare da una forma diesistenza a un’altra. L’acqua è un elementoprimordiale, ma non solo. È legato a un mioricordo. Avevo sei anni, ero in vacanza con lamia famiglia vicino a un lago. Andavamo inbarca, io all’improvviso scivolai e caddi giù.Mi ricordo che andavo sempre più in fondo,con gli occhi aperti. Ma non avevo paura. Sen-tivo che stavo passando da questa vita inun’altra vita. Ero tranquillo. Mio zio, che nonmi vedeva più, si tuffò e mi venne a riprende-re. Come fosse un angelo salvatore. Mi ricor-do che quando mi fece uscire dall’acqua perrespirare scoppiai in un pianto dirotto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Allestimento UUUUU
Rigore scientifico UUUUU
Catalogo UUUUU
L’appuntamentoMatisse. La figura, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, fino al 15 giugno (Info Tel 0532 44 949; www.palazzo diamanti.it). Catalogo Ferrara Arte (pp. 296, € 45). A fianco: Fauno che incanta una ninfa addormentata (1935, particolare). Sotto, da sinistra, particolari di Ritratto di Marguerite Matisse (1918) e de Il cappello giallo (1929)
»»»
Sopra: tre sequenze tratteda The Greeting (1995),
videoinstallazione di Bill Violaispirata dalla Visitazione del
Pontormo (foto grande in alto)

18 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
«Considero ricchezze autentiche solo quelle di un animo che abbia maggior stima di sé che dei poveri averi. A buon diritto chiamiamo ricco e dovizioso colui che sa come vanno impiegate le grandi ricchezze. Ma se uno non fa che
accumulare grettamente sostanze si riduce come l’ape, che fatica nell’alveare mentre altri si mangiano il miele»: Tommaso Moro ricorda in uno degli epigrammi (Edizioni San Paolo, 1994) che è molto povero chi sa solo accumulare...
Tommaso Moro e la povertà di chi accumula
{Sguardi Le mostreClassicamente
di Nuccio Ordine
Avanguardie Una rassegna a Forlì sullo stile che si diffuse nel 1902, esplose nel 1906 e si sviluppò fino al 1911
La libertà di essere LibertyOltre l’Art Nouveau, oltre il movimento Jugend: guardando al Rinascimentol’Italia elaborò la sua via all’«arte nuova», rivoluzionando anche grafica e architetturada Forlì ARTURO CARLO QUINTAVALLE
M olte le strade per comprende-re l’Arte Nuova in Italia. L’im-portante e ricca mostra di For-lì evoca la scansione tempora-le proposta da Rossana Bossa-
glia: diffusione del movimento in occasionedella mostra internazionale di Arte Decorati-va di Torino (1902), massimo consenso conl’Esposizione Universale di Milano (1906),ancora sviluppo fino alla mostra di Roma nel1911. Fernando Mazzocca e Maria Flora Giu-bilei puntano su un insieme di eventi storici:la progressiva industrializzazione italianarappresentata nelle mostre internazionali,l’apertura della Biennale di Venezia (1895), ilpeso sulla nostra ricerca delle Secessioni.
Cambia dunque la società, cresce una di-versa borghesia che si rappresenta nell’ar-chitettura, nell’arredo, nella moda, mentre lapittura pare conservare modelli del passato.Infatti l’Arte Nuova in Italia è sempre un con-fronto fra due modelli: quello tradizionale, del Rinascimento, e l’altro, della nuova scrit-tura anche grafica che il Liberty, l’Art Nouve-au, l’arte Jugend — dunque i modelli inglesie francesi, e poi tedeschi e austriaci — fini-ranno per introdurre. Così il racconto della mostra propone sempre esperienze diverse,opere che prendono punti di riferimentospesso distanti.
Nel 1902 Alfredo Melani scrive: «L’ArteNuova è poetica e contrapponesi alla prosa dell’arte vecchia, rifrittura delle cose anti-che». Ma qual è l’arte nuova e quale la vec-chia? Un’opera del preraffaellita inglese Ed-ward Burne-Jones, La principessa Sabra(1865), ci fa capire: in una cornice finto-rina-scimentale la figura di profilo, lunghe vesti,sta contro una spalliera di fiori e medita suun libro d’ore. Dunque evocazione del Rina-scimento, del Botticelli tanto amato da molticome Leonardo Bistolfi, Raimondo d’Aron-co, Gaetano Previati. Ma il dialogo col Rina-scimento ha valenze diverse, e, ad esempio,nel grande fregio esposto da Galileo Chini alla Biennale del 1907, i riferimenti sono aPiero di Cosimo, Luca Signorelli, Donatello.
In Italia il nuovo delle Secessioni europeesi confronta con la tradizione che accolgonoin molti, come Bistolfi che cita Agostino diDuccio nella Targa Ugo Rabbeno (1906). An-che in architettura, il nuovo fatica a penetra-re, semmai Ernesto Basile evoca le tradizionicostruttive popolari e solo Antonio Sant’Eliadisegna la città di una mitizzata rivoluzionedelle macchine. In mostra le opere di AubreyBeardsley, Kolo Moser, Gustav Klimt segna-
no modelli diversi dalla ricerca in Italia; danoi il nuovo, la ricchezza dell’invenzione, siscopre in alcuni ambiti: la ceramica, la grafi-ca, i metalli, i mobili. Fra i vasi floreali, unodel Museo Stibbert, attribuito a Adolfo de Carolis (1900), fa capire la complessità dei nessi fra le arti: intreccio di rose bianche sufondo azzurro e la scritta «Così partìa le rosee le parole», un verso di Petrarca ripreso daD’Annunzio.
Proprio il Vate è figura chiave della com-mittenza neorinascimentale per scultura epittura mentre, nell’ambito della grafica, in-nova nettamente: lo mostrano le illustrazio-ni per Francesca da Rimini (1902) e la coper-tina di Fedra disegnate da Adolfo de Carolis.Il peso della tradizione, l’impatto di Luca Si-gnorelli e di Michelangelo sono determi-nanti per Giulio Aristide Sartorio, ad esem-pio in Le Tenebre (1907) e nel fregio di Mon-tecitorio (1910), per Ettore Tito e molti altri.Dunque la novità, la rivoluzione sta altrove.Lo capisce Vittorio Pica che, su «Empo-rium», nel 1897 scrive: «In Italia non si puòdire che esista tuttora una vera e completaarte dei cartelloni, così come in Francia, inInghilterra, negli Stati Uniti d’America o inBelgio ma, dietro gli esempi d’Oltralpe, dadue o tre anni si notano i sintomi promet-tenti di una prossima, brillante fioritura».
Saranno i Marcello Dudovich, LeopoldoMetlicovitz, Adolfo Hohenstein, Duilio Cam-bellotti, Aleardo Terzi, Galileo Chini, Umber-to Boccioni e il grandissimo Leonetto Cap-piello a cambiare l’immagine di strada in Ita-lia e fuori, fra primo e secondo decennio, ri-voluzionando grafica e colori. Lo capisce nel1918 un giovane Roberto Longhi: «Sono con-vinto che l’illustrazione, molto più che l’arteche non vuol esser altro, sia ricca di umoripittorici sostanziali, che le permettono di ri-frangere ancora con simpatica vividezza infi-nite forme vitali da che l’arte d’oggi si va sem-pre più segregando». Ed esalta Cappiello eDudovich: «Erano ancora gli unici connazio-nali che sapessero fare dei “quadri”».
La mostra è anche altro, le primaverili fan-ciulle di Galileo Chini, le trascoloranti figurefemminili del trittico di Gardone di GaetanoPreviati (1908), il postimpressionismo di Pli-nio Nomellini, Giovanni Boldini e AmedeoBocchi. La rassegna chiude con gli omaggi aKlimt di Vittorio Zecchin e il ritorno al Rina-scimento michelangiolesco di de Carolis eSartorio. Riemerge sempre la tradizione in-tesa come identità nazionale, proprio quelloche il movimento Jugend rifiuta. Il confrontofra innovazione e restaurazione si ritrova indue saggi che hanno cambiato la storia del-l’arte: Problemi di stile di Alois Riegl (1893),con il racconto della lunga durata delle figu-re del naturale dagli egizi al Rinascimento, eil testo di Adolf Loos Ornamento è delitto(1908), dove è sotto accusa proprio la culturaJugend, con le sue avvinghianti volute. Sonomaturi i tempi per la nuova arte: Avanguar-die e Bauhaus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Allestimento UUUUU
Rigore scientifico UUUUU
Catalogo UUUUU
L’esposizioneLiberty. Uno stile per l’Italia
moderna, Forlì, Musei di SanDomenico, fino al 15 giugno
(Info Tel 199 15 11 34;www.mostre
fondazioneforlì.it),Catalogo a cura di Fernando
Mazzocca (Silvana Editoriale,pp. 408, e 34). Orario:
da martedì a venerdì 9.30-19;sabato, domenica e giorni
festivi 9.30-20.Chiuso il lunedì.
Biglietto intero: € 11;biglietto ridotto: € 9
Le opereIn mostra: opere di Previati,
Boldini, Sartorio e di altrimaestri italiani; lavori di artisti
stranieri come Klimt, Burne-Jones; grafica e arti applicate
(dai manifesti di Dudovichagli abiti di Eleonora Duse)
i
Due delle opere esposte ai Musei di San Domenico a Forlì per la mostra Liberty. Uno stile per l’Italia moderna: in alto, Carlo Stratta (1852-1936), Aracne (1893), olio su tela (cm 120 x 113, particolare) proveniente dalla collezione della Galleria d’arte moderna e contemporanea (Gam) di Torino; sopra, Amleto Cataldi (1882-1930), Vaso con nudi di donne e mascheroni (inizio XX secolo), bronzo (cm 60), dalla collezione Alessio Ponti Galleria d’arte, Roma

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 19
Bambole innamorate. Si chiamano kokeshi i pupazzi tradizionali giapponesi dal busto cilindrico, senza gambe e braccia, e dalla testa rotonda. Le più famose, riprodotte in pietra, si trovano davanti al ponte Harimaya-bashi,
nella città di Kochi. Rappresentano due infelici amanti di 150 anni fa: il monaco Junshin e Ouma. Quando lui fu visto comprare un fermaglio per capelli vicino al ponte, venne allontanato dal paese. I due non si videro più.
Il monaco che divenne una bambola
{Sguardi PersonaggiSushi style
di Annachiara Sacchi
MILANOLe cromie di KaufmannMassimo Kaufmann nasce a Milano nel 1963 e lavora tra la sua città natale e New York. Appartiene a quella generazione di artistiche si è imposta dopo la stagione dell’Arte povera e della Transavanguardia. In mostra la serie The Golden Age (sopra: Stripes, 2010).Galleria Scognamiglio Fino al 30 marzoTel 02 36 52 68 09
Calendario
VENEZIALa realtà e i sogniDopo Mosca e prima di giungere a Londra, fa tappa in laguna la mostra dedicata a Viktor Popkov, uno dei maggiori artisti russi del XX secolo. Le 45 opere esposte, attraverso scene quotidiane,evocano le grandi tematiche della vita umana (sopra: La notte di Capodanno, 1973). Ca’ Foscari esposizioni Fino al 27 aprile Tel 041 234 62 23
MODENAFotografia come documentoUna serie di immagini, tutte provenienti dalle raccolte della Galleria, raccontano il fotogiornalismo di maestri come Henri Cartier-Bresson, Weegee, Robert Capa (sopra: Roger Pic, Il Che, 1962) che hanno eternato i grandi uomini e la grande storia. Galleria civica di Modena Fino al 13 aprile Tel 059 20 32 911
SANKT MORITZ (Svizzera) Il bianco come fil rouge Un evento che è il preludio della prossima edizione di St. Moritz Art Masters (agosto): 20 opere, sculture e dipinti dall’antichità a oggi, in cui prevale il bianco (sopra:Ai Weiwei, Born Beijing, 1957 Marble Doors, 2007).Chiesa protestante Fino al 9 marzo Tel +41 81 833 10 28
U n’occasione forse unica. Un modello cuici si potrebbe richiamare in futuro. An-che per reagire alla drammatica crisiche sta colpendo la maggior parte deimusei d’arte contemporanea italiani, tre
importanti istituzioni pubbliche hanno deciso diritrovarsi insieme intorno a un unico progettoespositivo. Un esperimento analogo era stato giàtentato nel 2010 con le mostre itineranti sull’Artepovera e sulla Transavanguardia, tenutesi in diver-se sedi (a distanza di qualche mese). Riprendendoesperienze già sperimentare a livello internazio-nale, un museo nazionale (il Maxxi di Roma), unocomunale (la Gam di Torino) e uno regionale (ilMadre di Napoli) hanno deciso di collaborare, di«fare sistema».
La loro sfida è stata quella di pensare un’antolo-gica dedicata a Ettore Spalletti, intitolata Un gior-no così bianco, così bianco, disseminata tra ilnord (Torino), il centro (Roma) e il sud (Napoli),suddivisa in tre capitoli autonomi, ma fortementeconnessi tra di loro (il catalogo, anch’esso unico, èedito da Electa). Il 13 marzo (fino al 14 settembre)al Maxxi — a cura di Anna Mattirolo — sarà inau-gurato il primo appuntamento: Spalletti, il qualeha deciso di riscrivere parti dell’edificio di ZahaHadid, suggerendo un’esperienza visiva avvolgen-te, segnata da improvvise apparizioni. Dal 27 mar-zo (al 15 giugno) alla Gam — a cura di Danilo Ec-cher — si terrà la ricostruzione dell’atelier dell’ar-tista, concepito come rifugio intimo, cripta di pensieri e di meditazioni, spazio dove maturanoipotesi e strategie: una sorta di museo privato. In-fine, dal 13 aprile (al 18 agosto) il Madre — a curadi Andrea Viliani e Alessandro Rabottini — pre-senta un’antologica che ripercorre l’intero itinera-rio di Spalletti, dagli esordi (negli anni Sessanta)agli esiti più recenti del suo lavoro: un itinerarioche, lungi dall’assecondare un andamento crono-logico, mira a indugiare sui temi forti della ricercadi questa personalità.
Dunque, Spalletti. Ovvero, uno tra i maggiorisolitari dell’arte italiana del nostro tempo, già pre-sente in varie edizioni della Documenta di Kassel(1982 e 1993) e della Biennale di Venezia (1997).Una figura difficile da iscrivere in gruppi e in ten-denze, cui sono state dedicate personali in museiprestigiosi, come il Musée d’Art Moderne de laVille di Parigi (1991), l’Ivam di Valencia (1992), ilMusée d’Art Contemporain di Lione (1996), il Mu-sée di Strasburgo e il Museo di Capodimonte diNapoli (1999), la Fundacion La Caixa di Madrid (2000), l’Henry Moore Institute di Leeds (2005),
l’Accademia di Francia di Roma (2006), la Gallerianazionale d’arte moderna di Roma (2010).
Poverista? Concettuale? No, piuttosto siamo di-nanzi a una tra le poche voci più autenticamentereligiose della nostra epoca. Una sorta di monacodel XX secolo, del tutto distante dai riti e dallestrategie del mainstream, indifferente nei con-fronti dell’idea dell’arte come provocazione e co-me scandalo, impegnato esclusivamente in eser-cizi compositivi lenti, in gesti cauti, in meditazio-ni lambite da pause, da esitazioni, da dubbi. Spal-letti non lascia mai nulla al caso, né si affida a produzioni «meccaniche». Agisce come un ari-stocratico artigiano che attribuisce una centralitàassoluta alla pratica artigianale: il fare con le pro-prie mani è il principio cui si è sempre attenuto.Segue procedure esecutive antiche. Calcola ogni
momento, ogni linea,ogni pigmento. In pos-sesso di una notevolemaestria nella model-lazione di diversi mate-riali (alabastro, mar-mo, foglia d’oro, carta),plasma monumenticompatti, solenni, deltutto privi di rimandi edi allusioni.
In lui, vi è innanzi-tutto il desiderio diportarsi al di là di ognitentazione descrittiva orappresentativa. La suaambizione consiste nelprocedere senza fretta,riconducendo l’arte al-la sua essenza, alla sua
struttura. Iscrivendosi all’interno di quella che Fi-liberto Menna definì la «linea analitica dell’arte moderna», si propone di semplificare. Tende ver-so la purezza della forma. Insegue la pulizia, la perfezione, l’imperturbabilità. Attinge solo ad al-cune «unità linguistiche» finite e costanti, prive di ogni abbandono letterario.
A guidarlo sembra essere il celebre invito di Cé-zanne, il quale volle ridurre il mondo a cono, cilin-dro e sfera. Sulle orme di Cézanne, Spalletti inse-gue «verità percettive» non temporanee, ma eter-ne. Sorretto dalla convinzione secondo cui la real-tà non è liquida ma solida, ricorre esclusivamentead alcune geometrie fondamentali. Compie undifficile viaggio verso i «primari», nel quale unruolo decisivo è assegnato al colore. Che Spallettiutilizza oscillando tra slancio aniconico e segretirinvii. Da un lato, predilige il monocromo; scegliedi disgiungersi da ogni «interferenza» esterna;
elabora una sintassi governata dal rispetto di re-gole auree: la sua è «un’iconografia senza icone».Dall’altro lato, rifiuta i colori puri, mentre predili-ge quelli caldi, in grado di dischiudere varchi ver-so altre dimensioni. Le sue non sono tonalità «disuperficie», ma «atmosferiche», a tratti consape-volmente «svenevoli» (Barilli). Alludono sempre aun transito. Ad esempio, l’azzurro, il rosa, il gri-gio. Che vengono esibiti non nella loro respingen-te impersonalità (tipica delle soluzioni del mini-malismo). Sono scelti perché pronti a «ospitare»chi osserva: in essi ci sentiamo come immersi. Ciaccolgono, ma chiedono anche di non essere toc-cati. Hanno una profonda qualità emozionale: evi-denti le assonanze con le culture del Mediterra-neo. Rarefatti, sembrano respirare: si muovono inmaniera impercettibile. Sembrano evocare in noile sfumature della nostalgia.
Inoltre, i colori, nelle sculture di Spalletti, nonsono mai «pellicolari»: non ricoprono le cose, mapromanano dalle cose stesse. E, soprattutto, de-tengono una loro potenza plastica. E sembranoespandersi nei contesti: si diffondono negli am-bienti in cui vengono collocati. Dotati di una pre-cisa consistenza oggettuale, contribuiscono a de-finire la spazialità dell’opera. Si impongono con laloro monumentalità non anacronistica, ma fragi-le. Spalletti scolpisce autentici blocchi di colore.Che, in alcuni casi, si collegano tra di loro; si con-tinuano; seguono un ritmo modulare, spesso in-terrotto da calcolate imperfezioni e inesattezze. Spesso, si impone un effetto complessivo di omo-geneità incrinata.
«Il colore, come si sposta, occupa lo spazio enoi entriamo. Non v’è più la cornice che delimita-va lo spazio. Togliendola, il colore assume e inva-de lo spazio. E quando questa cosa riesce, è mira-colosa», ha affermato Spalletti, le cui opere sem-brano rifugiarsi nei territori dell’ammutolimento.Vivono nel silenzio. Che si oppone al rumore, sen-za annullare il linguaggio. Ha la capacità di prece-dere, e di contenere, ogni cifra. È un attimo, che vaposto sempre in relazione con qualcosa: deve ave-re confini. Sta in un intervallo prolungato. È esitoradicale di un brusio, che diviene indistinto. È strumento per svelare verità che si manifestanoattraverso un casto sillabario di linee, di punti, dicromie. L’esito finale: raffinati giardini di pietre,all’interno dei quali possiamo isolarci dalle voci difuori. Tempi mistici. Un tentativo per dar vita —anche nel nostro tempo disincantato — a un’artespirituale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le tre sediSono tre le sedi che ospitano
le oltre settanta opere dellamostra Ettore Spalletti. Un
giorno così bianco, così bianco:il Maxxi di Roma (13 marzo-14 settembre, a cura di Anna
Mattirolo); la Gam di Torino(27 marzo-15 giugno, a cura
di Danilo Eccher); il Madredi Napoli (13 aprile-
18 agosto, a cura di AndreaViliani e Alessandro Rabottini)
Le immaginiDall’alto: Sala delle feste,
1998 (in mostra al Maxxi);un ritratto di Spalletti (1940);
la sala del Madrededicata all’artista
i
Maestri Da Maxxi di Roma, Gam di Torino e Madre di Napoli un esemplare omaggio in tre capitoli
Spalletti mette il mondo in un conoUn colore che non ricopre le cose, forme puree un po’ di Cézanne per l’italiano più solitariodi VINCENZO TRIONE
a cura di CHIARA PAGANI

20 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
PercorsiStorie, date, biografie, reportage, inchieste
Alain Ruscio e la grandeur,atteggiamento che ritorna
«La Francia non capìil senso della sconfittaE perse anche l’Algeria»dal nostro corrispondente a Parigi STEFANO MONTEFIORI
Lo storico
L a grande battaglia vinta dal ge-nerale Giap è stata l’inizio dellafine dell’impero coloniale, ma ifrancesi non hanno voluto ac-corgersene. «Mentre in Maroc-
co si festeggiava e in Tunisia e Algeriagli indipendentisti prendevano corag-gio — se ce l’avevano fatta i vietnamitipotevano farcela anche loro — la Fran-cia non ha tratto le conseguenze di quel-la disfatta e si è lasciata impantanarenella guerra di Algeria. Il colonialismofrancese aveva e ha radici molto profon-de, che si fanno sentire ancora oggi»,dice lo storico Alain Ruscio, 66 anni,specialista della Francia coloniale e inparticolare dell’Indocina.
La sconfitta di Dien Bien Phu fu unasorpresa totale per la Francia?
«Da un punto di vista militare sì, fuun episodio di guerra di posizione enon un atto di guerriglia, una débâcle coloniale senza precedenti, ma i france-si avevano già avuto molte prove che laloro presenza non era gradita nelle co-lonie. La prima sorpresa fu nel 1945, quando la fine della guerra mondialeportò le rivolte coloniali invece che pa-ce: dalla sanguinosa repressione diSétif, in Algeria, alla sollevazione del1947 in Madagascar. Quanto all’Indoci-na, la sconfitta del 1950 alla frontiera ci-nese era stata già un avvertimento. Biso-gna ricordare che la caduta di Dien BienPhu è arrivata alla fine di una guerra che
laggiù durava ormai da sette anni».In seguito la difesa dell’Algeria
francese avrebbe poggiato su un lega-me cominciato già nel 1830 e soprat-tutto sulla presenza massiccia degli «europei» (nel XX secolo Algeri diven-ne la seconda città francese). Qual erainvece il fondamento ideologico del-l’Indocina francese?
«Non poteva certo essere il numerodei coloni: c’erano solo 40 mila francesiin un territorio grande quanto tutta laFrancia. Ma loro pensavano di essere lìin virtù di una gerarchia naturale tra leciviltà: alla Francia spettava dirigere eproteggere le popolazioni locali, facen-do valere paternalisticamente la propriasuperiorità. Su questa base di coloniali-smo classico si è aggiunto poi l’antico-munismo: a differenza che in India o inIndonesia il movimento indipendenti-sta indocinese era comunista. Difende-re l’Indocina francese divenne un ele-mento della lotta globale contro il co-munismo».
Lo pensavano anche gli americani.«Nel 1945 Washington era anticolo-
nialista, avrebbe preferito che i francesise ne andassero. Ma quando gli ameri-cani hanno capito che Ho Chi Minh eracomunista, e quando Mao Zedong nel1949 ha proclamato la Repubblica popo-lare di Cina, hanno deciso di aiutare ifrancesi. Alla fine c’erano centinaia di consiglieri militari americani, e la guer-ra dei francesi era finanziata all’80 percento da dollari americani».
In «Apocalypse Now» di Coppolac’è la famosa scena della «French
plantation», prima espunta ma recu-perata nell’edizione estesa («Re-dux»), in cui i soldati americani si im-battono in alcuni coloni francesi su-perstiti. È vicina alla realtà?
«È verosimile, soprattutto perché di-pinge bene gli atteggiamenti delle dueforze straniere. Gli americani conside-ravano i francesi come dei dinosauri, ein effetti avevano ragione: i nostri colonifacevano parte di un vecchio mondo,erano conservatori al limite della reazio-ne, rappresentavano la vecchia Francia.Anticomunisti, ma soprattutto fieri di-fensori delle loro tovaglie immacolate edel loro savoir vivre trapiantato orgo-gliosamente nella giungla indocinese.Prima di Dien Bien Phu, quegli stessifrancesi nelle città predicavano la politi-ca del bastone contro le popolazioni lo-cali, e protestavano ogni volta che il go-verno di Parigi faceva qualche conces-sione all’imperatore Bao Dai».
Il colonialismo francese è rimastoassociato ai paracadutisti, all’imma-gine tetra di un Jean-Marie Le Pen conla benda sull’occhio, reduce di Indoci-na e Algeria.
«È un’immagine parziale, perché ilnostro colonialismo non fu affattoespressione esclusiva dell’estrema de-stra. Al contrario, la sinistra francese è stata tradizionalmente colonialista, ba-sti pensare al socialista Jean Jaurès, chepoi cambiò idea, ma nel 1887 votò i cre-diti di guerra per il Tonchino, o al gran-de colonialista Jules Ferry. Tutti gli in-terventi coloniali della Francia sonosempre avvenuti abbracciando — conuna parte di sincerità, va riconosciuto— una qualche bandiera nobile, dai di-ritti umani alla protezione delle mino-ranze oppresse: la lotta ai pirati nel Me-diterraneo per l’Algeria nel 1830, la dife-sa dei cristiani perseguitati in Indocinao dei berberi contro gli arabi in Algeria,oppure dei cambogiani contro i vietna-miti. È un atteggiamento che si fa senti-re ancora adesso».
Vede una forma di neocolonialismonei recenti interventi di NicolasSarkozy (Costa d’Avorio, Libia) oFrançois Hollande (Mali, RepubblicaCentrafricana)? Ogni missione ha ra-gioni diverse, dal cacciare un dittatorealla lotta al terrorismo all’impedire un genocidio.
«Credo che per ogni intervento ci sia-no sempre più motivazioni, tra le qualicertamente alcune puntuali e ragione-voli. Ma tutte queste guerre hanno in co-mune la vecchia idea che la Francia ab-bia una sorta di missione universale, ac-coppiata all’esigenza di mantenere leposizioni geostrategiche in un conti-nente, l’Africa, in pieno sviluppo e con-teso da altre potenze come Stati Uniti eCina. Possiamo anche riconoscere lasincerità di questo o quell’uomo politi-co, ma non spiega tutto».
Lei ha incontrato più volte il gene-rale Giap. Era consapevole del suoruolo storico?
«Assolutamente sì. Era un uomo mo-desto, un vietnamita e un comunistache non pronunciava mai la parola io e,in un francese impeccabile, meticoloso,metteva sempre in avanti i meriti delpopolo. Ma era cosciente che la sua vit-toria aveva scosso il mondo intero. Sa-peva benissimo di essere stato un pre-cursore».
@Stef_Montefiori© RIPRODUZIONE RISERVATA
Alain Ruscio (1947) è uno storico del colonialismo francese, non soltanto in Indocina
La battaglia
13 marzo - 7 maggio
L A O SV I E T N A M
C I N A
Dien Bien Phu
Luang Prabang
Lai Chau Yen Bay
Hanoi
ForzeViet Minh
Forzefrancesi
soldati delle forze regolari
uomini50.000
caduti10.000
15.000
portatori260.000
portatori260.000
caduti3.000
pista di atterraggio
ISABELLE
GABRIELLE
ELIANE
CLAUDINE
HUGUETTE
BEATRICE
FRANÇOISE
pistadi atterraggio
13 maggio 1954Il generale Vo Nguyen Giap
dopo aver ottenuto la vittoriadecisiva nella battaglia di Dien Bien Phu
DOMINIQUE
Postazioni Viet Minh
Aree sotto il controllo francese
Meno di 6 chilometri tra Gabrielle e Isabelle
Direttrici di avanzata e rifornimento Viet Minh
Una decina di carri armati
Unità del comando e dei servizi(compreso un bordello con prostituteviet e algerine)
3 batterieda 105 e 155 mm
3 compagniedi mortai da 120 mm
*che costituivano la riserva mobile
4Legione straniera
4unità nordafricane
3unità thai
2parà*
Dei 15.000 uomini solo un decimo circa erano francesi
13 battaglioni
ANNE-MARIE
Dien Bien PhuIl 13 marzo 1954 il generale Giap avviòl’assedio che umiliò il colonialismo di ParigiMa alla vittoria non seguì un’epoca di pacedal nostro corrispondente a Pechino GUIDO SANTEVECCHI
M attina del 13 marzo 1954,alla radio francese parlail generale Henri Navar-re, comandante delleforze in Indocina: «La
marea offensiva del Viet Minh si è fer-mata...». Nella valle di Dien Bien Phu ilcolonnello Christian de la Croix de Ca-stries e i suoi ufficiali ascoltano e sisentono sicuri. Intorno a loro, sulle colline, sono di sentinella Gabrielle,Béatrice e Anne-Marie sul limite Nord;Huguette, Dominique, Françoise,Claudine, Éliane al centro; al sud, iso-lata, veglia Isabelle. La truppa dice chede Castries ha battezzato i capisaldipensando alle sue non poche conqui-ste sentimentali (qualche legionariosostiene che in realtà sono anche loro«mercenarie»). Charles Piroth, l’esper-to ufficiale che ha disposto nella valle itrenta pezzi dell’artiglieria francese, hadetto più volte ai colleghi di non preoc-cuparsi: i viet non riusciranno mai adavvicinarsi, non potranno mai far arri-vare i loro pesanti cannoni di fabbrica-zione cinese attraverso la giungla, aportata utile per infastidire gli avam-posti francesi.
«... La marée est étale». Capisce be-ne il francese anche il comandante delViet Minh, l’armata di liberazione, Vo Nguyen Giap, che ha insegnato storiaal lycée français di Hanoi ed è diventa-to generale da autodidatta, studiando
le campagne di Napoleone. Giap sentequella frase del nemico e sorride. Dà un ordine e i cannoni «troppo pesantiper essere trascinati in posizione utileper battere i capisaldi francesi» apro-no il fuoco.
Il colonnello de Castries era arrivatonella conca vietnamita di Dien Bien Phu il 20 novembre 1953, in esecuzio-ne del piano militare di Navarre e dellafollia politica di Parigi. Finita la Secon-da guerra mondiale, il governo france-se aveva creduto di poter riprendere ilcontrollo del suo Empire, dall’Algeriaall’Indocina. Vive l’Indochine françai-se, con la Cambogia, il Laos, le tre pro-vince vietnamite del Tonchino a nordcon capitale Hanoi, l’Annam al centrocon l’antica Hué e la Cocincina a sud,con la capitale Saigon. L’avventura co-loniale in Asia era cominciata intornoal 1850; più di cent’anni dopo, Parigicredeva ancora di avere un diritto cul-
turale e morale al dominio coloniale. Nel 1945 comincia la guerra con il
Viet Minh, la Lega per l’indipendenzadel Vietnam guidata da Ho Chi Minh.All’inizio sono azioni di sabotaggio eguerriglia che i militari francesi pensa-no di poter reprimere. Nel 1949, con lavittoria di Mao Zedong in Cina, la stra-tegia cambia e il Viet Minh comunistalancia i suoi combattenti nel Tonchinoin attacchi a bassa intensità che co-stringono i francesi a chiudersi ad Ha-noi, dove rischiano l’accerchiamento.
È in questo scenario che nella valledi Dien Bien Phu, vicina al confine conil Laos, alla fine del 1953 il comandodell’Armée d’Indochine fa spianare ilterreno per una pista d’atterraggio,vengono lanciati i paracadutisti, i re-parti della Legione straniera, batta-glioni di fucilieri algerini e marocchi-ni. In tutto, de Castries avrà ai suoi or-dini oltre 15 mila uomini riforniti dacirca 200 aerei al giorno. L’idea, mistodi audacia temeraria e arroganza alservizio della grandeur imperiale, è diattirare le imprendibili forze del VietMinh e distruggerle in una battagliagrazie all’artiglieria e al sostegno deibombardieri.
C’era un inviato speciale di «LeMonde» al seguito di Christian de Ca-stries. Si chiamava Robert Guillain e, dopo essersi guardato intorno, osser-vò: «Mon colonel, mi permetta, questa
CoraggioI comandi di Parigi
avevano piazzatole truppe in basso,
sottovalutandole mosse del Viet Minh
SSS

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 21
Nguyen Huy Thiep, coscienza critica del Paese
«Questo mio Vietnamè bello e maleducatocome un adolescente»di MARCO DEL CORONA
Lo scrittore
Q uando i vietnamiti vinsero aDien Bien Phu, Nguyen HuyThiep aveva 4 anni. La batta-glia non è dunque parte dellasua storia, ma lo è del Paese di
cui è oggi il narratore più significativo. Isemi di quell’epoca ritornano nella sua opera, così come la guerra ha abitato ilVietnam ben oltre il 1954. «Ero troppopiccolo... Ma lo scrittore — spiega a “laLettura” — deve opporsi a violenza eguerre. Però in Vietnam quelli che hannobeneficiato della guerra sono coloro chehanno creato la guerra. Lo stipendio deimilitari è molto alto, anche le pensioni.Un sostegno non solo materiale ma an-che morale. Mi fa paura. Mentre una per-sona normale cerca un modo per vivere,la pensione di un maggiore può arrivare a10 milioni di dong al mese (circa 350 eu-ro, ndr), che corrisponde al guadagno ditutta una famiglia per un anno».
Di Thiep, Alessandra Chiricosta — fi-losofa interculturalista che insegna an-che all’Università di Hanoi — sostieneche «quando nel 1987 uscì il suo raccontoIl generale in pensione, rappresentò unoscandalo politico e letterario». Come inaltri scritti di Thiep, dice Chiricosta a «laLettura», la retorica eroica della guerra«lascia spazio al dramma del quotidianonella ricostruzione postbellica, quandopure i generali devono lottare per il dirit-to alla pensione. Lo stile letterario diThiep riflette le contaminazioni intercul-
turali della letteratura moderna vietna-mita: influenze della tradizione orale deiracconti nei villaggi intessute con tecni-che narrative postmoderne».
Un convergere di elementi che si ritro-va nelle prudenti parole dell’autore, abi-tuato a essere un «osservato speciale» daparte delle autorità (le sue risposte sonostate fatte avere a mano, non per email):«La storia di un Paese — aggiunge — ècome quella di una persona. In gioventùsi è forti ed entusiasti. Tanti sogni, ambi-zioni. Si fanno cose pericolose e stupide.Da quanto vedo, anche la politica in Viet-nam è così. La prima fase è meravigliosa,poi inizia il declino e viene la morte. Misono sempre stupito del fatto che il Viet-nam abbia 4 mila anni di storia. Ci siamoliberati dalla Cina solo nel 1802. Il regimecomunista, dal 1945 a oggi, è ancora nellasua gioventù: è maleducato, ma anchebello. Per la cultura è diverso. A me inte-ressa più la vita, perché anche la culturacade nelle illusioni. Non ho mai capitoche cosa sia veramente la cultura. Contacomunque e sempre il senso morale».
Com’è il suo stato d’animo ora? «Capirà cosa intendo quando avrà 64
anni. Di recente sono passato davanti acasa di Nguyen Khuyen, un poeta dell’Ot-tocento, del periodo in cui sono arrivati ifrancesi. La casa è tenuta bene, con bei ri-cordi: un albero di longan cresciuto da unnocciolo donato dall’imperatrice al poe-ta. Quando hanno preso a cannonate ilvillaggio, hanno evitato di colpire la suacasa e l’area intorno, e il suo paese s’è sal-vato. Nguyen Khuyen a 64 anni ha scrittoil suo testamento letterario, rivolgendosinon al Dio cristiano ma agli spiriti: “La
mia età è arrivata a 8x8, / il numero 9 por-ta fortuna. / Dio mio, la morale è sottilema ho questa longevità. / Oh Dio mio, lemie capacità sono modeste / ma sono ar-rivato al quaderno del drago”, quello do-ve si registravano i nominativi di chi su-perava tutt’e tre i livelli degli esami man-darinali. Questo è l’esempio di un intel-lettuale vietnamita, forse il miglioredell’epoca, e cosa pensava a 64 anni...».
Il Vietnam continua a essere un Pae-se fortemente impregnato di valori tra-dizionali, forse più della Cina...
«La cultura comprende tutto, da Bud-dha a Confucio e Lao Zi, e anche il cristia-nesimo. La cultura è innanzitutto religio-ne. Il problema non è mantenere, ma cre-are. Oggi non si può buttare via e neanchemantenere. Sono lezioni apprese da tuttele religioni. C’era un’epoca in cui hannodistrutto le chiese, ora le ricostruiscono.Quindi il problema secondo me sta nelmodo in cui la gente vive questa vita inogni singola famiglia. Quando si parla dicultura, si parla troppo della cultura chetrova espressione “fuori”, non di quellainterna. Mentre quando si parla di Bud-dha, ci si accorge che Buddha è dentro ilcuore: Buddha c’è dove Buddha non c’è.La sua domanda è più sulle attività ester-ne: sono cose importanti, sì, ma a me in-teressa la cultura interna».
Anche alla luce di queste riflessioni,lei ritiene che il Vietnam abbia trovatouna sua modalità particolare nel filtra-re le influenze occidentali e globali?
«Non sono un politico, non ho respon-sabilità a livello sociale: quindi non hocompetenze per rispondere. La genteparla troppo della libertà, anche i giovani.Il problema non è la libertà, ma il confineinterno nel proprio cuore. Non sono imargini esterni, ma quelli interni a doveressere superati. In una situazione in cuigli stupratori non scoperti giudicanoquelli scoperti, la libertà non c’è, e nelcontempo c’è ovunque. Comunque,quando una persona sta bene di salute eha una buona cultura, si sente più sicuradi sé e della propria libertà».
Citavamo la guerra. Il Vietnam ha unpericoloso contenzioso con la Cina perle isole Spratly e le Paracel...
«Il rapporto tra Cina e Vietnam è statosempre complicato. A volte le cose vannomale a causa delle condizioni esterne, nonostante la volontà dei singoli di farleandare bene. Fa parte del destino di duenazioni, di due popoli. Sono destini chenascono da tante vite precedenti. Cometra marito, moglie e figli nella stessa fa-miglia: si amano e si odiano anche, sidanno l’uno all’altro ma si distruggono,anche. Si riscaldano ma si bruciano. Biso-gna quindi accontentarsi e arrendersi.Anche se si risolve una singola questione,ci saranno poi altri problemi. Un po’ co-me il rapporto tra l’Italia e i suoi vicini.Non mi interesso delle cose oltre a me ealla mia famiglia».
Nel mondo, e anche in Asia, le ten-denze cosiddette nazionaliste sono increscita. Accade anche in Vietnam?
«Non mi interessa». E non la preoccupa l’atteggiamento
della Cina nella regione?«Non ho opinioni in merito». Quali sentimenti e quali pensieri le
suggerisce il riavvicinamento anchemilitare con gli Stati Uniti?
«Non sono leader politico. Se lo fossiavrei modo di esprimere un’opinione».
@marcodelcoronaleviedellasia.corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nguyen Huy Thiep (1950). Apprezzato da Claudio Magris, nel 2008 gli è stato assegnato il Premio Nonino
La battaglia
13 marzo - 7 maggio
L A O SV I E T N A M
C I N A
Dien Bien Phu
Luang Prabang
Lai Chau Yen Bay
Hanoi
ForzeViet Minh
Forzefrancesi
soldati delle forze regolari
uomini50.000
caduti10.000
15.000
portatori260.000
portatori260.000
caduti3.000
pista di atterraggio
ISABELLE
GABRIELLE
ELIANE
CLAUDINE
HUGUETTE
BEATRICE
FRANÇOISE
pistadi atterraggio
13 maggio 1954Il generale Vo Nguyen Giap
dopo aver ottenuto la vittoriadecisiva nella battaglia di Dien Bien Phu
DOMINIQUE
Postazioni Viet Minh
Aree sotto il controllo francese
Meno di 6 chilometri tra Gabrielle e Isabelle
Direttrici di avanzata e rifornimento Viet Minh
Una decina di carri armati
Unità del comando e dei servizi(compreso un bordello con prostituteviet e algerine)
3 batterieda 105 e 155 mm
3 compagniedi mortai da 120 mm
*che costituivano la riserva mobile
4Legione straniera
4unità nordafricane
3unità thai
2parà*
Dei 15.000 uomini solo un decimo circa erano francesi
13 battaglioni
ANNE-MARIE
fortezza sembra costruita al contra-rio». Il nobile ufficiale di cavalleria ri-spose infastidito: «Prego, che cosa vor-rebbe dire?». «Mon colonel, io ho lettoil De bello gallico e ho capito che dai tempi di Alesia per vincere non si sta inbasso ma sulla cresta delle colline perdominare il campo di battaglia». Neiricordi di Guillain, il colonnello repli-cò che il giornalista evidentementecon sapeva nulla della guerra moder-na, Giulio Cesare era superato: «Chevengano i viet, è qui che li attendo, èqui che il nostro fuoco incrociato lispazzerà via. Vede, il nostro problemaè il contrario, è che i viet non voglionorischiare, per questo da mesi non si so-no mossi».
L’armata del Viet Minh invece si eramossa, per mesi, lungo i sentieri strettie fangosi. E tutto sommato Giulio Ce-sare poteva ancora insegnare qualcosae sicuramente lo aveva insegnato aGiap, quel professore che i liceali diHanoi chiamavano Napoleone per lasua passione della storia militare. Inquei mesi di silenzio che avevano illu-so Navarre, Giap aveva portato intornoalla valle 50 mila uomini. Come? «Dovepassa una capra, può passare un uomoe uno alla volta passa un battaglione»,amava ripetere Giap, citando Napoleo-ne e la campagna d’Italia. Il problemaprincipale sono i rifornimenti: «Sì, perfar arrivare un chilo di riso alla primalinea bisogna consumarne quattro du-rante il trasporto... noi abbiamo im-piegato oltre 2o0 mila portatori, 400camion, 500 cavalli e 20 mila biciclet-te». Le biciclette di fabbricazione Re-nault e Peugeot i viet le avevano com-prate di nascosto ad Hanoi, in una sor-ta di riedizione dell’epopea dei taxidella battaglia della Marna. I cannoni furono smontati e trascinati a bracciasulle colline.
Siamo a quel 13 marzo 1954. Giapsente Navarre alla radio, ordina il fuo-
co. I cannoni viet cominciano a colpi-re. La presunzione degli ufficiali fran-cesi si sgretola. Il colonnello Piroth chiede scusa ai colleghi, prende unabomba a mano, toglie la sicura e si fasaltare. Cadono subito Gabrielle e Bea-trice. Il 16 marzo cede Anne-Marie e il28 il campo d’aviazione è inutilizzabi-le. Ai francesi, senza rifornimenti, nonresta che «finire bene», proprio comeaveva detto ai suoi ufficiali il colonnel-lo Galliano ad Adua nel 1896. I legiona-ri sul campo si sacrificano con valore.Mentre cade Dominique, sono allostremo Huguette e Éliane, il governofrancese si umilia fino al punto di invo-care il soccorso degli americani. Washington non risponde (il suo tur-no in Vietnam verrà dopo). Ad apriledurante uno squarcio nel cielo copertodalle nuvole, Navarre fa lanciare un al-tro battaglione di parà. Servirà solo aingrossare il numero delle perdite: 3mila caduti e 10 mila prigionieri. Il VietMinh perse oltre 10 mila combattenti su 50 mila.
Il 7 maggio 1954 l’artiglieria di Giaplancia l’ultimo fuoco di sbarramento epoi è l’assalto finale. De Castries, pro-mosso generale durante l’assedio,mette uno straccio bianco davanti alsuo bunker, non «finisce bene» comeGalliano ad Adua. Con la resa di Isabel-le si chiudono i 57 giorni di Dien BienPhu. A Ginevra, durante il massacro, sinegoziava. Nella notte tra il 20 e il 21 lu-
glio la firma: i francesi se ne vanno e ilVietnam viene diviso in due lungo il17° parallelo. Per la riunificazione civorranno altri 21 anni e una guerra cheferì l’America nell’anima. Da allora, inun gioco del domino che si svolse inmodo completamente opposto rispet-to alle previsioni di Washington, l’eser-cito vietnamita ha combattuto e occu-pato a lungo la Cambogia e si è scon-trato per un mese, tra il 17 febbraio e il16 marzo 1979, con quello della Repub-blica popolare cinese in una situazionedi rivendicazioni nazionaliste e rivalitàideologiche che si sono meritate il tito-lo di Terza guerra d’Indocina. Con Pe-chino le tensioni restano, centrate sul-le isole Spratly e Paracel, anche se innome dell’economia di mercato «concaratteristiche socialiste», i due Paesiora hanno anche imparato a collabora-re. Per i 35 anni dall’invasione cinese, il17 febbraio, solo poche decine di viet-namiti hanno cercato di manifestaread Hanoi: sono stati bloccati dalle au-torità. Gli eroi sono stanchi.
Ora il Vietnam insegue un modellodi crescita anche nell’hi-tech, attrae in-vestimenti di multinazionali ansiosedi aprire nuove fabbriche con costi dellavoro inferiori a quelli cinesi, preferi-sce progettare la nuova Silicon Valleyin zone dove si combatterono grandi battaglie. Sul web il giovane NguyenHa Dong, genio delle app, ha appenafatto furore con il gioco Flappy Bird, incui un uccellino deve compiere evolu-zioni su un percorso obbligato. Un suc-cesso mondiale, fino a quando Nguyenha deciso di ritirarlo: «Creava assuefa-zione». Pochi giorni fa a Ho Chi MinhCity (la vecchia Saigon) è stato aperto ilprimo McDonald’s del Vietnam: è invia Dien Bien Phu. Giap, che se n’è an-dato l’anno scorso a 102 anni, sarebbestato soddisfatto.
@guidosant© RIPRODUZIONE RISERVATA
Indocina addio
TrasformazioneOggi Hanoi cerca un
equilibrio con la Cina, stringe rapporti
con gli Usa e costruisce la sua Silicon Valley
SSS
Per un inquadramento del Vietnam non limitato alla guerra «americana» sono stati pubblicati in Italia, entrambi a firma di Francesco Montessoro, Vietnam, un secolo di storia (Franco Angeli, 2000) e Le guerre del Vietnam (Giunti, 2004). In francese: Alain Ruscio, Dien Bien Phu: la fin d’une illusion (L’Harmattan, 1986). Sulla battaglia, il regista Pierre Schoendoerffer (1928-2012) ha girato i film La 317e section (1965) e Dien Bien Phu (1992). Il volume Vietnam Soul raccoglie tutti i racconti di Nguyen Huy Thiep usciti in italiano (traduzione di Tran Tu Quan, Bianca Maria Mancini e Luca Tran, ObarraO, pp. 352, € 18). Sulle dinamiche culturali del Vietnam oggi: Alessandra Chiricosta, Filosofia interculturale e valori asiatici (ObarraO, pp. 330, € 14).
Libri e film
(

22 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Percorsi Controcopertina
L a consuetudine di identificare la storia princi-palmente con le vicende e le scansioni periodiz-zanti caratteristiche dell’Europa ha radici assaiprofonde. E la cosa non stupisce, se si pensa chea dare i natali alla moderna storiografia scienti-fica è stato il nostro continente, nel cuore del-l’Ottocento, subito valorizzandola come impor-
tante strumento di legittimazione del dominio occidentalesul mondo. In quell’epoca un’Europa contraddistinta dallarivoluzione industriale e dalla liberalizzazione delle istitu-zioni politiche costruì i propri grandi imperi coloniali inAsia e in Africa, sottomettendo grandi civiltà e elaborando ilmito della propria «missione civilizzatrice» su scala planeta-ria. Andare alla ricerca degli antefatti di una superiorità allo-ra tanto schiacciante da sembrare quasi genetica significòper gli storici europei dare consacrazione definitiva all’ideadi progresso (materiale, civile, culturale) e ancorare in esclu-siva la dimensione della storia (cioè, in ultima analisi, dellosviluppo e della trasformazione) alla civiltà occidentale, dacontrapporre orgogliosamente a quelle — reputate stagnan-ti e immobili — fiorite nelle altre parti del globo.
La storia, come perlopiù la conosciamo, è dunque con-traddistinta da un vizio originario di eurocentrismo. E tendeda un lato a servirsi di un modello di periodizzazione che en-fatizza alcune scansioni tutte interne alla vicenda occidenta-le (Antichità/Medioevo/Età moderna/Età contemporanea),dall’altro a inglobare nel proprio racconto altre civiltà pre-sentandole come semplici scenari periferici prima del-l’espansione, poi del dominio europeo. Essa si muove alla ri-cerca delle possibili anticipazioni plurisecolari (o addirittu-ra plurimillenarie) di un rapporto di forza su scala planetariache è stato caratteristico dell’età contemporanea e sembraperò oggi destinato a una metamorfosi dagli esiti incerti.
Ma il mondo anteriore alla svolta ottocentesca, come lastoriografia che si ispira al metodo della World History hadurante gli ultimi decenni cercato di dimostrare, era in real-tà assai più policentrico di quello nel quale si è svolto il no-stro passato recente. E, se si considera la scala globale in pro-
spettiva plurisecolare, appare davvero problematico conti-nuare a assegnare una sorta di primato permanente all’Euro-pa. Al punto che, come ha scritto qualche anno fa ImmanuelWallerstein, per accostarsi oggi proficuamente alla storia sa-rebbe opportuno dimenticare preventivamente tutto ciò chein materia si è appreso a scuola. Un’affermazione, natural-mente, paradossale, ma non priva di suggestioni preziose.Perché da un lato è vero che a partire dal Cinquecento gli eu-ropei furono i più efficaci tessitori di una trama di connes-sioni planetarie di scala e intensità inedite, e offrirono uncontributo determinante alla costruzione di quel mondo aquattro (e, in seguito, a cinque) parti che rimpiazzò la tradi-zionale ecumene tricontinentale formata da Asia, Africa e Europa. Però è altrettanto vero che, all’interno di questo nuovo spazio planetario interconnesso, le singole grandi ci-viltà continuarono a seguire per lo più, come in passato, ilproprio filo. Facciamo qualche esempio.
Si tende a parlare, quando si narra dell’ondata di esplora-zioni e poi dell’espansione europea avviata all’inizio della (nostra) Età moderna da Cristoforo Colombo e da Bartolo-meo Diaz, di decollo di una inedita globalizzazione, contrad-distinta dalla supremazia europea su scala planetaria. Ma cisi dimentica che in precedenza vi erano state, in realtà, altrestraordinarie esperienze di irradiazione territoriale e cultu-rale diffusa, di cui erano state protagoniste civiltà diversedalla nostra. La rete della globalizzazione araba, tra VII e XIIsecolo, era giunta ad avvolgere spazi sconfinati, che si di-stendevano dalla penisola iberica al cuore dell’Asia, transi-tando per le coste mediterranee africane; e quella della glo-balizzazione islamica, a partire dal XIII secolo, giunse a de-positarsi anche su una porzione rilevante dell’immenso sub-continente indiano, dilatandosi inoltre verso l’Asia sud-orientale. Quando, tra l’XI e il XII secolo, le repubblichemarinare di Venezia, Genova, Pisa, che da una prospettiva eurocentrica siamo abituati a considerate le avanguardie
1050 a.C.Si affermala dinastiaZhou
770 a.C.Inizia l’epoca «Primaveree autunni».Si accentuanoi conflittiinterniall’impero
476 a.C.Il regnosi spezza, cominciail periododegli «Stati combattenti»
221 a.C.Il re Ying Zhengdi Qin riunificala Cina
202 a.C.Liu Bang fonda la dinastia Han,da cui prende il nome l’etnia cinese
581La dinastiaSui riunificala Cina
618Subentra la dinastia Tang, sotto la quale sono inventate stampa e polvere da sparo
907Nuova fasedi disgregazione,detta delle Cinque Dinastiee dei Dieci Stati
960-976 Taizu fonda la dinastia Song e conquistal’intera Cina. Si avvia una fase di modernizzazione
1260-1279Invasione dei mongoli,che fondano la dinastia Yuan
1368 La dinastia Mingcaccia i mongoli
1644 Invasori provenienti dalla Manciuriaconquistano Pechino e fondano la dinastia Qing
1842 Guerra dell’oppio: gli inglesi sconfiggonola Cina. Grave decadenza dell’impero
1912 Abdica Pu Yi, ultimoimperatore. Nasce la Repubblica
1949 Mao Zedong fondala nuova Cina comunista
Cro
nolo
gia
euro
cent
rica
Cro
nolo
gia
isla
mic
aC
rono
logi
ain
dian
aC
rono
logi
aci
nese
ANTICHITÀ
1800 a.C.Prima dinastiadi Babilonia
753 a.C.Fondazionedi Roma
La Lupacon i gemelli
Romolo e Remo,simbolo di Roma
Maometto predica ai suoi seguaciin una miniatura medievale
Una statuadel dio indiano
Shiva
Un guerrierodi terracotta di Xi’an
490478 a.C.Guerrepersiane
313 d.C.L’imperatore Costantinolegalizza il culto cristiano,che diventa egemone
476Caduta dell’imperoromano d’Occidente
800Incoronazionedi Carlo Magnoa sovranodel nuovoSacro RomanoImpero
1492Scopertadell’America
1648Pacedi Westfalia
1776Dichiarazioned’indipendenzaamericana
1914-1918Prima guerra mondiale
1939-1945Seconda guerramondiale
1989-1991Fine del sistemasovietico
1789Rivoluzionefrancese
1861Unità d’Italia
1517Riformaluterana
1095-1099Primacrociata
1347-1353Grandeepidemiadella pestenera
Conquista mongoladi Bagdad,fine degli Abbasidi
1453I turchi prendonoCostantinopoli
1718Pace di Passarowitz,fine dell’espansioneottomana in Europa
1839Inizio delle riformeoccidentalizzanti in Turchia
1299Nascitadel regnoottomanoin Turchia
1501I Safavidi alpotere in Iran
1736 Cade in Persiala dinastia Safavide,sostituita dagli Afsharididi stirpe turca
1517Conquistaislamicadell’India
1923Fine dell’impero ottomano,nasce la Repubblica turca
1947Fine del dominio britannico,nascono India e Pakistan
1971 Il Bangladeshsi stacca dal Pakistan
1857-1858 Rivolta repressa dagli inglesi.Tutta l’India sotto la corona britannica
Noi e gli altri, cronologie parallele
MEDIOEVO
1800 a.C. 100 d.C. 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA
27 a.C.Augustodiventa il primoimperatoreromano
EPOCA DEI CALIFFATI
622 d.CAnno dell’Egira, Maomettofonda la prima comunità islamica661Nascita del califfato Omayyade di Damasco,il cui potere si estende dall’Iran alla Spagna
750Si afferma il califfato Abbasidedi Bagdad, che segna la maggiorefioritura della civiltà araba
DECADENZA
0d.C.a.C.
1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
INDIA CLASSICA
486 a.C.Morte di Buddha
409 d.CLa dinastia Guptaunifica l’India
991Prime incursionimusulmanecontro i regniRajput327-325 a.C.
Spedizionedi AlessandroMagno in India
510Cade l’imperoGupta
DOMINIO MUSULMANO
1206In seguitoall’invasioneislamicanasceil sultanatodi Delhi
1398Tamerlanoinvadel’India
1739Sacco
di Delhida parte
dei persianidi Nadir
Shah
1763La Compagnia inglesedelle Indie ottienel’amministrazionedel Bengala
1803Gli inglesi conquistano Delhi
1517I Moghulislamiciregnanoin India
1258
1650 a.C.La dinastia Shang èla prima su cui esistano testimonianze storiche
1500 a.C.Nascela civiltà vedica
EPOCA DEGLI IMPERI ISLAMICIGRANDI IMPERI ISLAMICI
COLONIZZAZINEBRITANNICACOLONIZZAZIONEBRITANNICA
INDIPENDENZAINDIPENDENZA
La tradizionale scansione degli eventi nasce come uno strumento di legittimazionedel predominio occidentale e non ha alcun significato per il resto del pianetache era interconnesso prima di Colombo e rimase policentrico fino all’Ottocento
Adesso globalizziamo il passato Cina, India, mondo arabo: le civiltà da rivalutare L’Europa non è stata l’unico centro del mondodi MARCO MERIGGI
World Historyuna rivoluzione
L’autore e il dibattitoLo storico Marco Meriggiinsegna all’Università di
Napoli. È autore con Laura DiFiore del libro World History.
Le nuove rotte della storia(Laterza, 2011). Il suo
intervento riprende il temadelle periodizzazioni storiche
affrontato sul numero 117della «Lettura» da Maurice
Aymard, Franco Cardini eGiuseppe Galasso
BibliografiaAlcuni saggi che adottano la
visione della World History:Vittorio Beonio Brocchieri,
Storie globali (EncycloMedia,2011); Immanuel
Wallerstein, Comprendere ilmondo (traduzione di Marina
Errico, Asterios, 2006);Teodoro Tagliaferri,
La Repubblica dell’umanità(Rubbettino, 2012)
Lo sguardo antropologicoEsce il 26 febbraio il libro di
Arjun Appadurai Il futurocome fatto culturale
(traduzione di Marco Monetae Maria Pace Ottieri, Raffaello
Cortina, pp. 444, e 29)
i Una collana di romanzi storici
Il coraggio e le astuzie dei Signori della Guerra Mercoledì prossimo, 26 febbraio, tocca a Guglielmo Testadimaglio, giovane crociato che partecipò alla conquista di Gerusalemme nel 1099, e a Giovanni delle Bande Nere, il condottiero della casa dei Medici che combatté al servizio dello Stato pontificio e morì nel 1526, cercando di fermare le truppe imperiali che avrebbero compiuto il Sacco di Roma. Sono i protagonisti dei due romanzi storici con cui parte la collana dei «Signori della Guerra», edita da Rizzoli: Il crociato infedele (pp. 315, e 12,90) di Davide Mosca narra le imprese di Testadimaglio; Il gran diavolo di Sacha Naspini (pp. 355, e 12,90) s’incentra su Giovannidelle Bande Nere. Come spiega Michele Rossi, responsabile narrativa italiana di Rizzoli Libri, l’obiettivo della collana è «raccontare i principali protagonisti dellastoria medievale e moderna. Guerrieri, combattenti, veri signori che la guerra hanno combattuto o teorizzato». Si tratta di romanzi, prosegue Rossi, «caratterizzati da rigore storico-documentale che hanno l’obiettivo di innovare il genere e che abbiamo pensato per un pubblico anche giovane e attento ai nuovi linguaggi». Ai libri di Mosca e Naspini ne seguiranno a breve altri due. Il falco nero di Mauro Marcialis, sull’imperatore Federico II di Svevia (1194-1250), esce il 3 marzo, mentre Il principe del male di Francesco Ongaro, dedicato a Niccolò Machiavelli (1469-1527), sarà in libreria il 4 aprile. Il programma della collana prevede l’uscita di quattro titoli all’anno.
Nel parlare di «psichiatria neocoloniale» Derek Summerfield, del Royal College of Psychiatry di Londra, accusa l’industria delle malattie mentalie gli psichiatri occidentali di sostenere che le malattie mentali sono più diffuse di quanto non
I poveri sono matti
{Sopra le righedi Giuseppe Remuzzi
lo siano davvero. Da qui un uso sconsideratodi antidepressivi. Forse ci si dovrebbe chiedere se le malattie mentali non dipendano, specie nei Paesi poveri, dalla frattura fra i molti che non hanno niente e i pochi che hanno tutto.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 23
Il luogo comanda ai nomi: rifugiati per la notte in Santa Maria Maggiore i manifestanti gridano dai cancelli ai giornalisti di non chiamarli forconi «perché è un nome cattivo». Data un’occhiata alle navate s’erano
accorti che là dentro c’era un forcone da tre denti in mano a un demone e un altro con quattro punte manovrato da un ceffo che attizza il fuoco al pentolone in cui furono bruciati i sette Maccabei.
Forconi in Basilica
{Due parole in crocedi Luigi Accattoli
SSSUna copertinaun artista
Il cielo di Parmiggiani Una mano irrompecome un lampo di lucenel cielo stellato. E sullamano l’ombra di unalbero scarno in unavisione tragica e poetica:è il mito di una naturaperduta, l’idea
dell’imprendibilità del naturale e, con esso, della vita. Un tema ricorrente per Claudio Parmiggiani, grande protagonista dell’arte internazionale, che ha realizzato un’opera dal forte valore simbolico, in cui vita, natura e creazione s’intrecciano in una costellazione che diventa evocazione dell’esistenza, vera rivelazione. Claudio Parmiggiani (Luzzara, 1943) lavora con il fuoco e l’aria, la luce e la sua ombra, la pietra, il vetro, la maestà del marmo, la fragilità delle farfalle: materiali che trasforma (talvolta con una volontà iconoclasta) in installazioni e sculture nelle quali convivono la classicità e la sua messa in discussione. La sua è un’arte di impegno civile: frammenti del mondo come racconto di un presente costantemente sospeso nel tempo e in cui prevale l’emozionante e poetico racconto sul persistente, ineluttabile dialogo con l’assoluto dell’Assenza. (gianluigi colin)
Supplemento culturale del Corriere della Seradel 23 febbraio 2014 - Anno 4 - N. 8 (#118)
Direttore responsabile Ferruccio de BortoliCondirettoreVicedirettori
Luciano FontanaAntonio MacalusoDaniele MancaGiangiacomo SchiaviBarbara Stefanelli
Supplemento a curadella Redazione cultura Antonio Troiano
Pierenrico RattoStefano BucciAntonio CariotiSerena DannaMarco Del CoronaDario FertilioCinzia FioriLuca MastrantonioPierluigi PanzaCristina Taglietti
Art director Gianluigi Colin
© 2014 RCS MediaGroup S.p.A. Divisione QuotidianiSede legale: via A. Rizzoli, 8 - MilanoRegistrazione Tribunale di Milano n. 505 del 13 ottobre 2011REDAZIONE e TIPOGRAFIA:Via Solferino, 28 - 20121 Milano - Tel. 02-62821RCS MediaGroup S.p.A. Divisione PubblicitàVia A. Rizzoli, 8 - 20132 Milano - Tel. 02-25841© COPYRIGHT RCS MediaGroup S.p.A. Divisione QuotidianiTutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo prodotto puòessere riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
Lo sguardo di Appaduraisull’umanità degli slum
Non più arcaici retaggi La nuova antropologiasi proietta nel futurodi ADRIANO FAVOLE
Etica e sapere
L e società umane sono legate dauna fitta trama di fili che, diret-tamente o indirettamente, leconnettono le une alle altre,sosteneva Arjun Appadurai nel
libro del 1996 Modernità in polvere(Raffaello Cortina, 2012). La globalizza-zione degli ultimi trent’anni ha accele-rato la corrente che percorre le culture,dando vita, allo stesso tempo, a «gob-be» e «ostacoli» che, in alcune parti, nerallentano i percorsi. Fuor di metafora,la corrente è rappresentata dagli ingentiflussi di merci, persone e soprattuttorappresentazioni e immaginari che sidipanano nell’ecumene globale con sor-prendente velocità. Ciò che è rilevante,per Appadurai, non sono tanto i conte-nuti che viaggiano sulle reti (le reti onli-ne del web o le reti offline della comuni-cazione tradizionale), quanto le forme.Tra queste spiccano la «forma nazio-ne», le costituzioni e la democrazia a li-vello politico; i giornali, le soap opera epiù recentemente i social network a li-vello mediatico. Anche nelle aree delpianeta considerate più remote e perife-riche (dal Nepal alla Papua Nuova Gui-nea), gli esseri umani oggi «produconolocalità», ovvero costruiscono società eculture posizionate localmente, ma apartire da dialoghi, conflitti e negozia-zioni con quei format politici e mediati-ci che viaggiano senza sosta sulle retiglobali.
Di Appadurai esce il 26 febbraio in
Italia Il futuro come fatto culturale. Sag-gi sulla condizione globale (RaffaelloCortina). Conosciuto a livello interna-zionale come uno degli autori più im-portanti nel vasto campo interdiscipli-nare dei post-colonial studies, Appadu-rai ha di recente intensificato i legamicon il nostro Paese, intervenendo in se-minari accademici e in incontri con il pubblico (il suo intervento al Festival Dialoghi sull’Uomo di Pistoia, dal titoloCosì vicini, così lontani, è in pubblica-zione nel volume a più mani, L’oltre el’altro, Utet).
Gentile, affabile ed affabulante, pro-fondo conoscitore di Vico e della storiadei Comuni, sottilmente ironico e pun-gente, Appadurai incarna la figura «pro-totipica» dell’antropologo contempora-neo. Un antropologo che viene da «al-trove» — l’India — e parla di «noi» edella globalizzazione che ci circonda eci assedia, dando concretezza a quella reciprocità o inversione di sguardi tantospesso evocata. L’antropologo che rom-pe i confini disciplinari e si addentra neiterritori dell’economia, della sociologiae dei cultural studies. Lo scrittore che,conforme al clima post-moderno, evitadi dare vita a un paradigma teorico fortee onnicomprensivo, ma è capace di met-tere a punto concetti («flussi», «produ-zione di località», «democrazia profon-da», «etica della possibilità» contro«etica della probabilità») che aprononuovi sentieri nelle complesse forestedi significati che ci avvolgono.
Il futuro come fatto culturale nascedalla scommessa di rilanciare una teoriae una pratica della modernizzazione, ri-
partendo da Max Weber. Appadurai co-mincia però col criticare la modernizza-zione «europea» laddove si è connessaal progetto imperialista e laddove haconfuso l’universalismo con l’imposi-zione delle proprie traiettorie storiche.Occorre, secondo l’antropologo dellaNew York University, tenere ben presen-te le «sorprese» che la modernizzazioned’ancien régime ci ha riservato: «Il rifiu-to della religione di essere sacrificata sultavolo dello sviluppismo della scienzamoderna; la paradossale tendenza dellenuove tecnologie di comunicazione aincoraggiare la differenza culturale in-vece di rincorrere la somiglianza; la pro-pensione della voce popolare a preten-dere sangue, vendetta, guerra ed etnoci-dio (…) provando in questo modo la fal-sità delle correlazioni che ci si attendevatra istituzioni democratiche e crescita della tolleranza e della pazienza comevirtù politiche».
La globalizzazione non ha annullatole diversità culturali, come si era paven-tato, ma, ugualmente, non ha indeboli-to le diseguaglianze. Gli slum di Mum-bai in cui Appadurai compie le ricercheetnografiche che presenta nel libro so-no esemplari. La crescita in tutto ilmondo di megalopoli, che assumono l’aspetto di nuove «città-Stato», ha crea-to grandi sacche di non cittadini, abi-tanti delle città senza diritto a condivi-derne le risorse. I poveri di Mumbai abi-tano baracche o giacigli provvisori, va-gano in cerca di cibo e non hanno postiin cui depositare gli escrementi. Le so-cietà opulente producono affamati e licostringono a una nudità simbolica e reale nel momento in cui li privano del-l’intimità persino nel defecare.
Il panorama dipinto da Appadurai,tuttavia, non è così fosco. La costruzio-ne di pratiche inclusive e condivise dimodernizzazione sarà possibile se gliscienziati sociali, specie gli antropologi,sapranno guardare al futuro. In un’epo-ca di «pace fredda», caratterizzata da unbasso livello di conflittualità internazio-nale, ma da forti tensioni interne, il di-scorso sul futuro è stato monopolizzatoda economisti e speculatori. L’econo-mia dei disastri (finanziari e ambientali)è un’attività quanto mai lucrosa, basatasul calcolo probabilistico del rischio chequalcosa di grave possa succedere in fu-turo in qualche parte di mondo .
Riappropriarsi del futuro inteso co-me «fatto culturale» significa invecepassare da un’etica della probabilità aun’etica della possibilità, guardando al-le speranze e alle immagini della «buo-na vita» che ogni società elabora. L’an-tropologia ha dato priorità in passato al-lo studio delle culture come retaggi, alletradizioni, ai costumi: perlopiù ha cam-minato con lo sguardo volto all’indietro.È ora di indagare le costruzioni culturalidel futuro, le aspirazioni, i progetti, i so-gni che germogliano nelle località delmondo globalizzato. A Mumbai sono inprimo luogo i poveri a immaginare viedi uscita dalla miseria, a partire dalla lo-ro esperienza, ma anche dalle connes-sioni con i poveri di altre mega-città, re-se possibili dalle nuove tecnologie (il«cosmopolitismo» dei poveri).
Possibilità, speranza, immaginazio-ne, futuro sono le parole chiave che Ap-padurai consegna agli studiosi dellenuove generazioni, invitandoli a coglie-re «dal basso» l’improvvisazione e lacreatività culturale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’altro cosmopolitismoI diseredati immaginano vie di uscita dalla miseria
anche a partiredalle connessioni digitali
con quelli di altre città
SSS
protocapitalistiche della storia mondiale dell’epoca, ebberola possibilità di operare in quegli spazi, prima sostanzial-mente preclusi agli europei, lo fecero assumendo un ruoloda comprimarie, all’interno di una rete i cui punti nodali sitrovavano nel cuore dell’Asia.
In quella rete la scienza, di cui gli arabi avevano raccolto ilfilo greco-classico smarrito nel frattempo dall’Europa, in-trecciandolo con le raffinate conoscenze elaborate in India ein Cina e integrandolo con la propria ulteriore speculazione,godeva di un invidiabile stato di salute, mentre in Europastentava a emanciparsi dalla teologia. A quella araba si af-fiancò tra Due e Trecento — senza cancellarla — la globaliz-zazione mongola, che Gengis Khan e i suoi successori realiz-zarono a partire dalla dorsale della via della seta, un percor-so che attraversava, come ha scritto il geostorico ChristianGrataloup, «la più grande costruzione politica terrestre diogni tempo». Vi si incamminò, tra i tanti, anche il nostroMarco Polo, raggiungendo Khanbaliq (l’odierna Pechino).Lì, due secoli più tardi, sopravvisse per qualche tempo neigiardini della corte dei Ming una giraffa, che l’ammiraglio Zheng He, capo della maestosa flotta imperiale cinese, avevatrasbordato con successo in patria nei primi decenni delQuattrocento, prelevandola dall’entroterra di quelle costeafricane alle quali più volte era approdato, nel corso di viaggiche lo portarono a solcare gli immensi spazi di quello straor-dinario mare multiculturale, multietnico, multireligioso —l’Oceano Indiano — che si distendeva tra Africa e Asia. MaZheng He e la sua flotta non avevano fatto vela solo versol’Occidente. Orientando il timone in direzione nord, in que-gli stessi decenni si spinsero fino alla Kamchatka.
Non solo il mondo era policentrico, dunque, ma le sueparti dialogavano intensamente tra loro, prescindendo dal-l’intermediazione europea. E la stessa svolta cinquecentesca,se comportò un fenomeno di disseminazione degli europeisul globo (in America, ovviamente; ma in proporzioni assaipiù contenute anche in Asia; in misura quasi impercettibile,invece, in Africa), non si tradusse, a lungo, nell’avvio del-l’egemonia occidentale. Sotto molti punti di vista, le grandiciviltà asiatiche rimasero superiori a quella europea sino allafine del Settecento. E gli europei che visitavano quei luoghine erano, per lo più, pienamente consapevoli.
Così, se quella tra Medioevo e Età moderna è una cesurache ha naturalmente un senso per l’Europa e per la rimodu-lazione gerarchica dei suoi valori, mentre meno (o addirittu-ra nulla) ha da dirci in relazione alla storia delle grandi civil-tà asiatiche, diverso è indubbiamente il rilievo che, su scalaplanetaria, assunse quella tra Sette e Ottocento, per i motiviche abbiamo illustrato all’inizio. Diversamente da quello chel’aveva preceduto, il mondo globale che prese allora forma lofece sotto il segno di una superiorità europea che si lasciavaavvertire tanto, in primo luogo, sotto il profilo degli arma-menti, quanto sotto quello della crescita diseguale della ric-chezza e delle opportunità materiali e civili.
Ma quel mondo da tempo ormai sta cambiando. E certoanche per questo la metodologia della World History, basatasul riconoscimento del pluralismo e del policentrismo cul-turale e insofferente delle rigidità etnocentriche, ha oggi da-vanti a sé compiti importanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1050 a.C.Si affermala dinastiaZhou
770 a.C.Inizia l’epoca «Primaveree autunni».Si accentuanoi conflittiinterniall’impero
476 a.C.Il regnosi spezza, cominciail periododegli «Stati combattenti»
221 a.C.Il re Ying Zhengdi Qin riunificala Cina
202 a.C.Liu Bang fonda la dinastia Han,da cui prende il nome l’etnia cinese
581La dinastiaSui riunificala Cina
618Subentra la dinastia Tang, sotto la quale sono inventate stampa e polvere da sparo
907Nuova fasedi disgregazione,detta delle Cinque Dinastiee dei Dieci Stati
960-976 Taizu fonda la dinastia Song e conquistal’intera Cina. Si avvia una fase di modernizzazione
1260-1279Invasione dei mongoli,che fondano la dinastia Yuan
1368 La dinastia Mingcaccia i mongoli
1644 Invasori provenienti dalla Manciuriaconquistano Pechino e fondano la dinastia Qing
1842 Guerra dell’oppio: gli inglesi sconfiggonola Cina. Grave decadenza dell’impero
1912 Abdica Pu Yi, ultimoimperatore. Nasce la Repubblica
1949 Mao Zedong fondala nuova Cina comunista
Cro
nolo
gia
euro
cent
rica
Cro
nolo
gia
isla
mic
aC
rono
logi
ain
dian
aC
rono
logi
aci
nese
ANTICHITÀ
1800 a.C.Prima dinastiadi Babilonia
753 a.C.Fondazionedi Roma
La Lupacon i gemelli
Romolo e Remo,simbolo di Roma
Maometto predica ai suoi seguaciin una miniatura medievale
Una statuadel dio indiano
Shiva
Un guerrierodi terracotta di Xi’an
490478 a.C.Guerrepersiane
313 d.C.L’imperatore Costantinolegalizza il culto cristiano,che diventa egemone
476Caduta dell’imperoromano d’Occidente
800Incoronazionedi Carlo Magnoa sovranodel nuovoSacro RomanoImpero
1492Scopertadell’America
1648Pacedi Westfalia
1776Dichiarazioned’indipendenzaamericana
1914-1918Prima guerra mondiale
1939-1945Seconda guerramondiale
1989-1991Fine del sistemasovietico
1789Rivoluzionefrancese
1861Unità d’Italia
1517Riformaluterana
1095-1099Primacrociata
1347-1353Grandeepidemiadella pestenera
Conquista mongoladi Bagdad,fine degli Abbasidi
1453I turchi prendonoCostantinopoli
1718Pace di Passarowitz,fine dell’espansioneottomana in Europa
1839Inizio delle riformeoccidentalizzanti in Turchia
1299Nascitadel regnoottomanoin Turchia
1501I Safavidi alpotere in Iran
1736 Cade in Persiala dinastia Safavide,sostituita dagli Afsharididi stirpe turca
1517Conquistaislamicadell’India
1923Fine dell’impero ottomano,nasce la Repubblica turca
1947Fine del dominio britannico,nascono India e Pakistan
1971 Il Bangladeshsi stacca dal Pakistan
1857-1858 Rivolta repressa dagli inglesi.Tutta l’India sotto la corona britannica
Noi e gli altri, cronologie parallele
MEDIOEVO
1800 a.C. 100 d.C. 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
ETÀ MODERNA ETÀ CONTEMPORANEA
27 a.C.Augustodiventa il primoimperatoreromano
EPOCA DEI CALIFFATI
622 d.CAnno dell’Egira, Maomettofonda la prima comunità islamica661Nascita del califfato Omayyade di Damasco,il cui potere si estende dall’Iran alla Spagna
750Si afferma il califfato Abbasidedi Bagdad, che segna la maggiorefioritura della civiltà araba
DECADENZA
0d.C.a.C.
1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100
INDIA CLASSICA
486 a.C.Morte di Buddha
409 d.CLa dinastia Guptaunifica l’India
991Prime incursionimusulmanecontro i regniRajput327-325 a.C.
Spedizionedi AlessandroMagno in India
510Cade l’imperoGupta
DOMINIO MUSULMANO
1206In seguitoall’invasioneislamicanasceil sultanatodi Delhi
1398Tamerlanoinvadel’India
1739Sacco
di Delhida parte
dei persianidi Nadir
Shah
1763La Compagnia inglesedelle Indie ottienel’amministrazionedel Bengala
1803Gli inglesi conquistano Delhi
1517I Moghulislamiciregnanoin India
1258
1650 a.C.La dinastia Shang èla prima su cui esistano testimonianze storiche
1500 a.C.Nascela civiltà vedica
EPOCA DEGLI IMPERI ISLAMICIGRANDI IMPERI ISLAMICI
COLONIZZAZINEBRITANNICACOLONIZZAZIONEBRITANNICA
INDIPENDENZAINDIPENDENZA

24 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014