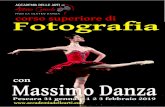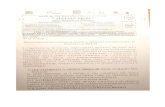Documento2 · Title: Microsoft Word - Documento2 Author: Massimo Created Date: 1/23/2017 4:45:16 PM
Transcript of Documento2 · Title: Microsoft Word - Documento2 Author: Massimo Created Date: 1/23/2017 4:45:16 PM

1

2
Sommario
Nascita casuale di un amore ................................................................................................................. 5
L’importanza delle regole .................................................................................................................... 7
Il Debate; il judo dell’intelletto ......................................................................................................... 10
Le sue origini ................................................................................................................................. 11
Struttura di un match di Debate ..................................................................................................... 11
Cosa occorre ............................................................................................................................... 12
A chi può essere utile il debate ...................................................................................................... 13
Le Life skills .............................................................................................................................. 14
Le competenze necessarie nel Debate ................................................................................................ 19
La comunicazione verbale ............................................................................................................. 20
Tono ................................................................................................................................... 20
Volume ............................................................................................................................... 21
Ritmo .................................................................................................................................. 21
La melodia o enfasi ............................................................................................................ 22
Alcuni nemici giurati di una buona comunicazione verbale: ..................................................... 23
Il public speaking ....................................................................................................................... 24
Come definiremo cosa dire e con quale priorità organizzare gli argomenti? ........................... 28
Stile deduttivo o induttivo? ........................................................................................................ 29
La comunicazione persuasiva .................................................................................................... 31
Metacomunicazione e linguaggio del corpo .................................................................................. 35
L’ascolto attivo .............................................................................................................................. 40
Ascoltare con tutti i sensi ........................................................................................................... 41
Il lavoro di gruppo.......................................................................................................................... 43
Il gruppo ..................................................................................................................................... 43
Capacità intellettive specifiche necessarie nel Debate ................................................................... 48
Attenzione e concentrazione ...................................................................................................... 48
Capacità di analisi e sintesi ........................................................................................................ 49
Saper fare una ricerca ................................................................................................................. 50
Le fasi di un match di Debate ........................................................................................................ 53
La strategia di gara e le fallacie logiche ......................................................................................... 55
La fase introduttiva .................................................................................................................... 55
La cross-examination ................................................................................................................. 56
La confutazione .......................................................................................................................... 56
Qualche consiglio pratico........................................................................................................... 57
Le fallacie logiche ..................................................................................................................... 59

3
Utilizzi del Debate nel mondo del lavoro .......................................................................................... 64
Il Debate nella comunicazione aziendale interna ....................................................................... 64
Il Debate nella formazione aziendale ......................................................................................... 68
Il Debate nell’Advocacy ............................................................................................................ 69
E adesso? ........................................................................................................................................ 73
Come apprendiamo .................................................................................................................... 73
Un test più semplice ................................................................................................................... 74
E con il Debate? ......................................................................................................................... 74
Allegato 1; l’uso efficiente di Google ............................................................................................ 76
Allegato 2; Regole e consigli per i giudici di una gara di debate .................................................. 80

4
hey there baby, I could use just a little help
you can’t start a fire you can’t start a fire without a spark
ehilà piccola, potrei avere un piccolo aiuto
tu non puoi appiccare un fuoco, tu non puoi appiccare un fuoco senza una scintilla
Bruce Springsteen; Dancing in the dark
Grazie a Gemma e Teresa Ducci che hanno avuto la pazienza di leggere, grazie a Dario Mastrogiacomo che mi ha dato la scintilla, grazie a Paolo Vergnani che ha soffiato sul fuoco.

5
Nascita casuale di un amore
Tempo fa un conoscente, mi chiede: “ma tu sai qualcosa del Debate?” Io confesso la più totale ignoranza ma prometto che mi informerò. Grazie dunque a Google, ovvero la bussola, il portolano, la stella cometa dei nostri giorni, scopro alcune cose:
a parte alcune scuole in Lombardia, che in modo pionieristico hanno abbracciato per i propri studenti questa disciplina, in Italia quasi nessuno ne sa nulla; insomma nella mia ignoranza sono in buona compagnia,
mentre studio le caratteristiche del Debate, sento nascere una forte attrazione che potremmo definire amore, intellettuale se volete, ma pur sempre amore.
Il Debate altro non è che un dibattito tra due squadre che contendono a suon di argomentazioni la fondatezza o l'infondatezza di un assunto. Per raggiungere il proprio scopo i contendenti useranno le vecchie ma sempre valide armi della dialettica, della retorica, della citazioni di fonti credibili e au-torevoli, insomma cercheranno di convincere gli ascoltatori con elementi oggettivi. Certo non disdegneranno però un efficace utilizzo del tono della voce, della gesticolazione, del lin-guaggio del corpo per essere ancora più persuasivi. Quindi di uno scontro si tratta, di un match con tanto di arbitri e di spettatori, con il naturale sano agonismo nei giocatori che ne può conseguire e chiaramente con il relativo divertimento di chi vi assisterà…..se i giocatori saranno bravi e se useranno bene le predette armi. Niente di nuovo si potrà pensare, poiché già qualche migliaio di anni fa si assisteva a giochi del ge-nere che avevano grande importanza nell’antica Grecia e successivamente a Roma. Tale dibattito è regolamentato in modo rigoroso affinché ogni "giocatore" (ma iniziamo a chiamarli con il loro vero nome: debater) abbia la possibilità di esprimersi, perché in conclusione prevalga quell'aurea regola che dichiara:
Non si discute per aver ragione ma per capire
Insomma il Debate enfatizza il potere della parola nel modo più nobile e questo può fare innamorare un vecchio formatore; si potrà obiettare che in questi tempi, di parole ne sentiamo fin troppe: volga-ri, manipolative, urlate, offensive. Non nel Debate! Qui le parole devono essere piene di valore, di contenuti e più che altro di utilità, affinché chi ascol-ta si faccia un’idea più chiara dell’argomento trattato. Ecco dunque spiegato l'amore per il Debate, rafforzato ancor di più dal contesto nel quale viviamo che me lo fa vedere come un indispensabile antidoto in un'epoca di sgomitatori sociali, come diceva Pasolini, di urlatori offensivi, di petulanti da talk show, un mondo nel quale la menzogna di oggi fa dimenticare quella ascoltata ieri e la manipolazione diviene regola.

6
Questa disciplina ci insegna a provare ciò che dichiariamo, a parlare dopo esserci documentati, ad ascoltare ciò che dice il nostro avversario e a contestarlo correttamente perché di avversario si tratta e non di un nemico da distruggere. Meglio di me lo esprime Gary Gillespie del Northwest College, Seattle Washington. “Oggi in queste nostre Olimpiadi intellettuali, noi possiamo godere di un gioco fondato sulla dia-lettica progettato per insegnare una delle più importanti lezioni di civiltà: come trasformare ciò che è peggio della natura umana in quello che è meglio ovvero come sostituire i simboli dell’aggressività privilegiando il dialogo alla violenza, la ragione alla forza.” Insomma il Debate ci insegna a usare la cultura, la ragione, la dialettica e l’ascolto oltre che a gioca-re pulito; come non amarlo?

7
L’importanza delle regole
Immaginate di essere un judoka esperto e immaginate pure che la vostra categoria di peso sia: “Uomini dai 66 ai 73 kg”; come molti sapranno, in questo sport vi sono regole precise che de-finiscono il comportamento da tenere sul tappeto, i punteggi, le sanzioni. Per esempio, per vedersi assegnare un “ippon”1 bisogna aver pra-ticato un atterramento che abbia tutte caratteristiche di caduta net-ta sulla schiena, di forza e di velocità. Insomma regole rigorose che evitino contestazioni, comportamenti scorretti e che, natural-mente, devono essere conosciute da ogni judoka. Riflettendoci noteremo che è poi questo il fine di ogni regolamen-tazione, dai giochi di carte fino alle leggi di uno Stato: fare in mo-do che le interazioni avvengano in modo prevedibile e senza con-flitti….o per meglio dire, senza troppi conflitti. Senza le regole non avremmo la boxe ma una rissa scomposta, nel traffico citta-dino sopravverrebbe il più aggressivo, nel poker vincerebbe il più prepotente, una gara di Formula Uno si trasformerebbe in un autoscontro. Torniamo dunque al judo; immaginate dunque di essere convocato con la vostra squadra per un match e che qualche secondo prima dell’incontro il giudice vi comunichi che voi combatterete secondo le regole del judo, ma che il vostro avversario, oltre a pesare molto più di voi, sarà do-tato di una gigantesca mazza ferrata e potrà colpirvi senza rispettare alcuna regola. Come pensate che finirà l’incontro? OK, ne parleremo appena vi dimetteranno dall’ospedale. Vi sembra un paragone assurdo? Allora pensate a quanto accade regolarmente nei dibattiti televisivi; a fronte di un argomento che viene proposto dal conduttore, possono trovarsi contrapposte due persone civili che si muoveranno in base a regole di rispetto reciproco e correttezza, ma quante volte vi è accaduto di assistere ad una situazione siffatta? Più frequentemente o incroceranno le armi (metaforiche) una persona più pacata e l’altra più aggressiva oppure, caso sempre più frequente, due persone aggressive. Cosa accadrà dunque? Nel primo caso la persona aggressiva urlerà, interromperà l’altro impedendogli di parlare, lo deriderà con il sarcasmo, cercherà di soverchiarlo in ogni modo. Alla fine potrà sembrare che sia stato più efficace nel dibattito, ma non sarà così perché questi avrà sconfitto l’altro non sul piano dei contenuti, che sono quelli che dovrebbero interessare gli ascoltatori, ma su quello della relazione. 1 Nel karate e nel judo, l'ippon (ja. «un colpo alla vita») è l'obiettivo dell'incontro: il suo conseguimento comporta l'as-
segnazione della vittoria. È paragonabile alla schienata nella lotta e al knock-out nel pugilato. L'ippon viene riconosciuto quando un atleta esegue una tecnica, nel rispetto del regolamento, che mette fuori combatti-mento l'avversario. Nel judo consiste nell'atteramento dell'avversario sulla schiena, in modo che non abbia alcun appog-gio al tatami (tappeto). Da Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Ippon

8
Nel secondo caso poi le cose non andranno meglio; assisteremo ad una imbarazzante rissa ver-bale che potrà piacere a coloro che rallentano in autostrada per vedere gli incidenti, insomma quelli che vogliono lo scontro violento, che amano vedere scorrere il sangue, ma certo non ci avrà fatto migliorare di una virgola nella conoscenza del problema posto come argomento di dibattito. Promuovere il Debate, ovvero la disciplina del dibattito regolamentato, per coloro che vi cre-dono, parte da un presupposto logico che spero condividerete:
Alla fine di un buon dibattito, indipendentemente da chi possa considerarsi vincitore, sia i due “contendenti”, sia chi era presente in qualità di ascoltato-re, dovrà uscirne arricchito di conoscenze, dovrà saperne di più sull’argomento della contesa e dovrà essere in grado di valutare, sulla base di quanto ascoltato, quale punto di vista deciderà di abbracciare. Intendiamoci nessuno si illude che la valutazione sarà perfettamente oggettiva, ovvero basata solo su fatti, dati concreti, fonti autorevoli. All’interno del giudizio conclusivo agiranno fattori che poco o nulla hanno a che fare con l’oggettività, infatti ricordiamo che la comunicazione “non verbale", ha un peso decisivo nelle relazioni. Si stima che il corpo sia determinante in almeno il 70% del messaggio trasmesso e che le parole ovvero il cosa dico, rappresentino solo una piccolissima fetta della comunica-zione rispetto al “come lo dico” e cioè a:
postura del corpo sguardo toni di voce gestualità.
All’interno del processo decisionale dei giudici di un match di Debate quindi, agiranno anche elementi non col-legati necessariamente a dati, numeri, esperienze docu-mentate, ma avranno il loro peso: il tono di voce che potrà essere caldo e suadente piuttosto che sgradevole o acuto, la gestualità che potrà accompagnare e rafforzare quanto detto oppure apparire rigida e fuori luogo e, insieme a tutto ciò che si defi-nisce “Linguaggio del corpo”, avrà spazio anche l’aspetto esteriore in omaggio a quanto so-stenuto dal grande Oscar Wilde ovvero che “Solo chi è superficiale non bada all’apparenza”. Il Debate però instrada le percezioni dei giudici attraverso un semplice strumento: una griglia di valutazione che renderà il giudice stesso quanto più oggettivo possa essere. In particolare i giudici dovranno focalizzare la loro attenzione su alcune aree quali:
Contenuti e capacità analitica del debater in particolare sulla completezza delle infor-mazioni, sull’attinenza tra l’oggetto del contendere e il suo discorso, sulla capacità di rispondere alle domande poste dall’altra squadra.
Sull’organizzazione del discorso poiché la sequenza con la quali i contenuti vengono presentati potrà agire sulla capacità persuasiva dei contenuti stessi.
Modalità di presentazione, considerando in tale area la correttezza del discorso da un punto di vista formale, l’utilizzo di metafore, il linguaggio del corpo.

9
Ecco dunque la forza di questa disciplina: promuovere un dibattito regolamentato rigorosamen-te e giudicato secondo regole standard. Regole e valutazione oggettiva dunque, e questo binomio vi dice sin d’ora come mai tale di-sciplina sia quasi totalmente sconosciuta nel nostro Paese.

10
Il Debate; il judo dell’intelletto
Mi piace paragonare il Debate al Judo giacché questa arte marziale già dal nome, presenta una sua
peculiarità che ben si adatta al Debate, infatti in kanji significa: 柔 (柔 jū, yawara, gentilezza, adat-
tabilità, cedevolezza, morbidezza) e 道 (道 dō, michi, via); traducibile come via dell'adattabilità, o
via della gentilezza. Insomma potremmo definire il Debate come “La via della Parola” 道単語
Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo, che consente di sviluppare capacità di argomentazione e di strutturare una serie di competenze “cosiddette trasversali”2 che contribuiscono
alla formazione della personalità. Il dibattito regolamentato, infatti, ha come proprio scopo quello di fornire gli strumenti per analizzare questioni complesse, per esporre, sostenere e difendere le proprie ragioni e valutare le altrui senza dirle o svalutarle; si dimentichi quindi ciò che quoti-mente si vede nei talk show televisivi che sono la tomba del dialogo. La tecnica del Debate sviluppa significative abilità analiti-che, critiche, argomentative e comunicative, sia verbali sia non verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza de-mocratica e partecipativa. Questa tecnica obbliga i “giocato-ri” o debaters a prendere coscienza non solo dei propri punti di vista, ma anche di quelli degli avversari; inoltre essa in-duce a chiedersi come percepiranno le nostre argomentazio-
ni gli ascoltatori e coloro che saranno poi giudici del dibattito. Si sarà dunque portati ad analizzare i propri punti di forza ma anche quelli di debolezza e a confron-tarli con quelli degli avversari. Insomma questa ampia visione di molteplici punti vista e opinioni, amplia la comprensione reci-proca e permette di trovare nuove intese, per una conclusione che non debba necessariamente pre-vedere la prevaricazione del più aggressivo ma la vittoria della logica e del buon senso. Si passa, in tal modo, dalla disputa fine a se stessa allo scontro dialettico.
2 Con competenze trasversali si intendono quelle caratteristiche personali dell’individuo alle quali egli attinge quando deve rispondere ad una richiesta dell'ambiente organizzativo, sociale, affettivo e che sono ormai ritenute basilari sia nel-la scuola che nel lavoro poiché consentono di trasformare una teorica conoscenza in un comportamento concreto. E-sempio di tali competenze trasversali sono: capacità decisionale, di relazione, di analisi e soluzione di criticità, di co-municazione, auto-organizzative e di gestione del tempo, di flessibilità mentale, di gestione di ansia e stress, leadership, attitudine al lavoro di gruppo.

11
Le sue origini Il debate ai nostri giorni è una disciplina prevalentemente anglosassone che da Stati Uniti e Gran Bretagna (si pensi che una importante scuola di Londra è stata fondata ai primi del 1800), si sta dif-fondendo rapidamente in tutto il mondo. Se vogliamo però le sue vere origini si possono far risalire alle scuole greche e romane di dialettica e logica alle quali si formò, tra gli altri, Cicerone. Cosa abbia allontanato il “Debate” dalle nostre sponde per fargli trovare una nuova casa in Gran Bretagna e Stati Uniti è presto detto: il nostro Paese nei secoli scorsi è passato da invasioni e domi-nazioni varie ad una suddivisione in tanti piccoli stati spesso litigiosi per arrivare ad una unità spac-ciata per liberazione ma che fu essenzialmente una guerra di conquista per motivi economici. Per non parlare dell’influenza sulla nostra cultura della religione spesso onnipresente. Non dimentichiamo inoltre vent’anni di dittatura che certo non sono lo sfondo ideale per la dialetti-ca e il confronto di opinioni diverse. L’Italia insomma ha conosciuto una vera democrazia solo dalla seconda guerra mondiale in poi e ancora oggi la cultura democratica non è molto radicata; una cultura realmente laica e aperta è anco-ra più recente e relativamente immatura. Questa disciplina è proprio l’espressione simbolica della dialettica democratica, dello scontro nel quale non vince la forza, il censo, il denaro ma la pura ragione; ecco perché fa un po’ fatica a radi-carsi presso di noi…..ma cerchiamo di essere ottimisti.
Struttura di un match di Debate Anche se in momenti successivi di questo scritto si entrerà meglio nel dettaglio, pensiamo sia op-portuno dare a chi legge una idea immediata di cosa sia un match di Debate, in tal modo sarà più fa-cile poi allocare nel posto giusto i vari concetti che seguiranno. Ecco dunque come materialmente andrà organizzato un incontro tra due squadre.
1. Gli Organizzatori del match scelgono un tema e lo comunicano ai team con sufficiente anti-cipo (una settimana almeno) affinché le squadre possano studiarlo e prepararsi. In questa oc-casione si deve anche comunicare quale sarà la squadra “positiva” ovvero quella che dovrà dimostrare la validità del tema scelto e quale la “negativa”, che naturalmente avrà il compi-to opposto. Mentre le squadre sono già formate, l’attribuzione del ruolo di positiva o negati-va sarà definito per sorteggio.
2. Al momento del dibattito un moderatore scelto dall'organizzazione dichiara: il tema di discussione i tempi degli interventi, le regole del gioco la composizione delle squadre
Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione della norme o regolamenti, la sua deci-sione è definitiva.
3. Il tema di discussione deve essere sempre comunicato in forma positiva, ad esempio: l’alimentazione prevalentemente vegetariana è di valido aiuto alla salute in chiave pre-ventiva. Oppure: se in un altro Paese sono minacciati i diritti basilari dell’Uomo il nostro Paese deve considerare l’ipotesi di intervenire, ecc.
4. Il moderatore presiede ogni dibattito e, per quanto possibile, non deve giudicare o tenere il tempo. Il suo ruolo è semplicemente quello di mantenere l'ordine e far rispettare le regole:

12
lui o lei non dovrebbe partecipare attivamente al dibattito a meno che ciò sia necessario per tutelare i diritti di un partecipante. Le squadre devono accettare le decisioni del moderatore.
5. Deve esserci un cronometrista con il compito di tenere il tempo di ogni intervento, egli può comunicare rapidamente ai debater (preferibilmente con dei gesti per non interromperli) di quanto tempo dispongono ancora. Passato il tempo assegnato con una tolleranza non supe-riore ai 15 secondi, il cronometrista lo comunica al moderatore che blocca l’intervento. Non ci sono regole prescritte per il tempo dei singoli interventi; si potrà andare dai 5 ai 15 minuti, ma nel complesso sarà bene restare su tempi brevi poiché la capacità di attenzione delle per-sone non è molto alta.
6. Ogni dibattito, come detto, avverrà tra due squadre opposte: una squadra detta positiva o af-fermativa che sostiene il tema di discussione e una squadra negativa o oppositiva che ne contesta la validità o propone una soluzione alternativa. Il moderatore si siede tra le squadre, con quella positiva alla sua destra.
7. In ogni dibattito, ogni squadra deve avere la stessa quantità di tempo a disposizione, così come i singoli debaters.
8. Il dibattito deve essere valutato da almeno 3 giudici di provenienza diversa da quella dei giocatori delle due squadre. Il giudizio dovrebbe essere il più possibile oggettivo ovvero ba-sato su fatti, numeri, dati concreti.
9. L’onere della dimostrazione sta alla squadra positiva che deve dimostrare la correttezza dell’assunto di partenza; se non ci riesce perderà il dibattito.
10. Il debate deve essere continuo e senza pause, ma il moderatore può fissare brevi intervalli per permettere ai giudici di prendere appunti su quanto ascoltato. Si possono concedere dieci minuti alle squadre prima delle conclusioni degli ultimi debaters.
11. I debaters possono usare ausili visivi o altri elementi concreti durante un dibattito, ma tali sussidi dovranno successivamente essere disponibili per l'utilizzo da parte degli avversari.
12. I debaters non possono fare commenti personali durante gli interventi degli altri oratori. Una squadra però può, alla fine dello speech, porre ai giudici una domanda relativa all’intervento in corso; i giudici valuteranno se la domanda sia pertinente o meno e in caso di non risposta o risposta inadeguata, il punto in questione si considererà appannaggio di chi ha fatto la do-manda.
13. I debaters devono fornire prove oggettive delle loro affermazioni e il giocatore che fornisse prove false sarà squalificato e la sua squadra penalizzata.
14. È vietato leggere salvo in caso di citazioni specifiche e brevi; un eccesso in tal senso sarà penalizzato dai giudici.
15. Il debater parla da solo e non può consultare i colleghi o chiedere loro aiuto; non ci si può servire di portatile, tablet, smartphone o altri supporti digitali.
16. Il turpiloquio è assolutamente vietato e i giudici valuteranno in che misura punirne l’uso. 17. L’umorismo è consentito o addirittura consigliato; l’eccesso di sarcasmo contro gli avversari
sarà bloccato dai giudici.
Cosa occorre
Circa 12 – 16 persone così suddivise: due squadre di 3 – 5 persone 3 giudici un moderatore un cronometrista un responsabile

13
non sono indispensabili supporti audiovisivi deve esserci un adeguato numero di seggiole per i ruoli predetti e eventualmente per il pub-
blico Se una squadra ha bisogno di mostrare delle prove tramite o la presentazione di oggetti o la proie-zione di video/immagini, dovrà consentire la stessa facoltà agli avversari.
A chi può essere utile il debate
I naturali beneficiari di questa disciplina sono, come è facile immaginare, gli studenti a partire dalle scuole medie fino all’università, perché le competenze che il Debate sviluppa e rafforza ovvero quelle analitiche, critiche, argomentative e comunicative, saranno sicuramente utili nel percorso scolastico o accademico. Ciò è confermato dall’uso positivo che di tale disciplina si fa nei paesi di lingua inglese, dove i college hanno una loro squadra che gareggia con le altre in un vero e proprio campionato e alcune università, ad esempio Harvard, hanno una squadra addirittura leggendaria per la sua imbattibilità. Insomma anche nel Debate esistono squadre come i Chicago Bulls o il Real Madrid.3 Studio scolastico e Debate sono un connubio immediato; si pensi che nell’istante in cui sarà comu-nicato l’argomento del match alle due squadre, inizierà una fase di ricerca su varie fonti, da quelle tradizionali a Internet, dalla quale potrebbe dipendere l’esito del match. Trovare dati, analizzarli e poi sintetizzarli, individuare testimonianze significative e trasformare il tutto in un discorso chiaro, comprensibile; ecco in cosa consisterà il lavoro preliminare delle squa-dre senza dimenticare le prove, le simulazioni. Appare fin troppo scontato quanto questo “allenamento” possa essere d’aiuto nel lavoro scolastico. Non si dimentichi però che le competenze trasversali cui si è fatto riferimento sono sempre più ri-chieste nel mondo del lavoro e spesso oggetto di attenta analisi da coloro che fanno ricerca del per-sonale; questo per un motivo non secondario. Al capo del personale di una grande azienda anglo-americana si attribuisce la fin troppo abusata fra-se: “Si può sempre addestrare un tacchino a salire sugli alberi ma è meglio cercare uno scoiatto-lo”. Cosa significa questa frase aldilà dell’umorismo che contiene? In ogni lavoro, affinché la sua esecuzione sia svolta nel modo più efficace, occorrono una serie di competenze che spesso vengono messe tutte nello stesso fascio ma che invece si distinguono note-volmente le une dalle altre. Normalmente si adopera una tripartizione classica che vede come contributive allo svolgimento ide-ale di un compito:
a) le competenze cognitive ovvero il sapere teorico necessario a svolgere un’attività, quell’insieme di concetti, norme, regole, leggi senza le quali si apprenderebbe solo per tenta-tivi ed errori ovvero “tâtonnement”, come si direbbe in alcune teorie psicopedagogiche, in-
3 lo scorso anno ben 48 stati hanno partecipato al World School Debating Championship, tenutosi in Sud Africa; le
registrazioni on-line all’European University Championship, che si terrà il prossimo agosto a Belgrado, hanno esaurito i posti disponibili in soli 43 secondi, record che solo i concerti dei più famosi cantanti riescono a battere, l’International Debate Education Association ha censito nel 2011 ben 542 società di dibattito, ma di queste una sola è italiana. Tratto da http://www.iisviasalvini.gov.it/attachments/article/262/Progetto%20DEBATE.pdf

tendendo per questo dell’evoluzione umana; insommaefficiente,
b) le capacità pratiche dette
ché, come molti sanno perfettamentescere a memoria codici e non equivale a saper pilotare
c) e infine ci sono appunto
motive, abilità psicosociali Cosa sono? Per Wikipedia possonotrano in gioco quando egli rispondete essenziali in ambito lavorativotrasversali? Perché, tanto per usare come esempiopacità di pianificazione e quellasponsabili di un supermercato siaInsomma mentre con un cambioandranno perse o sostanzialmentenon a caso vengono anche dette “trasferibili”.
Le Life skills Considerando che oggigiorno siaaccademico sia quello lavorativotanza a queste competenze, saràqualche approfondimento giacchécapacità che il Debate ci aiuterà zare.
In inglese vengono definite conmente altisonante di “Life Skills”cità per la vita o di vita. Con essedi abilità cognitive, emotive e relazionali,sentono di operare in modo adeguatobientali sia a livello individuale in parole più semplici, le Life Skillsla gamma di competenze che ci cela” nelle varie situazioni complessediana ci presenta. Un amico ha bisognodifficoltà relazionali a scuola, mi da queste situazioni. Cercherò aiutoO metterò all’opera le mie life skills?
In tal senso il termine usato non vanella vita di tutti i giorni. Poiché sono considerate essenzialicosa valga anche per gli adulti,
14
apprendimento a tentoni uno degli elementiinsomma si apprenderebbe in modo primordiale
in alcuni casi algoritmiche, ovvero il saper fareperfettamente, conoscere non vuol dire saper fare.
pandette ed essere un pessimo avvocato, sapernetare un aereo;
le competenze trasversali, definite di volta inpsicosociali o comportamentali e così via.
possono definirsi “quelle caratteristiche personalirisponde ad una richiesta dell'ambiente organizzativo
lavorativo per trasformare una conoscenza in comportamento”
esempio alcune delle più tipiche competenze trasversaliquella di gestire il tempo, queste abilità ci serviranno
sia che, cambiando lavoro, divenissimo i proprietaricambio di professione le competenze afferenti i primi
sostanzialmente modificate, le competenze trasversali le por“trasferibili”.
sia il mondo scolastico e lavorativo, danno molta impor-
sarà opportuno dedicarvi giacché sono proprio quelle
a sviluppare o raffor-
con il termine apparente-Skills”, letteralmente capa-
esse si intende un insieme relazionali, che ci con-
adeguato agli stimoli am- che sociale. Per dirla
Skills costituiscono quel- permettono di “cavar-
complesse che la vita quoti-bisogno del mio sostegno più psicologico che si pone un problema che non ho mai affrontato
aiuto da altri perché non mi sento in grado di reagireskills?
va inteso come “capacità vitali” bensì come capacità
essenziali nel benessere di bambini e adolescenti, maadulti, il nucleo basilare delle Life Skills viene analizzato
elementi fondamentali primordiale e certamente pocco
fare concretamente poi-fare. Si possono cono-
saperne di aerodinamica
in volta competenze e-
personali dell'individuo che en-organizzativo e che sono ritenu-
comportamento” ma perché
trasversali quali: la ca-serviranno sia se saremo re-
proprietari di una azienda. primi due ambiti spesso
portiamo sempre con noi,
che pratico, mio figlio ha affrontato prima; come uscirò
reagire adeguatamente?
capacità che ci aiutano
ma non escluderei che la analizzato anche dalla

15
l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), secondo tale ente il nucleo è costituito da 10 com-petenze:
1. Consapevolezza di sé
Area emotiva 2. Gestione delle emozioni
3. Gestione dello stress
4. Empatia
Area relazionale 5. Comunicazione efficace
6. Relazioni efficaci
7. Risolvere problemi
Area cognitiva 8. Prendere buone decisioni
9. Senso critico
10. Creatività
Esse a loro volta possono essere elencate in tre aree:
Nell’area emotiva troviamo: consapevolezza di se, gestione delle emozioni, gestione dello stress
In quella relazionale avremo: empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci
E infine in quella cognitiva vi saranno: problem solving, presa di decisioni, senso critico, creatività
Guardiamole nel dettaglio:
1. la consapevolezza di se o conoscenza di se stessi, considerata da secoli come il punto di partenza e di arrivo della vera conoscenza4, significa conoscere i propri punti di forza come pure quelli di debolezza, conoscere le emozioni che si proveranno in determinate situazioni, sapere cosa si vuole davvero nella vita. Tale consapevolezza è utile perché ci permette di prevedere come reagiremo in certi contesti; saremo dunque in grado di prendere decisioni che siano coerenti con noi stessi e i nostri obiettivi. Insomma se sono una persona ansiosa farò meglio a scegliere un lavoro che mi da certezze e non il commercio o l’imprenditoria dove il rischio è parte del lavoro stesso. Nel Debate questa competenza ha un’importanza al-ta.
4 conosci te stesso (in greco antico: γνῶθι σαυτόν, gnōthi sautón) è la massima scolpita nel tempio di Apollo a Delfi è
attribuita a vari saggi dell’antichità ma i più propendono per Chilone.

16
2. la gestione delle emozioni nasce dal divario che è ormai nato tra come reagiamo emotiva-mente e cosa invece ci chiede l’ambiente sociale. Può sembrare assurdo ma le nostre emo-zioni sono antiche e allo stato attuale leggermente inadeguate; insomma che il cuore batta più forte facendo pulsare più sangue, incrementando l’adrenalina e facendo scorrere mag-giormente un enzima che coaguli il sangue delle ferite, poteva essere utile millenni fa, ma ora? Attenzione però che gestire le emozioni non vuole dire frenarle o nasconderle (scelta altamente stressante) ma trasformare il negativo in positivo. Se un cliente maleducato mi aggredisce verbalmente, io non devo re-agire ovvero essere anche io aggressivo; probabil-mente non risolverei la situazione e perderei il cliente. Dovrò scegliere la migliore linea di azione perché avrò gestito la mia emozione dicendomi: non sta aggredendo me ma l’azienda che lo ha trattato male, quindi non posso reagire come lui perché così facendo confermerei la sua idea, etc. etc. ……….. Nel Debate anche questa competenza ha un’importanza alta.
3. la gestione dello stress, da sempre importante, lo è oggi ancora di più poiché essendo lo stress una reazione adattiva alle richieste che l’ambiente ci invia, nessuno può negare che la quantità e la qualità di queste richieste aumenta sempre più. Ma cosa significa gestire lo stress? Significa saper ascoltare i segnali del nostro corpo e della nostra mente, risalire alle fonti dello stress (gli stressor) per capire quando è il momento di mettere in pratica attività di reazione che possono andare da una breve vacanza, a tecniche di respirazione (yoga, training autogeno) fino a capire che sto caricandomi di troppi impegni e quindi devo rinunciare a qualcosa. Perché? Semplice, perché lo stress è fonte di malattie, debolezza, malessere. Con-siderando che nel Debate i tempi di un match sono brevissimi e quindi lo stress è molto con-centrato, si capisce che questa competenza è essenziale.
4. l’empatia è la capacità di pensare come sta pensando l’altro, capire cosa pensa e cosa prova, insomma mettersi nei suoi panni o se preferite l’espressione inglese nelle sue scarpe (if you were in my shoes, se tu fossi nelle mie scarpe ovvero al posto mio). Saper ascoltare è l’insostituibile punto di partenza di tale abilità che ci permette di avere buone relazioni con tutti. Attenzione però a non confonderla con la simpatia poiché se provare a capire cosa sen-te l’altro può essere positivo, immedesimarsi completamente e provare tutto ciò che l’altro prova può essere faticoso fino all’autolesionismo. Nel Debate saper pensare che penserà l’avversario, può trasformarsi nella vostra carta vincente, essere un attento ascoltatore al-trettanto; anche in questo caso parliamo di una competenza importante.
5. la comunicazione efficace. Se partiamo dall’assunto che tutto nella nostra vita è comunica-zione potrebbe essere superfluo chiedersi perché mai dovremmo sviluppare la capacità di comunicare bene. In situazioni sociali, ovvero sempre, a meno che non viviamo come Ro-binson Crusoe, tutto ciò che diciamo o facciamo ma anche quello che non diciamo o non facciamo è comunque comunicazione. Con la comunicazione esprimiamo noi stessi, condi-vidiamo le nostre idee con la comunicazione ascoltiamo gli altri e li comprendiamo. Non a caso il primo assioma della comunicazione dice: non si può non comunicare. Perché nel Debate sia importante saper comunicare in modo efficace rischia di essere ridondante; il Debate è comunicazione. Potremo aver effettuato le più attente ricerche, aver scritto gli spe-ech più affascinanti, ma senza una buona comunicazione sarà stato tutto inutile; parliamo dunque della competenza fondamentale su cui poggerà tutto il resto e in assenza della quale tutto crollerà.

17
6. con relazioni efficaci si intende la capacità di creare e mantenere relazioni significative e non superficiali, come pure sapere quando è il momento di interrompere relazioni inadegua-te o peggio faticose da mandare avanti. Non basta; all’interno di tali relazioni dovremo esse-re assertivi, cioè capaci di far valere noi stessi, le nostre attese, i nostri bisogni senza essere aggressivi o remissivi. La capacità di costruire e tenere relazioni è considerato come un must per i manager. Nel Debate ha un’importanza relativamente limitata.
7. risolvere problemi è considerato attualmente come uno standard di valutazione
dell’intelligenza, ma cosa è un problema? È un evento che ci fa deviare dalla strada immagi-nata impedendoci di raggiungere la meta oppure rallentando il nostro cammino. In questi frangenti ci aiuta la capacità di analizzare la situazione e il contesto ambientale, comprende-re le nostre attese e quelle delle altre parti coinvolte e individuare la soluzione più efficace. Competenza importantissima nella vita e nel lavoro, ha nel Debate una importanza media.
8. saper prendere decisioni è una competenza dallo spettro tremendamente ampio: cambiare
macchina e riparare la vecchia? Sposare la persona amata o andare solo a conviverci? Cam-biare lavoro e guadagnare di più rischiando o tenersi il vecchio ed essere più tranquilli? Per non parlare poi delle micro decisioni che ci capitano ad ogni passo, noi trascorriamo lette-ralmente la giornata prendendo decisioni grandi e piccole. Interessante è notare che la parola decidere deriva dal latino caedere ovvero tagliare; infatti quando decidiamo noi optiamo per una scelta e tagliamo le altre possibilità. situazione ansiogena poiché rimane latente il dub-bio di aver scartato forse opzioni migliori. Ci aiuta nel processo decisionale un vero e pro-prio set di strumenti: esperienza, fiducia in se, intuito e in tali casi alcuni strumenti di tipo più “scientifico” come l’albero delle decisioni; rimane comunque il fatto che decidere è im-pegnativo e stressanti. Molti, per tale motivo, non decidono affatto e rimangono in situazio-ne di incertezza ma ricordiamo che decidere di non decidere…..è pur sempre una decisione. Anche questa è una competenza importantissima nella vita e nel lavoro, ma che ha nel Deba-te una importanza media.
9. possedere senso critico può apparire come un’espressione talmente generica da perdere
quasi significato. Usiamo queste parole in certe frasi fatte che lasciano il tempo che trovano: certe volte manchi di senso critico, è una persona con un gran senso critico. Ma cosa signifi-ca in fondo? Parliamo in questi casi della capacità di fermarsi di fronte agli eventi che si ac-calcano intorno a noi, analizzarli lucidamente, distinguere le opinioni dai fatti, filtrare i pre-giudizi nostri e altrui come pure conoscere i nostri filtri percettivi e capire quanto stanno in-fluenzando i nostri pensieri e le possibili decisioni. È una sorta di capacità di prendere le di-stanze dalla realtà per valutarla con la maggiore oggettività possibile. Nel Debate questa competenza è molto importante.
10. sulla creatività si sono scritti libri in quantità e definirla in poche righe potrebbe apparire
superficiale. Ho sentito dozzine di definizioni, ma quella che mi è piaciuta di più la descri-veva come la capacità di uscire dagli schemi consolidati. Non si cada nell’inganno di cre-dere che riguardi solo gli artisti e i bambini, la creatività è in tutti noi e l’ambiente nel quale cresciamo può aiutarci a svilupparla o la può spazzare via come inutile. Chiunque lavori ha sentito frasi tipo: ma dove le vai a pescare queste idee? Oppure: mai sentita una cosa simile, lasciamo perdere….se avessero risposto così al allora giovane ricercatore inglese del CERN Tim Berners Lee, oggi non avremmo Internet. Quando sorge un problema nuovo ed inatteso, quando una vecchia soluzione appare ormai inadeguata, la creatività ci permette di pensare ad altre strade, ad immaginare alternative che sfuggono ad un pensiero ripetitivo. Questa competenza di importanza vitale, è parimenti importante nel Debate.

18
Il Debate sviluppa e potenzia molte di tali competenze che, oltre alla loro intrinseca utilità nella vita quotidiana sono, come detto in precedenza, le più ricercate dalle aziende, poiché mentre conoscen-ze e capacità possono essere trasferite con la formazione e con l’esperienza sul campo, le compe-tenze trasversali sono molto più complesse da implementare e non sempre può servire la formazione tradizionale; insomma per tornare alla frase di partenza, se in azienda occorre qualcuno che sappia arrampicarsi sarà più facile cercare tra gli scoiattoli, se invece servirà qualcuno che difenda l’aia dai serpenti, il tacchino sarà perfetto. Non a caso la seconda parte di questo libro esplorerà, in modo sintetico, le possibili forme di utiliz-zo del Debate nel mondo del lavoro dove potrebbe essere considerato sia uno strumento formativo che di comunicazione interna. Ecco perché il Debate non solo continuerà ad essere utile a quegli studenti prima citati, nel loro per-corso didattico e una volta che si appresteranno ad entrare nel mondo del lavoro, ma anche a coloro che in tale mondo già operano e vogliano migliorare la propria posizione o solo desiderino sentirsi più adeguati. Per tutti gli altri si tratta di una vera e propria ginnastica mentale, da praticare in una palestra di ci-viltà e rispetto reciproco; e ditemi se di questi tempi non ne abbiamo tutti un disperato bisogno.

19
Le competenze necessarie nel Debate
In una gara di Debate l'obiettivo di ogni giocatore o debater è dimostrare la correttezza di un assun-to o di contro, dimostrarne l'erroneità. In entrambi i casi quindi bisognerà essere persuasivi; tale capacità però è una pietanza complessa che ha al suo interno più ingredienti.
Non basterà avere una buona dialettica, poiché i giudici valuteranno anche i dati oggettivi, le fonti, gli esempi che il debater porterà a sostegno della propria tesi e tutto ciò sarà il frutto di una buona capacità di fare ricerca oltre che di una innata curiosità. Appare perfino superfluo dire che una discreta cultura generale sarà molto utile sia nella fase preparatoria che durante il match vero e proprio.
Poiché si acquisiranno punti se si riuscirà a met-tere in discussione ciò che l'avversario ha soste-nuto, sarà importante fare domande ben mirate a individuare i punti deboli della sua tesi; ad e-sempio: “Quando il mio avversario dichiara che la medicina omeopatica è efficace, esprime un suo parere o si riferisce a fonti certe, e in tal caso può citarci queste fonti?”. Questo prevederà capacità di ascolto e di analisi oltreché una notevole prontezza nel cogliere gli aspetti salienti di una tesi e i suoi punti deboli.
Sarà determinante presentare i propri argomenti in una sequenza logica e scorrevole, affinché questi conducano per mano gli ascoltatori lungo il percorso desiderato e ciò nascerà da una ca-pacità in parte innata e in parte appresa di crearsi un ordine mentale, intuire i legami logici, de-finire le priorità.
Infine nel dopo gara bisognerà riflettere criticamente su quanto accaduto per apprendere dall'e-sperienza poiché sarà relativo il vincere o perdere, ma in ogni caso si dovrà apprendere: dai suc-cessi per individuare i punti di forza e dagli insuccessi per agire sui punti di debolezza. Questa fase merita ancora un approfondimento; in nessuna disciplina esistono gli infallibili, in quelle che prevedono la contesa non c’è nessuno che vince sempre, allora chi sarà un buon debater? Colei o colui che da ogni match avrà appreso qualcosa. Ecco perché la fase di analisi suc-cessiva al match, da svolgere non immediatamente dopo ma comunque in tempi brevi, dovrà e-videnziare cosa la squadra ha fatto bene per poter consolidare i punti di forza e cosa invece è stato inefficace e la prossima volta andrà fatto meglio. Non si dovrà cadere nella trappola di cer-care un responsabile, in caso di sconfitta, perché il punto saliente sarà comprendere le cause. Non effettuare questo momento di debriefing significherà trascurare un patrimonio di esperien-za di grande valore.
Facile dunque concludere che il Debate è una disciplina complessa, nella quale si potrà eccellere a condizione di possedere in partenza alcune caratteristiche che, in quanto atteggiamenti mentali, sa-ranno non apprendibili quali:
curiosità, rispetto per gli altri e le loro opinioni, empatia, estroversione necessaria per lavorare bene con gli altri giocatori.

20
Date per possedute in quanto innate tali caratteristiche, bisognerà integrarle e quindi essere formati e/o auto formarsi su competenze quali:
comunicazione verbale public speaking organizzazione degli argomenti comunicazione persuasiva metacomunicazione e linguaggio del corpo ascolto attivo lavoro di gruppo capacità intellettive specifiche della disciplina saper fare ricerca
Con il tempo e quindi con l’esperienza si maturerà la capacità di pensare e attuare una strategia di gara che cambierà di volta in volta in funzione dell’argomento del dibattito, dei giocatori e anche degli avversari. In tale ambito riconoscere le fallacie logiche5 nei propri ragionamenti per evitarle, e in quelli degli avversari per sottolinearle indebolendoli, potrà dare certamente qualche beneficio. E infine la componente essenziale sarà fare tanta, tanta pratica, poiché il Debate non si impara con la teoria, ma principalmente agendo. Senza la presunzione di voler essere completi, ma solo con la speranza di fare qualcosa di utile, in-somma di scrivere una sorta di piccolo manuale di cucina, proviamo ad approfondire alcuni punti relativi alle competenze necessarie.
La comunicazione verbale La comunicazione verbale è il modo con il quale offriamo le nostre opinioni, le nostre idee e con-vincimenti agli ascoltatori, ma attenzione perché dentro di essa c'è molto di più delle semplici paro-le. La comunicazione verbale è infatti connotata da:
Tono: non confondiamolo con il volume della voce anche se nel comune parlare questo errore
lo si compie spesso. Il tono è la possibilità e la capacità di modulare la voce per rendere più chiaro o attraente ciò che diciamo ed è molto importante; quindi possiamo definire tono tutto ciò che ha a che fare con i vari fenomeni del parlare e che vanno oltre il contenuto delle parole, insomma è tutto ciò che siamo in grado di dire "oltre le parole". Il tono può essere alto ovvero acuto o basso al contrario e ciò dipenderà da dove produciamo la voce stessa. Chi la produce in gola, come molte donne, avrà un tono acuto mentre chi la produce in petto avrà un tono più bas-so. Ricordiamo che le voci basse sono più gradevoli e meno faticose da ascoltare, mentre le voci acute hanno l'effetto opposto fino ad arrivare ad una vera e propria fatica da ascolto per coloro che hanno una voce acuta e metallica. Infine sarà importante modulare il tono della voce poiché da tale varietà dipenderà la gradevolezza dell'ascolto. Non a caso un tono uniforme viene defini-
5 In logica si è soliti riservare il termine fallacia a quegli argomenti che, pur essendo scorretti, appaiono psicologica-
mente persuasivi. Definiamo quindi come fallacia ogni forma di argomento che sembri corretta ma che, in seguito a e-same, si dimostri non essere tale. » (Irving Copi, Introduzione alla logica)

21
to:monotono. Di regola ci si attende più un tono che un determinato contenuto, per cui accadrà che chi ascolta presterà più attenzione al tono che al contenuto verbale di un discorso. Si narra che Mark Twain, avendo fatto una scommessa con degli amici, proprio sulla teoria che le persone badassero principalmente al come le cose vengono dette e non a cosa venga detto, ar-rivasse con notevole ritardo ad una cena cui era stato invitato. La padrona di casa gli corso incontro appena arrivato, era l’ospite d’onore della serata, dicendo-gli: “Signor Twain non sapevo cosa pensare e mi chiedevo se iniziare a mangiare o rimettere l’arrosto in forno in sua attesa.” Lo scrittore americano parlando rapidamente e con un sentito tono di scusa le disse: “Mi perdoni signora, mi perdoni ma ho dovuto strangolare la mia vec-chia zia e ho tardato”. “Va bene, va bene - disse la padrona di casa- l’importante è che ce l’abbia fatta.” Si può lavorare sul tono di voce per migliorarlo? Parzialmente si, ma sarà necessario imparare la cosiddetta respirazione bassa o diaframmatica. Non è certo difficile e qualunque corso di yoga potrà permetterci di impararla; questo tipo di respirazione avrà anche ulteriori vantaggi:
o Non ci farà finire in debito di ossigeno quando parliamo in pubblico. o Sarà utile come tecnica di rilassamento per attenuare la naturale ansia che avremo
prima di ogni match di Debate. Ai nostri fini, comprendiamo nella definizione di tono anche le espressioni sonore6 senza conte-nuto quali: sospirare, sbadigliare , grugnire o emettere quella sorta di rumore bianco (mmmmmm) che usiamo per riempire il silenzio quando non sappiamo cosa dire. Nei limiti del possibile (purtroppo diventano una sorta di vizio e neppure ce ne accorgiamo) vanno evitate perché rendono fastidiosa la comunicazione.
Volume: qui non ci sono fraintendimenti, parliamo della quantità di decibel che emettiamo.
Possiamo sussurrare o urlare, rammentiamo però che nella percezione altrui coloro che parlano con un volume di voce molto basso sono considerate timide o insicure mentre coloro che urlano vengono considerati aggressivi. Il volume di voce basso è quello dell’intimismo, delle riflessio-ni; quello alto si riserva alle cose da rendere pubbliche. L'ideale sarebbe variare il volume, così come accade nella musica. Anche per il volume saranno importanti gli esercizi di respirazione che ci permetteranno di fare arrivare lontano la voce senza gridare.
Ritmo: con tale termine si intende la frequenza di parole che facciamo entrare in una unità di
tempo, nel nostro caso, in un minuto. Possiamo definire il nostro ritmo nel parlare: • lento quando utilizziamo circa 200 sillabe (70 parole) al minuto • normale quando inseriremo circa 350 sillabe (125 parole) al minuto • veloce quando infine saranno circa 500 le sillabe (180 parole) che diremo in un minuto Teniamo a mente che un ritmo troppo intenso ha varie controindicazioni:
o non permette al nostro interlocutore......... di interloquire, il che se vogliamo nel par-lare in pubblico potrebbe non avere importanza,
6 Si definiscono: interiezioni prosodiche

22
o trasmette una sensazione di fretta, chi parla rapidamente infatti sembra non veda l'ora di finire, il che non è certo un segnale positivo,
o si corre il rischio che l'ascoltatore perda dei pezzi di conversazione o la comprenda solo parzialmente poiché non potrà mai soffermarsi a riflettere su quanto ascolta,
o il ritmo veloce è ansiogeno, infatti agisce sul ritmo cardiaco dell'ascoltatore, accelle-randolo. A molti sarà capitato di parlare con persone che ci facevano venire voglia di dire: per favore rallenta che mi fai venire l'ansia. Ciò è dovuto ad una caratteristica peculiare di noi umani: la capacità di rispecchiare le sensazioni provate da chi ci sta vicino. Pare dipenda dai neuroni specchio e dal fatto che questa empatia è funzionale alla conservazione della specie. Non sappiamo quanto credito possano avere queste teorie ma, per lo stesso motivo per il quale ci commuoviamo vedendo il dolore altrui, proveremo ansia nel percepire l’ansia del nostro interlocutore.
Un elemento della comunicazione verbale inerente il ritmo e meritevole di un'attenzione parti-colare l’utilizzo delle pause. Senza cadere negli eccessi della teatralità, la pausa ha una impor-tanza basilare poiché:
o fatta prima di esprimere un concetto ne rimarca l'importanza, in pratica con il silen-zio (che è comunque una forma di comunicazione) è come se dicessimo ai nostri a-scoltatori: attenzione! Sto per dire una cosa importante,
o fatta dopo un passaggio significativo, specie se espresso in forma di domanda, per-mette all'ascoltatore di riflettere su quanto detto; non trovate che questa domanda ri-volta alla nostra amministrazione comunale dovrebbe avere una sollecita risposta?
o lascia spazi di comprensione, o permette a chi comunica di respirare regolarmente per non finire senza fiato.
Insomma, usiamo le pause, con parsimonia ma usiamole; specie se dobbiamo raccogliere le idee su ciò che stiamo per dire. Meglio qualche secondo di pausa che far uscire parole confuse.
La melodia o enfasi è un aspetto del tono di voce che da molte informazioni a chi ci ascol-ta; potremmo paragonarlo all'utilizzo dell'evidenziatore giallo; ecco l'enfasi è nella comuni-cazione verbale ciò che l'evidenziatore colorato è nella comunicazione scritta. Pensiamo a questa frase: "Non ho detto io che la Daniela non sarebbe stata capace di fare questo lavoro." Ora proviamo a evidenziare con l'enfasi le prime quattro parole e diamo loro un tono inter-rogativo. "Non ho detto io ?? che la Daniela non sarebbe stata capace di fare questo lavoro." In questo modo stiamo sottolineando che siamo stati proprio noi a dire Daniela non sarebbe stata capace. E adesso evidenziamo le stesse parole, togliamo il tono interrogativo, rinforzando l'enfasi su "io" e otterremo l'esatto contrario, ovvero: non stato io a dirlo, è stato qualcun altro! "Non ho detto io che la Daniela non sarebbe stata capace di fare questo lavoro." Ma potremmo anche mettere l'enfasi sul nome proprio e la frase cambierebbe ancora signifi-cando che non l'ho detto di Daniela ma di qualcun altro. "Non ho detto io che la Daniela non sarebbe stata capace di fare questo lavoro." È chiara dunque l'importanza dell'enfasi per dare colore e significato alle nostre parole?

23
Alcuni nemici giurati di una buona comunicazione verbale:
la gergalitá ovvero l'utilizzo di un tipo di terminologia che potrebbe risultare sconosciuta al nostro interlocutore. Ricordate la sensazione che si prova a parlare con un informatico o con un medico che si esprimono in un linguaggio specialistico e astruso? Esclusione, senso di in-feriorità, timore che ci si stia nascondendo qualcosa? Insomma cerchiamo di parlare in modo coerente con il tipo di interlocutore che abbiamo di fronte e poiché nel Debate non sappiamo quale competenze abbiano i nostri ascoltatori, parliamo in modo semplice che non vuole dire elementare ma comprensibile. Einstein diceva che un vero esperto non ha bisogno di espri-mersi in modo incomprensibile e ammetterete che lui era un esperto nel suo campo!
l’astrattezza, quando noteremo la presenza di questo nemico della comunicazione? Quando
in ciò che diciamo non ci sono collegamenti concreti alla realtà di chi ci ascolta, poiché ci stiamo limitando a esprimere teorie che i nostri ascoltatori potrebbero non essere in grado di riferire alla propria realtà. Insomma, piuttosto che parlare delle minori tossine accumulate nell’organismo, a seguito di una dieta con prodotti biologici, dite alle signore presenti quan-to la loro pelle sembrerà più giovane.
la monotonia (delle argomentazioni), sarebbe sbagliato credere che si è monotoni solo u-
sando sempre lo stesso tono di voce; certo quella è la monotonia nel vero senso della parola ma non è la sola. Raccontare molti aneddoti anche divertenti può però risultare eccessivo, come citare in continuazione numeri e statistiche che gli ascoltatori finiranno per dimentica-re presto. Alternate dati oggettivi con esempi reali, citate delle statistiche ma create anche delle immagini mentali. Le persone ricordano davvero poco di quanto sentono e per lo più ricordano ciò che li ha suggestionati. Ricordiamo infine che la nostra memoria è prevalen-temente visiva anche se nel Debate questo non potrà esserci di molto aiuto infatti, salvo ec-cezioni, non è consentito usare ausili audio visivi. D’altro canto stiamo parlando di un match di comunicazione verbale, se iniziassimo a inserire immagini e poi video, si snaturerebbe l’essenza di questa disciplina.
la scarsità di informazioni e fonti potrebbe compromettere il vostro potere di persuasione
infatti gli esperti di comunicazione citano tra le prime componenti della persuasione: l’utilizzo di dati concreti e la credibilità della fonte. Quindi o voi stessi siete riconosciuti da-gli ascoltatori come fonte accreditata oppure dovrete prepararvi con una buona ricerca e con i riferimenti ad almeno una fonte attendibile. Un conto sarà dire che la spesa mondiale in ci-bo per animali è altissima e in continua crescita, un conto sarà proiettare il titolo del Sole 24 ore che stima tale spesa in 69 miliardi di euro.
le doppie negazioni, se non ricordo male in latino non si potevano usare poiché si diceva
che due negazioni affermano, in ogni caso risultano sgradevoli frasi come: non si può non dire….se non si può, diciamolo senza tanti giri di parole.
le parole o espressioni superflue sono a livello verbale qualcosa di simile a quelle interie-
zioni delle quali abbiamo parlato definendole espressioni sonore senza contenuto; anche in tal caso non ci rendiamo conto di farne un uso eccessivo ma pensate ai tanti cioè, diciamo, chiaramente, assolutamente, che sentiamo dire spesso a sproposito. In tal senso poiché si tratta di comportamenti ormai divenuti semi-automatici abbiamo pochi modi per agire su di loro: o ci registriamo mentre parliamo o chiediamo un feed-back ad una persona di cui ci fi-diamo. E se un amico dovesse dirci: “Ma sai che dici un sacco di diciamo….” Ebbene dia-mogli ascolto e proviamo a modificare questa cattiva abitudine.

24
le frasi fatte sono quelle che iniziano con: e come si dice comunemente……….. ed ecco una cascata di “buon sangue non mente”, “nella botte piccola c’è il vino buono” e via bana-lizzando. Intendiamoci, di tanto in tanto scappa a tutti una frase fatta o un luogo comune tipo “gli svizzeri sono pignoli” o “gli impiegati pubblici non hanno molta voglia di lavorare”. Nel complesso però evitateli poiché di regola li colleghiamo ad una certa superficialità intel-lettuale.
le espressioni burocratiche sono tipiche di quelle persone che per motivi di lavoro sono
spesso a contatto con la modulistica amministrativa, con regolamenti e leggi, insomma con la burocrazia. Avete mai sentito un carabiniere parlare? Sembra di sentire recitare una de-nuncia. Evitate questo gergo in modo assoluto; è noioso oltre che ridicolo.
l’uso di troppi incisi; si tratta di parentesi virtuali che apriamo parlando come ad esempio:
ieri ho rivisto Marisa, (a proposito ma come è ingrassata, (la Carla mi aveva detto che an-dava da un dietologo ma lei non è mai attendibile, (ricordi quella volta che ….. A tal punto abbiamo perso il filo e forse lo ha perso anche chi stava parlando. Vale sempre la vecchia regola: soggetto, verbo e complemento.
Il public speaking Filtrato dalla terminologia inglese non è altro che la comunicazione verbale…. in pubblico; detto così può sembrare facile ma vi garantisco che ho visto tante persone che, poste davanti ad un pub-blico specie se numeroso, si bloccavano prese dal panico e poco cambiava se in situazioni normali erano ottimi comunicatori. Il public speaking comporta tutto quanto detto nel capitolo precedente ma con qualche attenzione in più; attenzione dovuta al fatto che, nella comunicazione di coppia, in veste di interlocutori anche in modo inconsapevole, adattiamo il nostro stile e i contenuti all’altro soggetto del dialogo, prestiamo attenzione (alcuni di noi) alle espressioni del suo volto, capiamo quando l’altro non ha capito. Tutto questi sforzi di adattamento non possiamo attuarli quando parliamo davanti ad un pubblico, cosa che accade nei match di Debate. Inoltre quando parliamo ad un gruppo più o meno numeroso, dobbiamo ricordare che le dinamiche si moltiplicano e si acuiscono; un’espressione incredula sul volto del vicino indurrà una persona a esprimere sentimenti simili (omologazione al gruppo), una risatina potrebbe diventare contagiosa. Nessuna paura però perché questo fenomeno accade anche in positivo, bisognerà solo non dimenti-care mai i primi tre comandamenti di chi deve parlare in pubblico, ovvero:
1. preparatevi, 2. preparatevi, 3. preparatevi.
Non riuscire a prepararsi è prepararsi a non riuscire.7 Disegnate nella vostra testa e poi mettete su carta (o su tablet) la struttura del discorso che intendete fare usando lo strumento del quale parleremo tra poco nella “Organizzazione degli argomenti”, ripe-tete il vostro argomento mentalmente e perché no, anche ad alta voce davanti allo specchio. Fatelo più volte, all’inizio fatevi ascoltare da un amico o da un parente disponibile. Non andate “a braccio”
7 da “La presentazione perfetta” di John Collins

25
perché l’esito potrebbe essere a dir poco imbarazzante e non contate sul fatto di essere esperti dell’argomento. Voi dovrete farlo capire ad altri e quindi non va dimenticata una delle regole essen-ziali della comunicazione ovvero che non conta ciò che diciamo ma cosa arriva all’ascoltatore, cosa è compreso, cosa è accettato. Il problema dei discorsi improvvisati è che sono molto lunghi da preparare Lo so che sembra una frase ad effetto ma è totalmente veritiera. Probabilmente sarete rimasti colpiti da quegli oratori che parlano in pubblico in un modo molto naturale e fluido; non leggono e sembra che stiano improvvisando. A volte pare quasi che facciano un attimo di fatica a trovare la parola giusta che appare quasi per magia, ma in genere sono rilassati, sicuri. Bene, non pensiate neppure per un attimo che tutto ciò sia spontaneo. È il frutto di una lunga preparazione e, per tornare alla di-chiarazione iniziale, è molto più difficile e lungo preparare un discorso apparentemente improvvisa-to che uno strutturato. Se ci riuscirete però la vostra capacità persuasiva ne uscirà rafforzata.
Pensiamo al nostro speech come ad un regalo. Spesso noi comunichiamo in modo funzionale alle nostre idee, ai nostri gusti e per giunta con un tantino di innocente presun-zione: quella di pensare che ciò che piace a noi o ci interessa, debba fare lo stesso effetto su chi ci ascolta. Avete presente quelle mamme che parlano solo dei loro figli che se fossero unici al mondo? Questo è un errore grave, pari a quello commesso da coloro che dicono: quando faccio un regalo deve piacere per prima cosa a me. Spiacente ma un regalo deve piacere principalmente a chi lo riceve, altrimenti fallisce il suo obiettivo e la comunicazione
può essere intesa come un regalo che fate ai vostri ascoltatori. Ricordiamo quindi che l’obiettivo di una presentazione non è la trasmissione di idee bensì la rice-zione delle idee; pertanto preparazione, comunicazione e contenuto di uno speech (iniziamo ad usa-re la terminologia corretta) non devono essere adattati al debater ma al pubblico. L’assenza della componente emozionale, rende freddo e sterile lo speech, ma dove la prendiamo questa componente emozionale? Semplice, la troviamo in noi. È ciò che farà capire agli ascoltatori che siamo emotivamente coinvolti, che crediamo sinceramente in ciò che stiamo dicendo. La tra-smetteremo con il tono di voce, con l’enfasi che daremo a certi particolari passaggi del nostro inter-vento, con l’espressione del volto, con la postura del corpo. E se non crediamo in ciò che stiamo dicendo? Se il caso ci ha assegnato il compito di sostenere un’idea che non condividiamo? Se il BIRT (Be It Resolved That) fosse ad esempio “Il volontariato legittima l’inefficienza del Pubblico” e noi pensiamo esattamente l’opposto? Dovremo provarci lo stesso perché questa è l’essenza del Debate e che in parte prende spunto dal sistema giudiziario anglo-americano. Un imputato ha diritto alla miglior difesa possibile, e poco conta che l’avvocato lo ritenga o meno innocente. D’altro canto pensiamo che la speculazione filosofica per Hegel si basa su tesi, ovvero l’idea soste-nuta da chi parla o scrive e gli argomenti che la costituiscono, antitesi chiaramente il suo opposto e infine la sintesi che prova a considerare entrambe le prospettive. Nelle antiche scuole di retorica, agli studenti veniva richiesto di sostenere prima la tesi e quindi l’antitesi del medesimo argomento; l’insegnamento è evidente. In tale modo si è obbligati a vedere un problema da entrambe le prospettive, per considerare pro e contro di entrambe le argomentazio-

26
ni. In qualche modo questo allenamento ci aiuta a superare un limite del nostro modo di ragionare ovvero quello dell’esclusione, quel del se bianco è giusto nero deve essere sbagliato o viceversa. Prima di lavorare alla struttura del vostro discorso dovrete formulare un obiettivo preciso con una semplice, concisa asserzione di intenzione. Ad esempio potreste porvi come obiettivo: voglio far riflettere gli ascoltatori sui rischi che possono comportare i social network, oppure: voglio far comprendere gli aspetti positivi delle energie alternative. Ricordate che se il debater non focalizza il suo obiettivo, è improbabile che possano farlo gli ascoltatori. D’altro canto ricordate il consiglio dato ad Alice dal gatto del Cheshire (lo stregatto): se non sai dove andare qualunque strada andrà bene. Ovvero se non avete ben definito il vostro obiettivo percorrerete una strada confusa e vaga e tale apparirà anche a chi vi ascolta. Chiaramente non eccedete in senso opposto, ovvero non inserite troppi obiettivi nella vostra comunicazione; normalmente nel Debate ogni comunicazione può dura-re da un minimo di tre minuti ad un massimo di sette. Troppi obiettivi confonderebbero chi vi a-scolta, uno o al massimo due chiari e ben esposti saranno invece adeguati. Bene! Sperando di essere stato chiaro pur nei limiti della concisione passiamo ora alla parte opera-tiva poiché ci apprestiamo a programmare il nostro speech.
Le fasi dello speech Questo andrà suddiviso in tre fasi logiche.
L’introduzione Lo svolgimento La conclusione
I tempi da dedicare ad ogni fase sono: 20% - 60% - 20% Indipendentemente dal tempo che avrete a di-sposizione questa suddivisione, che va intesa come di massima e certamente non rigida, potrà essere applicata ad una comunicazione di due ora come ad una di cinque minuti. Vediamo ora quali attenzioni dedicare ad o-gnuna di queste tre fasi ma prima ricordiamo una cosa: non ne esiste una che sia più im-
portante delle altre; ognuna è essenziale alla capacità persuasiva della vostra comunicazione e come la prima ovvero l’introduzione è preparatoria alla seconda, così questa avrà lo stesso compito nei confronti della conclusione. Dunque attenzione a ciascuna di esse. L’introduzione è la fase nella quale vi giocate molto, se non tutto, poiché in pochi minuti dovrete:

27
ottenere l’attenzione dei presenti, infatti sarebbe inutile iniziare a parlare se parte dei pre-senti, e in particolare i giudici, sono distratti. Per ottenere la loro attenzione non usate meto-di scolastici quali battere la mano sul tavolo, ma state in silenzio per qualche secondo guar-dando gli ascoltatori, dovrebbe essere sufficiente.
accendere l’interesse in modo immediato; attenzione perché se non ci riusciste nei primi momenti potreste non riuscirci più. Questa fase corrisponde a quello che nei quotidiani è il sottotitolo, ovvero quella parte che fa decidere al lettore se proseguire nella lettura di tutto l’articolo o passare ad altro. Anche voi in questi primi momenti potrete indurre gli ascoltato-ri a seguire con attenzione la vostra presentazione o perdere completamente la loro attenzio-ne. Insomma dovrete rispondere immediatamente ad una domanda non dichiarata che aleg-gia nella testa dei vostri ascoltatori: perché mai dovrei stare ad ascoltarlo/a? Cosa accenderà il loro interesse?
o La prospettiva di ascoltare qualcosa di utile per loro; ciò che sto per dirvi vi aiuterà a presentare meglio la vostra immagine professionale nell’ambiente di lavoro.
o Una domanda che li faccia riflettere; come pensate di affrontare il problema della continua crescita dei costi del riscaldamento della vostra casa?
o Qualcosa che li scuota; nel breve tempo di questo nostro incontro X persone mori-ranno in incidenti stradali e Y resteranno gravemente menomate.
Attenzione però con questo ultimo metodo; è molto spettacolare ma potrebbe spaventare tanto i vostri ascoltatori da allontanarli psicologicamente dalla vostra logica. Nessuno ama pensare a cose spiacevoli e in certi casi si tende ad escludere chi invece vuole farci riflettere su tali cose. Insomma scartiamo in blocco non solo l’idea sgradevole ma anche chi ce la sta prospettando. È evidente che ciascuno di noi potrebbe venir meno in qualsiasi momento la-sciando in eventuali difficoltà la famiglia, ma se un assicuratore ce lo dice proponendoci una polizza, la maggior parte dirà che deve pensarci, da cui la risposta dell’assicuratore nella vecchissima storiella: “Va bene ci pensi,e se domani si sveglia mi richiami.”
definire il vostro ruolo ovvero chi siete voi per coloro che vi ascoltano? Siete l’esperto che parla sulla base di una radicata esperienza in un certo ambito, l’amico disinteressato che for-nisce consigli, colui che vuole indurre gli ascoltatori a riflettere? Quale sia il ruolo che sce-glierete, siate coerenti e non cambiatelo in corso d’opera e inoltre siate consequenziali nella scelta di tono e argomenti. Se siete l’esperto fate capire in che modo è nata la vostra esperienza e mostratela citando fonti, numeri e più che altro esempi: dichiararlo solo, non basterà. Un amico parlerà in tono cordiale e chiaramente informale, se volete indurre alle riflessioni fate molte domande senza eccedere in quelle retoriche.
Dire ciò che direte; anche questa sembra la solita frase di molto effetto e poca sostanza ma non è così. Un noto conferenziere americano sosteneva che nel parlare in pubblico ci fossero tre punti salienti: 1. ditegli ciò che gli direte 2. diteglielo 3. ditegli ciò che gli avete detto Nel presentare la struttura dello speech ai vostri ascoltatori voi fate ciò che un venditore di vini fa con il “ballon d’essai”: li preparate mentalmente a ciò che state per dire come il bic-chiere di assaggio prepara il palato al vino che verrà.
Lo svolgimento

28
Lo svolgimento è il corpo portante della vostra comunicazione; se avete svolto correttamente la fase precedente e rispettato gli accorgimenti consigliati, gli ascoltatori e in particolare si spera i giudici, saranno pronti per il piatto forte. Questo è lo spazio dei contenuti concreti, dei dati, delle fonti attendibili senza arrivare alla pedante-ria il vostro svolgimento dovrà essere invulnerabile alle critiche.
Come definiremo cosa dire e con quale priorità organizzare gli argomenti? Abbiamo uno strumento ottimo per questo scopo ed è la mappa mentale o se preferite il nome origi-nale “mind map”; questa potrà essere sviluppata con strumenti banali quali carta, matita e gomma per cancellare oppure usando un pratico software. Ricordate che in rete se ne trovano tanti e gratuiti sia per pc che per tablet. Non dovrete fare altro che digitare in Google le parole mindmapping e sof-tware ed ecco comparirvi oltre sei milioni e mezzo di risultati. Edraw è il mio preferito ma come in tutte le cose che si tratti di un’automobile piuttosto che di un elettrodomestico, le preferenze sono soggettive. Scaricatene qualcuno e fate delle prove, troverete sicuramente quello che fa al caso vostro. Proviamo ora ad usare una mappa mentale in modo concreto. Immaginiamo dunque che l’assunto del match di Debate sia: “Bisogna sempre più privilegiare un’alimentazione bio” e che il vostro obiettivo sia quello di dimostrare che il nostro modo di man-giare è mediamente dannoso e pericoloso per la nostra salute. Se l’idea che la nostra alimentazione sia inadeguata se non dannosa è il fulcro della nostra mappa, in Edraw la situeremo al centro come “Main idea” o idea centrale. Collegati a questo assunto di par-tenza o main idea, potrebbero esserci altri contenuti, ad esempio:
la pubblicità sugli alimenti è ingannevole le informazioni in nostro possesso sono parziali alcune malattie sono strettamente collegate alla nostra alimentazione esiste un collegamento diretto tra alimentazione e longevità
ecco dunque che la prima stesura della nostra mappa mentale apparirà così:

29
Evidentemente noi vorremo arricchire questi punti con uno o più argomentazioni che in pratica ri-spondono alla domanda: perché? riferita ad ogni argomento (Topic). Ad esempio dovremo docu-mentare che la pubblicità spesso è ingannevole citando rapidamente la legge nazionale sulla pubbli-cità e, meglio ancora, mostrando una pubblicità che nasconde qualcosa. Insomma ogni topic si potrà arricchire di sub-topic ma senza esagerare, pena il rischio che gli ascol-tatori si perdano. A tal punto la nostra mappa potrebbe presentarsi così8:
Ora il nostra schema è pronto e noi non dovremo fare altro che riempire di contenuti i vari topic. Facile no? In conclusione avremo costruito uno schema lineare e semplice da seguire dove esiste un’idea prin-cipale che è quella che dovremo far passare ad ogni costo, pena il fallimento della nostra comunica-zione; da essa si dipartono vari punti a sostegno della stessa. In pratica avrete fornito a voi stessi e ai vostri ascoltatori una sorta di mappa, tramite la quale po-tranno non solo seguirvi ma anche capire in ogni momento dove siete. Credetemi però quando vi dico che quella mappa servirà anche a voi stessi, sarà il vostro filo di Arianna, vi permetterà di fare una deviazione per poi tornare sicuri sul cammino principale. Senza di essa il rischio di perdersi è dietro l’angolo e a nulla servirà l’essere esperti della materia che state trattando; ricordate? Non è importante cosa sapete ma quanto gli ascoltatori capiscono.
Stile deduttivo o induttivo? A al punto dovremo solo scegliere lo stile da adottare e le differenze non sono solo…..di stile ovve-ro estetiche, ma hanno notevoli conseguenze su gradevolezza e comprensione. Lo stile deduttivo come dice il suo nome, parte dal generale per arrivare ad una conclusione; si struttura dunque su:
Premessa, ovvero una concettualizzazione generale che fa da introduzione al nostro speech
8 Questa mappa è stata preparata con il sw scaricabile all’indirizzo https://www.edrawsoft.com/freemind.php

30
Principi, sono i presupposti teorici su cui si basa la nostra comunicazione Sviluppo, ovvero la sua presentazione Conclusione, cosa fare
Se restiamo nel tema proposto nel precedente paragrafo ovvero quello sull’alimentazione:
in premessa dovremmo dire qualcosa circa il funzionamento del nostro metabolismo e come il cibo lo influenza,
nei principi potremmo spiegare le differenze sull’organismo di cibi bio e cibi non sani nello sviluppo presentare le conseguenze che hanno le nostre scelte alimentari e infine in conclusione invitare gli ascoltatori a una maggiore attenzione al cibo.
Lo stile deduttivo è quello che più comunemente viene adoperato e ciò dipende da un fatto: è quello che abbiamo appreso a scuola, non a caso si definisce stile deduttivo – scolastico. È semplice da progettare ma attenzione: è noioso. Lo stile induttivo naturalmente segue un percorso opposto a quello precedente: si prende spunto da un fatto particolare e da quello si arriva poi ai concetti generali secondo uno schema che prevede:
Un caso reale Delle riflessioni che nascono dal caso stesso I concetti teorici La conclusione ovvero il cosa fare.
Sempre fedeli al tema dell’alimentazione potremmo:
raccontare che oggi nelle scuole dell’infanzia non è consentito portare pietanze cucinate in casa, per cui ad una festicciola di compleanno sarà considerata accettabile una torta preconfezionata e sarà rifiutata quella fatta da una mamma o di un papà! 9
potremo quindi riflettere e far riflettere su come anche a livello educativo si mina la cultura ali-mentare dei bambini
citare dei dati sugli ingredienti dei due tipi di alimento e infine invitare gli ascoltatori ad agire in senso positivo facendo leva sull’affetto per i propri fi-
gli Questo stile è adatto se gli ascoltatori sono portati al “concreto”, inoltre riesce a facilitare la com-prensione di concetti complessi. Attenzione perché può esservi difficoltà nel passaggio da particolare a generale e se le persone non trovano il caso attinente alla propria realtà (nell’esempio citato, non hanno figli nelle scuole dell’infanzia o non sanno cucinare), potrebbero svalutare tutti i passaggi successivi. Quando lo stile induttivo parte da un caso reale critico allora lo si definisce “stile per problemi”; Oggi il 26,9% dei ragazzi italiani dai 6 ai 17 anni è in sovrappeso e nella fascia dei bambini fra i 6 e 10 anni, si arriva fino al 35,7%!
9 Alcune trovate possono essere ad effetto e se non rifuggite da un po’ di teatralità……
Si racconta che un giorno Catone il Censore si presentò nel Senato di Roma con dei fichi che offrì ai colleghi senatori. Chiese dunque se li trovassero buoni e freschi e alla risposta positiva, dichiarò che quei fichi erano stati raccolti a Car-tagine per poi concludere con la sua famosa esortazione: “Carthago delenda est” Cartagine deve essere distrutta (in quanto tanto vicina che la frutta arrivava fresca). Imitando Catone nell’esempio citato potreste portare una torta di pa-sticceria industriale e quindi leggere gli ingredienti. Il risultato sarà garantito quando inizierete a leggere con scrupolo: burro di cacao, lecitina di soia, mono- e digliceridi degli acidi grassi, addensante: fibra di guar, agenti lievitanti.

31
Dopo la premessa critica si proseguirà con le stesse fasi appena citate.
La comunicazione persuasiva Noi tutti viviamo così immersi quotidianamente nella comunicazione che, come i pesci non sono consapevoli di essere nell'acqua (attenzione si dice così, ma nessuno ha mai parlato con un pesce notoriamente muto), così noi siamo portati a non riflettere troppo su quella che invece è forse la più importante delle caratteristiche umane. Per esempio non ci chiediamo perché comunichiamo considerandolo un fatto naturale; in realtà noi comunichiamo per influenzare gli altri. Si tratta di una necessità essenziale poiché in sua assenza finiremmo per confliggere in continuità. Noi esseri umani siamo dotati di quella che Skinner definiva visione a tunnel, ovvero tendiamo a guardare la vita e gli eventi da una prospettiva molto soggettiva, come se appunto guardassimo in un tunnel che ci permette di vedere solo una parte della realtà e non tutto quello che c'è intorno. Questa visione raramente coinciderebbe con quella dei nostri simili e ciò ci porterebbe a continui conflitti, ma poiché il conflitto è costoso in termini di investimento emotivo, l'umanità nei millenni della sua evoluzione, ha elaborato questo metodo molto peculiare: la comunicazione interpersona-le. Si pensi che alcuni studiosi ritengono che il nostro notevole sviluppo cerebrale, rispetto ad altre specie animali, sia proprio una conseguenza della necessità di comunicare in modo sempre più complesso. Attraverso la comunicazione noi cerchiamo di influenzare i nostri simili invitandoli a guardare nel nostro tunnel, ma affinché questo influenzamento non si trasformi in manipolazione o addirittura in subornazione, occorrerà che sia reciproco, ovvero anche noi dovremo impegnarci a guardare nel tunnel dell'altro. Da questi reciproci sforzi di adattamento potrà nascere una comunicazione equilibrata ovvero sim-metrica che sarà la base indispensabile per futuri scambi comunicativi proficui e pacifici. Se dunque la comunicazione tende all'influenzamento, cosa cambia perché la si definisca persuasi-va? Proviamo con un esempio: immaginate di essere una sera al ristorante in compagnia di amici, dopo le ordinazioni qualcuno si accorge che non avete chiesto nulla che fosse a base di carne e vi chiede la ragione di questa scelta. A tale domanda rispondete che da qualche settimana avete abbracciato una scelta vegetariana; si tratta di una prova, una sorta di esperimento, aggiungete, ma siete proprio curiosi di verificarne gli esiti. Qualcuno vi prenderà in giro, altri vorranno sapere, ed ecco che vi sentirete quasi obbligati a spie-gare i motivi della vostra decisione, i benefici che contate di riceverne fino a tentare di indurre alcu-ni di loro a provare anche essi questa scelta. Certamente li avrete influenzati ovvero li avrete indotti a riflettere sui perché e sulle conseguenze di una scelta vegetariana. Ma sarete stati persuasivi? Certamente si, se uno o più dei vostri amici dirà: da domani provo a mangiare vegetariano anche io per una quindicina di giorni e poi si vedrà. La comunicazione dunque si definisce persuasiva quando mira ad un cambiamento dei comporta-menti oggettivamente constatabile e relativamente permanente.

32
Dunque l’essenza della persuasione sta nei comportamenti oggettivi ovvero concreti: non basta che abbiamo sensibilizzato una o più persone sul problema dell’esaurimento inevitabile dei carburanti fossili. Occorrerà che queste persone acquistino un’auto ibrida o montino i pannelli solari sul tetto o casomai inizino ad andare in ufficio in bici. Conviene riflettere su tale aspetto per comprendere quanto la persuasione interessi ambiti come la politica, il marketing, il management delle aziende; coloro che si muovono in tali ambienti non si accontentano della nostra sensibilizzazione. Loro vogliono che noi votiamo, acquistiamo, agiamo secondo le direttive che ci daranno. Per tali motivi la comunicazione persuasiva è da sempre oggetto di studio e, pur con le riserve che accompagnano ogni formuletta magica, in un ambito quale quello umano che formule non ne ha, possiamo estrapolare alcune caratteristiche della comunicazione persuasiva.
Determinanti della comunicazione persuasiva Delle sette determinanti che seguono,
1. Basarsi su fatti razionali e concreti 2. Credibilità della fonte 3. Motivazione del ricevente 4. Capacità del ricevente di elaborare il messaggio 5. Novità 6. Forza 7. Pertinenza
le prime due sono alternativamente essenziali, nel senso che se non vi è la prima deve esserci la se-conda o viceversa. In presenza di entrambe le nostre possibilità di persuasione saranno molto alte come di contro, in loro assenza, le nostre possibilità persuasive saranno ridotte al lumicino. La terza e la quarta costituiscono una sorta di condizione soggettiva senza le quali, anche qualora si sia stati convincenti, dovremo immaginare che le nostre parole vengano bloccate e/o respinte dai fil-tri psicologici del nostro ascoltatore. Le ultime tre poi consideriamole una specie di optionals; la loro azione sarà integrativa alle altre, ma non determinante.
Basarsi su fatti razionali e concreti È fuor di dubbio che un conto sia dichiarare che l’eccesso di velocità in macchina è rischioso, altro sia dire che con l’avvento del sistema Tutor c’è stata una riduzione del 50% del tasso di mortalità, del 22% del tasso d'incidenti e del 25% del tasso di incidenti con feriti. Ciò secondo la Polizia Stra-dale! Persuasivo eh!!!??? Citare dati, fatti, prove è chiaramente un elemento importante nella persuasione, ne volete una pro-va? La pubblicità tenta spesso di spacciare per fatti razionali e concreti degli elementi a dir poco vaghi. L’86% dei dentisti ha dichiarato il dentifricio Pinco……… insostituibile nell’igiene orale. Tre mamme su quattro hanno giudicato il pannolino Pallino perfetto per il culetto dei loro figli E così via vantando!

33
Non sappiamo quali siano le fonti di questi dati né se si parli dei dentisti mondiali, italiani o di Roc-ca Cannuccia, e le tre mamme su quattro le hanno intervistate un giorno all’uscita del supermerca-to? È evidente il tentativo di convincere i potenziali clienti che vi sono fonti attendibili che ci possono indurre a scegliere quel prodotto; forse pochi ci cascheranno ma su centinaia di migliaia che ascol-tano, anche un 5% è un bel risultato. Nel Debate la faccenda è più complessa poiché ci si augura che i giudici siano ben preparati, e cita-re dati fasulli è eticamente disdicevole oltreché causa di squalifica se scoperto; la soluzione dunque? Studiare, prepararsi, fare ricerche approfondite. Una squadra dovrebbe avere al suo interno uno o più addetti a fare analisi e ricerca di fonti da forni-re poi ai giocatori. Torneremo sull’argomento delle ricerche, ma a chi si avvicina al Debate deve es-sere chiaro che senza voglia di studiare e fare ricerche, non si farà molta strada in questa disciplina. Insomma il Debate non si addice ai superficiali!
Credibilità della fonte La credibilità di una persona è strettamente collegata alla fiducia che si ha in essa, ma tutto ciò non basta; potrei fidarmi del mio commercialista, ma se mi da consigli sentimentali potrei non ritenerlo credibile. Quindi alla fiducia deve unirsi la conoscenza di fatti e avvenimenti che mi convincano della compe-tenza specifica in un certo settore della persona in questione; tutto ciò sommato ad un certo orizzon-te temporale, insomma devono esserci state una serie di esperienze positive, diluite in un tempo per me significativo, che mi faranno ritenere credibile la sua opinione. Immaginiamo ad esempio di aver avuto negli anni un certo numero di relazioni con un meccanico; le singole esperienze vi dicono che quando questo tecnico ha espresso un’opinione questa di è di-mostrata sempre corretta. Lo stratificarsi di tali esperienze positive darà vita alla credibilità. Se dun-que un giorno costui vi dicesse: la sua macchina ha bisogno di……. e citasse una spesa corposa voi vi fidereste e spendereste quei soldi, cosa che non fareste a cuor leggero se le stesse parole le dices-se un meccanico mai visto prima cui avete portato l’auto mentre eravate in vacanza. Insomma quando la fiducia, radicata nel tempo, rende credibile una persona ai nostri occhi, noi fac-ciamo una cosa molto peculiare: deleghiamo a lei il processo decisionale. Avviene quindi un pro-cesso che possiamo definire cessione dell’ansia a fronte di una concessione di potere. È come se dicessimo: “Poiché io non ho elementi e competenze tali da scegliere o decidere, lo la-scio fare a te. Tu prendi la mia ansia e in cambio ti concedo il potere di decidere al mio posto…” Lo facciamo con il medico quando ci mette a dieta oppure con l’idraulico se dice di cambiare la caldaia. Quanti elementi abbiamo per valutare le loro opinioni? Nessuno di regola; ecco che in real-tà essi decidono al posto nostro. Nel Debate quando si verificherà una situazione del genere? Probabilmente mai poiché non cono-scerete giudici e pubblico; ciò vuole dire che la vostra credibilità dovrete costruirla voi nella mente di chi vi ascolta. Esperienze professionali, ruoli e mansioni svolte nel tempo, se debitamente portate a conoscenza degli ascoltatori e dei giudici, potranno rendervi più credibile; ma non esagerate. Questa competenza va veicolata non sbandierata, giacché questo comportamento potrebbe apparire presuntuoso e quindi eccessivo; piuttosto quindi che elencare i proprio titoli accademici e profes-sionali, potrà bastare una frase del tipo: nella mia lunga esperienza di avvocato mi è capitato di ve-dere tante situazioni di disagio familiare e quindi…….. , oppure: “Quando clienti o colleghi mi chiedono un consiglio in questo campo, normalmente dico che …..” sarà come dire che non parlate per sentito dire ma per una lunga esperienza diretta.

34
La motivazione del ricevente E veniamo al primo cancello che può sbarrarvi la strada della persuasione; con la definizione moti-vazione del ricevente si intende qualcosa di semplice ma netto e deciso:
quanto chi vi sta ascoltando vuole davvero farsi coinvolgere da ciò che dite? e quindi quanto è motivato a considerare davvero le vostre parole? Immaginate che all’interno di un match di Debate che abbia come BIRT i comportamenti ecologi-camente responsabili, voi vogliate sostenere l’importanza del car sharing. Tra i vostri giudici c’è un individuo alquanto asociale che di tanto in tanto, mentre guida, ama fu-marsi un toscano cosa che mai potrebbe fare a casa o in ufficio. Questo signore nel tempo, ha finito per considerare gli spostamenti in macchina casa-ufficio, come gli unici momenti di privacy e rilassatezza. Come lo convincerete della validità di portarsi in auto due o tre persone, ogni mattina che si reca al lavoro? Pur dando per accettata la sua onestà, non pensate anche voi che probabilmente la sua mo-tivazione sia quanto meno frenata? Se sostenete l’importanza della partecipazione sociale ad un incallito evasore fiscale, pensate che il giorno dopo il vostro intervento questi si rechi contrito negli uffici di Equitalia e chieda di pagare tutti i suoi arretrati? C’è qualcosa da fare per risolvere questo problema? Assolutamente no! Mi piacerebbe tirar fuori un coniglio dal cappello ma sinceramente nei 3, 4 minuti di uno speech nessuno può modificare un atteggiamento mentale radicato, inoltre i filtri percettivi, specie quelli più radicati poiché nati e sviluppatisi negli anni, spesso sono inconsapevoli e chi li ha neppure si rende conto di averli, quindi l’unica cosa da fare è sperare che non vi capitino giudici particolar-mente prevenuti.
Capacità del ricevente di elaborare il messaggio Anche questo è un cancello che può sbarrarvi la strada ma non risiede nei filtri soggettivi dei vostri ascoltatori, piuttosto nelle loro conoscenze e competenze; se esprimete concetti ostici da capire in quanto al di fuori della loro conoscenza, scolarità o cultura, come potrebbero essere persuasi da qualcosa che non hanno capito? Siete un appassionato di tecnologia e state sostenendo con vigore l’importanza della banda larga, ma se iniziate a dire che sarebbe preferibile la soluzione Fiber To The Cabinet e poi VSDL2 poiché così entro i 300m si raggiungono i 100Mb/s simmetrici, è molto probabile che la maggioranza di chi vi ascolta non abbia capito nulla (anche io, ho solo copiato questa frase da un articolo di giornale). A tal punto molto probabilmente li avrete persi e ciò per vari motivi: comunicare significa mettere in comune e se adoperiamo un linguaggio troppo specifico, noi
stiamo in pratica dicendo che vogliamo mettere in comune il nostro messaggio, solo con coloro che posseggono quel linguaggio, quelle conoscenze, in pratica con quelli che fanno parte del gruppo, gli altri sono esclusi. Il linguaggio da esperti, quello tecnico con tanti termini misteriosi non va demonizzato, in quanto tale modo di parlare ha un beneficio indiscutibile: è conciso e

35
non lascia spazio a interpretazioni. Se in barca a vela qualcuno vi dice di “cazzare la randa” e voi possedete quel linguaggio, non avrete dubbi su cosa fare. Se così non fosse, dovreste sentirvi dire che la vela triangolare che sta a prua della barca deve essere ridotta di tela esposta al vento. Forse a questo punto avreste già scuffiato, ovvero la barca si sarebbe rovesciata in acqua perdendo l’assetto e la testa dell’albero sarebbe immersa.
C’è un altro motivo che deve farci evitare laddove possibile un linguaggio da iniziati: chi ascolta parole incomprensibili non sempre riesce o può dire che non ha capito (e certo non può farlo durante un match di Debate) quindi se nella sua mente rimane un interrogativo è probabile che egli continui a pensarci senza dare ascolto a ciò che avrete detto dopo.
Ad alcuni addirittura i discorsi incomprensibili appaiono fatti ad arte per nascondere la verità; ricor-date Renzo de “I promessi sposi” con l’avvocato Azzeccacarbugli10? Tutto ciò ci insegna una verità importante: bisogna parlare sempre con un linguaggio semplice e comprensibile, se “ci scappa”qualche parola tecnica niente di male, purché subito dopo ci si spieghi ad esempio: ritengo preferibile la soluzione Fiber To The Cabinet ovvero quella che porta i cavi in fibra ottica fino ad un armadietto, che a sua volta è collegato alla centrale; a quell’armadietto potrete collega-re tutti i telefoni, computer e smartphone di casa.
Novità, forza e pertinenza Queste tre determinanti, come si diceva inizialmente, sono una sorta di optional della persuasione; se ci sono aiutano ma da sole non sortiranno grandi risultati. Far scoprire all’ascoltatore una novità, un concetto che non conosceva, un metodo innovativo gene-ra in lui una specie di gratitudine poiché conosciamo istintivamente il potere dell’informazione. La forza trasparirà dalla vostra comunicazione se farete vedere quanto credete in ciò che dite ovvero quanto siete coinvolto emotivamente. Tale forza la trasmetterete con una caratteristica della comu-nicazione della quale parleremo tra breve, l’enfasi, oppure facendo capire agli ascoltatori che avete vissuto situazioni simili a quelle trattate e quindi siete particolarmente immedesimato. Quanto alla pertinenza, la vostra comunicazione sarà tanto più persuasiva quanto più sarete rimasti “sul pezzo” ovvero avrete usato argomentazioni pertinenti all’argomento e più che altro vicine alle esperienze delle persone.
Metacomunicazione e linguaggio del corpo Con termini quali metacomunicazione o linguaggio del corpo, intendiamo tutto ciò che riusciamo a dire oltre le parole e se credete che con le parole si esaurisca la maggior parte del compito della co-municazione ahimè state trascurando una parte importante , poiché le percezioni che trasmettiamo con il tono di voce e con il corpo, costituiscono certamente le componenti che destano maggiore attenzione in chi ci ascolta. Anche se non siamo bravissimi in inglese credo che questo diagramma a torta dovrebbe darci un’idea chiara di cosa le persone notano e quindi ricordano della nostra comunicazione.
10
Nel terzo capitolo del romanzo di Alessandro Manzoni, Renzo si reca dall’avvocato sperando che questi possa aiutar-lo a sanare un torto subito dal potente don Rodrigo. Inizialmente avviene un equivoco tra i due personaggi, e l’Azzeccagarbugli pensa che Renzo sia un “bravo”. Quando il giovane riesce a spiegare la situazione, l’avvocato vile, per non mettersi contro un potente si rifiuta di aiutarlo. Nel farlo, inizia a parlare in latino al povero Renzo che si sente raggirato poiché chiaramente non capisce una parola.

Come si vede la parte del leone bale” ovvero la postura del corpo,vero le espressioni del volto, l’importantissimagesticolazione. Fatta 100 una comunicazionetendiamo a soffermare la nostra 55% su tali componenti. Una partete dell’interesse di chi ascolta, il tono di voce. Soltanto un misero to alle parole dette. Ecco perchéfermarci su questo aspetto che inbate, come nella comunicazioneha un grande peso. 11
Le aree di osservazione
Vediamo di fare chiarezza su ciòguaggio del corpo di chi parla.
Le aree di osservazione, definite
1. l'atteggiamento posturaleticolare attenzione ai movimentiesempio lo spostare il pesopiedi, accavallare le gambe,
2. la mimica ovvero tutti queiclusi i processi psicosomaticiarea è la più ricca ed espressiva
3. la gestualità ovvero i movimentiremo, è non solo molto indicativo
4. la gestione della distanzavalore possono avere i movimentistanza avvicinandoci all'altro
5. il tono ovvero tutto quelloprendiamo:
a. l'intonazione,
b. la melodia del discorso,
c. le pause,
d. il volume della voce,
e. il ritmo dell'eloquio.
Di questi ultimi aspetti non parleremo
11
Se ti interessa approfondire questo argomento
36
la fa il “non ver-corpo, la mimica ov-
l’importantissima comunicazione noi
attenzione per il parte non indifferen-
38%, la ottiene il 7% viene dedica-
perché dobbiamo sof-in una gara di De-
comunicazione di tutti i giorni,
ciò che le persone osservano (a volte in modo inconsapevole)
anche "Criteri di percezione focalizzata" sono
posturale ovvero la postura che assumiamo in un datomovimenti che cambiano o modificano la posizione
peso sporgendosi in avanti o indietro, il dondolarsigambe, ecc.
quei fenomeni che si possono osservare sul voltopsicosomatici come, ad esempio, l'arrossire o impallidire.
espressiva e quindi fonte di tante importanti informazioni,
movimenti delle braccia e il linguaggio delle maniindicativo ma difficile da nascondere.
distanza ovvero, come gestiamo lo spazio che ci separamovimenti più o meno improvvisi che agiamo
all'altro o allontanandocene.
quello che diciamo oltre alle parole e non è poco
discorso,
voce,
dell'eloquio.
parleremo avendoli già trattati precedentemente.
argomento puoi anche leggere ” Il corpo rivelatore”
inconsapevole) nel lin-
sono cinque:
dato momento con par-posizione del corpo, quali ad
dondolarsi sulle piante dei
volto di una persona, in-impallidire. Vedremo che tale
informazioni,
mani che, come scopri-
separa dagli altri e che per modificare tale di-
poco poiché nel tono com-
precedentemente.

37
L'atteggiamento posturale
Con una enunciazione forse troppo generica possiamo definire l’atteggiamento posturale come: il modo nel quale il corpo sta nello spazio.
Sostiene Alexander Lowen padre dell'Analisi Bionergetica che " Il problema della sicurezza emotiva di un individuo non può essere separato dal problema della sua sicurezza fisica, del suo aderire con i piedi al suolo". In parole povere chi vi osserva noterà la vostra postura e la collegherà alla sicurezza che state provando in quel momento. Mi rendo conto di quanto sia dif-ficile dimostrare questi assunti, ma provate a pensare a quelle sensazioni che abbiamo provato tutti osservando una persona; spesso avremo usato espressioni come: “sembra molto disinvol-to” oppure “appare a suo agio come fosse a casa sua” o di contro “mi sembrava a disagio, in-sicuro” senza dimenticare la classica: “sembrava un gatto sui carboni”.
Tutte queste percezioni nascono in noi dall’osservazione di come il corpo occupa lo spazio, di come si muove.
Quali sono dunque gli errori da evitare quando si parla davanti ad un pubblico:
non dondolatevi né oscillate, questo tipo di movimento è tipico di chi non vorrebbe essere dove si trova in quel momento. Avete presente quando fate la fila in un ufficio pubblico?
non aggrappatevi all’eventuale leggio come se fosse uno scoglio durante una tempesta. Allo stesso modo non appoggiatevi al muro o a mobili; la ricerca di appoggi trasmette insicurez-za;
evitate il movimento da leone in gabbia muovendovi da una parte all’altra, normalmente nel Debate i debater stanno dietro ad un leggio o comunque ad una postazione fissa,
le persone tenderanno a notare quanto il movimento delle spalle tenda a proteggere il collo; qualche migliaio di anni fa, i nostri antenati per difendersi dalle continue minacce prove-nienti dagli animali o da altri uomini proteggevano la parte del corpo più delicata e vitale: la gola. Ecco allora che il ritrovarsi in una situazione o in un ambiente che riteniamo ostile o minaccioso ci induce a infossare la testa nelle spalle (per proteggere la gola) tradendo così la nostra chiusura verso quell'ambiente e in genere il nostro disagio.
La mimica
Il volto umano è letteralmente unico tra i mammiferi, è infatti dotato di quarantanove muscoli i quali, in varie combinazioni possono dar vita a circa diecimila espressioni, in tal senso la frase "il tuo viso è un libro aperto" non esagera; il volto umano è un libro molto ricco di spunti e pos-sibili interpretazioni. Come e perché il volto umano abbia raggiunto tali vette di complessità è ben difficile da comprendere, probabilmente ci siamo arrivati in centinaia di migliaia di anni di evoluzione, spinti dalla necessità di comunicare in modo più complesso di altri animali.
Questa spiegazione è accettata anche da molti studiosi che attribuiscono alla complessità della nostra comunicazione, anche la derivante complessità del nostro cervello. In pratica si sarebbe innescato un circolo virtuoso: più la nostra comunicazione diveniva complessa più il nostro cer-vello si sviluppava, il che a sua volta consentiva ulteriore complessità della comunicazione e co-sì via.
I segnali che la mimica può esporre possono essere migliaia; proviamo a soffermarci su quelli più evidenti:

lo sguardo; come detto,persone che ci appaionose guardate solo in unasguardo quindi deve vagare
osserviamo come teniamoinsicurezza, mentre alse tale postura perdura
sorridete poiché il sorrisocontagioso, infatti quandoportati a sorridere ancheche state dicendo, quindipoiché simulare il sorrisoghigno. Qualcuno staràrantisco che non è così.ridere ed è il muscolo
o Solleva gli angoli o Stira le labbra o Solleva le gote o Genera le “zampe
sorriso
Sorriso falso
Se osservate le quattro foto, esigenze professionali spesso,ro di quelle piccole rughe cheniamo con una espressione comune:
La gestualità
Proviamo a fare un gioco.
In compagnia di uno o più amicitremmo ad esempio raccontareconosciuta di recente o anche
NO
38
detto, potrebbe accadere che istintivamente ci siappaiono interessate. Nulla di male se questa scelta
una direzione, gli altri ascoltatori potrebberovagare sulla sala senza naturalmente dimenticare
teniamo il mento; qualora sia infossato verso il al contrario se proteso in avanti indicherà la volontà
perdura può addirittura essere percepita come arroganza,sorriso è il segnale empatico per eccellenza, loquando vediamo qualcuno vicino a noi sorridere,anche noi. Chiaramente il vostro sorriso deve esserequindi non deve comparire a sproposito. Devesorriso è difficilissimo e rischiamo quindi di produrstarà pensando che simulare un sorriso sia moltocosì. Nel nostro viso c’è un muscolo preposto al
muscolo zigomatico maggiore; questo contraendosi:
della bocca,
“zampe di gallina” che sono il marchio insostituibile
falso Sorriso sincero
scoprirete che le due nelle quali il soggetto spesso, si distinguono appunto per l’assenza delle zampe
che nascono intorno agli occhi. Accade per i falsicomune: “stava sorridendo ma solo con il viso,
amici proviamo a descrivere una breve e recentetare la trama di un film, oppure descrivere una
anche raccontare di una esperienza vissuta sul lavoro.
SI
si soffermi su una o più scelta non diventa costante;
potrebbero sentirsi esclusi. Lo dimenticare i giudici;
collo mostrerà timore, volontà di farsi valere e
arroganza, lo è tanto da sembrare
sorridere, siamo naturalmente essere coerente con ciò
Deve inoltre essere sentito, produrre uno spiacevole
molto semplice, ma vi ga-al compito di farci sor-
insostituibile di un vero e naturale
sincero
simula un sorriso, per zampe di gallina, ovve-
falsi sorrisi ciò che defi-viso, non con gli occhi…”
recente esperienza; po-una persona interessante
lavoro.

39
La regola di questo gioco è che dovremo parlare tenendo bloccate completamente mani e brac-cia; per farlo ci basterà giungere le mani e tenerle chiuse tra le ginocchia.
Cosa accadrà?
Accadrà che nonostante apparentemente noi si debba parlare con la bocca e non con le mani e le braccia, ci sentiremo bloccati non solo fisicamente ma anche dialetticamente, come se le parole facessero più fatica ad uscire.
Con questo semplice esercizio ci convinceremo che i gesti non sono semplicemente ausiliari alla comunicazione verbale, quale una sorta di rinforzo o maggior chiarimento, o meglio non sono solo quello, bensì sono parte integrante della facoltà di parlare con proprietà e scorrevolezza.
Da ciò consegue una importante verità: chi ci osserva, anche se in modo inconsapevole, terrà conto della nostra gesticolazione e dalla portata di questa trarrà delle valutazioni. Ecco dunque a cosa badare, specie quando comunichiamo in pubblico.
gesti ed emozioni: la gesticolazione dice molto del nostro coinvolgimento emotivo poiché possiamo sostenere che, almeno nella nostra cultura latina, gesticolazione ed emozioni van-no in parallelo sicché una persona che non gesticola è percepita come in imbarazzo o non sincera o forse come poco coinvolta in ciò che sta dicendo, mentre maggiore sarà l'intensità delle emozioni provate, maggiore sarà la gesticolazione.
l'ampiezza dei gesti darà informazioni su quanto siamo a nostro agio o meno, ma cosa inten-diamo per ampiezza? I gesti saranno tanto più ampi quanto più si allontanano da una sfera virtuale della quale siamo al centro e che ha come raggio un nostro braccio leggermente flesso; una gesticolazione che rimanga molto vicina al corpo potrebbe comunicare insicu-rezza. Man mano che i gesti si allontaneranno ci daranno una sensazione di maggiore sicu-rezza fino a sembrarci aggressivi qualora escano dalla predetta sfera o bolla.
la direzione dei gesti darà, a chi ci osserva informazioni su quanto accettiamo, accogliamo o di contro rifiutiamo e respingiamo l’ambiente che ci circonda. I gesti che vanno dall’esterno all’interno specie se con i palmi aperti sono gesti di accettazione. Quelli che vanno invece in direzione opposta sono di rifiuto. Attenzione a puntare il dito, una penna o peggio una bac-chetta; sono considerati gesti di dominanza e quindi aggressivi.
il ritmo del nostro gesticolare potrà essere lento e armonico oppure sincopato e frenetico; nel primo caso daremo una sensazione di tranquillità e sicurezza mentre nel secondo trasmette-remo emotività e coinvolgimento fino ad arrivare ad ansia o rabbia
chiusura o apertura? Faremo un classico gesto di chiusura / rifiuto, quando sembrerà che con le mani vogliamo bloccare la strada a qualcosa o qualcuno, ma un altro gesto di chiusura ti-pico è quello della braccia conserte. Di contro pensate al Papa che con le palme in su e le braccia aperte sembra voglia accogliere tutti. Attenzione dunque ai gesti di chiusura che ver-ranno percepiti come sintomatici di ostilità al contesto,
i gesti manipolatori meritano una certa attenzione; si tratta di tutti quei movimenti nei quali una parte del corpo ne manipola un’altra, ad esempio:
passarsi una mano tra i capelli può significare esasperazione (non a caso esiste il detto “mettersi le mani nei capelli”) ma anche seduzione se fatto da una donna,
massaggiarsi gli occhi o le tempie (stanchezza o stress) grattarsi la testa è spesso accomunato alla menzogna poiché i bimbi che mentono
tendono a farlo, può però significare anche riflessione e necessità di concentrarsi, grattarsi il naso mentre si parla ovvero menzogna oppure esagerazione tirarsi i lobi delle orecchie può indicare indecisione grattarsi il collo ci parla di dubbi e incredulità carezzarsi reciprocamente le mani è invece un chiaro indice di auto-consolazione
poiché siamo in un momento difficile o imbarazzante.

40
in ogni caso cerchiamo di controllarli e non eccedere.
La gestione della distanza Con tale definizione va intesa sia la distanza che si assume rispetto agli altri, sia i movimenti repen-tini miranti a modificare tale distanza. Da come gestiamo tale distanza dagli altri, lasciamo capire il livello di intimità che abbiamo, la si-curezza che proviamo, la nostra cultura di provenienza (per un arabo, la distanza appropriata da te-nere in una situazione sociale è molto minore a quella che terrebbe un giapponese, ad esempio). E non è certo finita qui; di regola maggiore è lo status di una persona, maggiore è la “zona intima che le si riserva, incrementando quindi la distanza. Si tratta dunque di un aspetto importante del nostro linguaggio del corpo, ma in questa sede non ab-biamo motivo per approfondirlo, infatti il regolamento del Debate prevede che il debater sia fermo, in piedi dietro un leggio o ad un tavolo; la gestione della distanza sarà dunque fissa e non trasmette-rà nulla….o quasi. Ci sono dunque delle eccezioni? Sostanzialmente due: se durante il vostro speech vi piegherete in modo significativo sul leggio o sul tavolo quasi che
lo voleste scavalcare con il corpo proteso in avanti, darete la sensazione di desiderare di avvici-narvi fisicamente e emotivamente ai vostri ascoltatori, ma perché lo state facendo? Perché li sentite distanti e non coinvolti? O perché siete molto emozionato? Siate consapevoli del vostro stato d’animo perché in tal caso potrete correggere eventuali eccessi, diversamente rischiate di dare un’impressione sbagliata ai vostri ascoltatori,
di contro se durante la comunicazione vi dovesse accadere di fare un passo indietro, ciò potreb-be essere interpretato come una volontà di distanza; se poi a tale passo indietro si dovesse som-mare l’incrocio delle braccia sul petto (ritirata gestuale), saremmo di fronte ad una possibile menzogna.
L’ascolto attivo Perché unire la parola “ascolto” con l’aggettivo “attivo”? e perché questa competenza dovrebbe mai essere utile nel Debate cioè in una disciplina nella quale è importante parlare in modo persuasivo? L’aggettivo “attivo” non è un semplice arricchimento della parola, ma ne costituisce parte essenzia-le in quanto, per i fini di una buona comunicazione, l’ascolto dovrà necessariamente essere attivo. Erroneamente si potrebbe credere che per ascoltare efficacemente sia sufficiente concentrarsi atten-tamente su ciò che l’altro dice e il gioco sarà fatto; purtroppo non è così o meglio, non è così sem-plice e la prova la abbiamo quotidianamente quando osserviamo quanti pochi siano i buoni ascolta-tori intorno a noi. Ascoltare bene significa farlo attivamente, ovvero mettendo in pratica dei comportamenti che vanno ben oltre la semplice concentrazione e che tra poco vedremo nel dettaglio. Quanto all’utilità che l’ascolto riveste nel Debate la risposta è presto data: due sono i momenti nei quali dovremo essere buoni ascoltatori:

41
1. durante il lavoro preliminare al Debate ovvero nelle attività di studio, preparazione, elabora-zione della strategia di gara il gruppo e non il singolo diviene protagonista e in un lavoro di gruppo non si farà molta strada se tutti i membri non saranno in grado di ascoltarsi recipro-camente con attenzione. Ciò sarà indispensabile per cogliere gli aspetti salienti delle propo-ste dei compagni, per individuarne i punti di forza, per rinforzare o eliminare invece quelli di debolezza;
2. durante il match i giocatori dovranno ascoltare attentamente quanto detto dagli avversari, poiché ciò sarà determinante al fine di porre domande di approfondimento che potrebbero metterli in difficoltà, per poter controbattere con efficacia i loro assunti, per introdurre dubbi nelle menti dei giudici e conquistare punti determinanti.
Facciamo un esempio: se in match che ha come BIRT “L’immigrazione può essere economica-mente conveniente”, il nostro avversario ha fatto un accenno a quanto accade in Germania soste-nendo che in quella nazione l’immigrazione ha aspetti economicamente vantaggiosi, solo se avremo ascoltato con attenzione potremo replicare con: “Perché il mio avversario paragona due paesi diversi? e come mai egli pensa che ciò che funzioni dove c’è una diversa economia e un diverso sistema industriale e sindacale, possa funzionare anche qui?” Una domanda così può sicuramente instillare più di un dubbio in chi sta ascoltando, ma se invece di ascoltare eravamo tutti presi da ciò che avremmo detto, probabilmente questa opportunità ci sfuggi-rà. È dunque essenziale ascoltare in modo attivo; vediamo dunque cosa contraddistingue un buon a-scoltatore.
Ascoltare con tutti i sensi Una lettura altamente simbolica della complessità dell’ascolto ci viene data dall’interpretazione dell’ideogramma cinese che significa questa parola. Compariranno insieme i sensi dell’udito e della vista, l’empatia (il cuore), il tutto legato dalla capacità di at-tenzione unitaria. Facile dunque ricavare che all’ascolto non bastano gli orecchi, bisognerà anche guardare per cogliere le sfu-mature emotive di chi parla e per verificare se vi sia coerenza tra ciò che dice e ciò che esprime il suo volto. Ci si dovrà immedesimare nell’altro per comprendere le sue motivazioni e infine si dovrà essere capaci di fare tutte queste cose insieme, in questo complesso cocktail, e trarre le debite inter-pretazioni da quanto ascoltato. Capito perché ci sono così pochi buoni ascoltatori in giro (noi compresi)? Un ascoltatore empatico si deve concentrare su sei dimensioni: 1. Il contenuto
ciò che l’altro sta dicendo, insomma i concetti, le parole provando a non farsi influenza-re da preconcetti vari. Insomma dobbiamo ascoltare il cosa senza farci impressionare troppo dal come,
2. L’autopresentazione cosa dice di sé, ovvero che immagine di se stesso l’altro sta provando di trasferire negli
ascoltatori

42
3. La richiesta implicita cosa vuole ottenere, è chiaro che nel Debate la richiesta è quella di ottenere attenzione
ma cosa sta cercando di ottenere? Di indignarli per un’ingiustizia? Di commuoverli? 4. La relazione
che tipo di rapporto vuole stabilire con chi lo ascolta? amichevole ? da esperto? 5. La manifestazione emotiva
quali emozioni esprime e perché vuole che le persone si convincano che le sta provando? 6. Il contesto
Come la situazione ambientale influenza il comunicatore? Alcuni nemici dell’ascolto Durante l’ascolto ci potrebbe accadere di……..
Ascoltare in modo selettivo Si ascolta solo ciò che si vuole sentire ovvero si lascia passare quello, poco o molto che sia, che i nostri filtri per-cettivi lasciano passare. I filtri più comuni sono dati dalle nostre esperienze, i nostri vissuti, ma abitudini, cultura, valori etici e morali non scherzano. In tal modo tutto ciò che ci sembra lontano ci appare anche non degno di atten-zione, anche perché in caso contrario, dovremmo mettere in discussione noi stessi.
Fare le prove Si pensa a cosa si dirà, non concentrandosi su ciò che sta dicendo l’interlocutore; una frase, un concetto ascoltato innescano automaticamente il “adesso gli rispondo questo e poi ribatto con quest’altro e vedremo….”. quando ciò accade avverrà che perderemo molti pezzi di quanto l’altro dice poiché distratti dalle nostre prove.
Identificarsi Si riferisce tutto quanto si ascolta alla propria esperienza e quindi si compie quello che definiamo “errore di proiezio-ne logico”; dobbiamo renderci conto che la nostra espe-rienza non è l’unica chiave di realtà possibile, anche se possediamo solo quella.
Denigrare – Sminuire Si snobba o si accantona quanto viene detto perché ritenu-to di poca importanza; è qualcosa di molto simile alla ra-zionalizzazione della volpe con l’uva quando dichiara “Nondum matura est” non è ancora matura, riferita all’uva che in realtà non è riuscita a raccogliere perché troppo in alto per lei. Quando sminuiamo ciò che ascoltiamo non facciamo altro che dire: non vale neppure la pena di ragionarci su.
Esprimere giudizi su chi parla Quel che si giudica non si può comprendere……quando attacchiamo un’etichetta addosso ad una persona la com-prensione si ferma. Difficilissimo non cadere in questa trappola; un meccanismo atavico ci obbliga ad etichettare le persone immediatamente, questo comporta una conse-

43
guenza: badiamo più a chi parla che a ciò che dice. Proviamo ad ascoltare i contenuti esimendoci dai giudizi su chi sta parlando.
Il lavoro di gruppo Durante le fasi del match di Debate, il debater è solo di fronte a giudici e pubblico, non può scam-biare con i compagni di squadra neppure un cenno, figurarsi poi delle informazioni o dei consigli e tutto ciò potrebbe farci credere che questa sia una disciplina prevalentemente individualistica. Questo sarebbe un grave errore! Se vogliamo servirci di una metafora sportiva potremmo pensare alla Formula uno; vero che il pilo-ta è solo nel suo abitacolo, ma l’auto che guida, il suo assetto, le soluzioni tecniche e la strategia di gara sono frutto di quanto accaduto prima e tutto ciò è accaduto in un gruppo di tecnici, ingegneri,
specialisti di aerodinamica che pensano, coadiuvano e integrano il lavoro del pilota. Questi per quanto bravo non potrà vincere senza un buon gruppo intorno; ragionamento simile può essere fatto per un debater. Apparentemente coloro che vanno “in campo” sono tre o a volte quattro; oltre a loro sarà necessaria la presenza di un bravo ricercatore, di un allenatore, di una persona che sappia scrivere gli speech. A volte alcuni di tali ruoli sa-ranno rivestiti dalla stessa persona, altre volte ciò non sa-rà possibile e la squadra finirà per essere composta dai
quattro ai sei membri. Tutte queste persone devono imparare a lavorare insieme avendo un unico obiettivo: far vincere la squadra! Essi dovranno quindi pensare come gruppo mettendo da parte i propri individualismi e questo, cre-detemi, non è affatto facile.
Il gruppo I concetti che seguono connotano le caratteristiche di un buon gruppo; che della vostra squadra di debater voi siate il leader o un partecipante, dovrete agevolare la realizzazione delle predette carat-teristiche. Se ci riuscirete imparerete una competenza che nella vita lavorativa vi sarà preziosa ben oltre i match di Debate.
Il fine crea il gruppo Un gruppo non è solo la somma matematica di alcune persone, pur se da queste è composto, ma è qualcosa in più; si ritiene infatti che un gruppo, se ben gestito abbia competenze maggiori della somma di quelle dei singoli. Accadrebbe dunque che in un buon gruppo, e per mia esperienza que-

44
sto succede quando esiste un buon capo, il totale è maggiore della somma degli elementi che lo compongono. Pensate che poiché è possibile misurare il QI di un gruppo, si è riscontrato che in un gruppo ben gestito, il QI di gruppo è maggiore del più alto QI singolo. 12 Purtroppo può anche accadere il contrario, ovvero un gruppo conflittuale o mal condotto, avrà com-petenze minori di quelle dei singoli. Una metafora interessante ci propone di immaginare alcune persone che, in visita al giardino zoolo-gico, siano tutte intente ad ammirare una tigre nella sua gabbia. Al momento questo è solamente un insieme di persone; ma immaginiamo che all’improvviso, per un qualsivoglia motivo, la gabbia si apra e la tigre salti fuori. Gli spettatori terrorizzati si rinchiudono in una baracca vicina, mentre la tigre gira nelle vicinanze sperando di integrare il pasto fornitole dallo zoo con uno spuntino extra. È probabile che tra le persone assediate, qualcuno cercherà di assumere la guida del gruppo, qual-cuno rincuorerà quelli spaventati, altri barricheranno le porte e le finestre e infine altri, come in tutti i gruppi che si rispettino, non faranno proprio un bel niente. A tal punto potremo dire che queste persone sono divenute un gruppo, momentaneo poiché cessata la minaccia si potrà sciogliere, ma pur sempre un gruppo, perché ha un fine comune e condiviso: salvarsi. Chiaramente se qualcuno all’interno del gruppo avanzasse una proposta di questo genere: “Ehi prendiamo lui/lei che è anzianotto e anche sovrappeso, lo lasciamo alla tigre e noi nel frattempo scappiamo….” Beh in tal caso non avremmo titolo per parlare di gruppo. Quindi abbiamo già identificato la prima caratteristica che identifica un gruppo: il fatto che tutti i membri abbiano un fine comune e condiviso, ovvero tutti sanno di avere un certo obiettivo il rag-giungimento del quale sia voluto da tutti i membri.
Un rapporto durevole e solido I membri devono percepirsi come parte di una unità durevole nel tempo e nello spazio, dal che si deduce che le persone che costituiscono la nostra squadra, dopo essere state scelte, dovranno restare insieme per del tempo. La saltuarietà non sarà di nessun aiuto poiché nessuno si identifica in un gruppo nel quale non sa fino a quando resterà; altrettanto dannosa sarà l’abitudine di cambiare un membro perché ha sbagliato e si è mostrato al di sotto delle attese. Bisognerà avere pazienza e tolle-rare gli insuccessi poiché le persone vogliono sentirsi difese dal gruppo, anche se sbagliano. Questo aspetto merita una particolare attenzione: benché la cosa non venga razionalizzata dai più, stare all’interno di una qualunque struttura sociale, che si tratti di un piccolo gruppo, di un’azienda o di una nazione, costa una certa serie di “fatiche”. Dobbiamo sottostare a delle regole e poco conta che siano scritte (leggi) o non scritte (usanze, abi-tudini), dobbiamo praticare un costante sforzo di adattamento continuo agli altri, pena una perenne conflittualità. C’è poi un altro sforzo da sostenere quando siamo in gruppo e non diviene minore per il suo nome evocativo: lo specchio frantumato. Quando si entra per la prima volta in un gruppo, questo rispecchia dell’individuo una immagine scissa; è un po’ come riflettersi in uno specchio frantumato in tanti pezzi, ciascuno dei quali ri-manda una parte della stessa immagine totale. I pezzi dello specchio sono naturalmente i membri del gruppo che rimandano al singolo, tramite la loro comunicazione, i frantumi che altro non sono che le singole percezioni che hanno ricevu-to.
12
D’altro canto se vi fa piacere saperlo, in un gruppo di lavoro nel quale molti se non tutti tengono accesi cellulari e tablet il QI scende anche di un buon 30%. Avete capito perché sembra che in certe riunioni non esca mai nulla di buo-no?

45
L’obiettivo del singolo sarà a quel punto quello di ricomporre l’immagine nella sua globalità, ma il risultato di questa ricomposizione può essere duplice ovvero, l’immagine ricomposta potrà es-sere conforme o difforme dall’immagine che la persona ha di se. In ogni caso tale sforzo sarà fa-ticoso e molti potrebbero reagire negativamente. Quando al modo, i membri dovranno lavorare con un metodo funzionale al gruppo stesso e anche in tal caso ci può aiutare una metafora sportiva; avete mai visto una partita di football americano? Se non dal vero in quanto sport poco diffuso da noi, probabilmente avrete visto qualche scena al cine-ma in film famosissimi quali: Quella sporca ultima meta, Ogni maledetta domenica e tanti altri. Quando il quarterback effettua un lancio dopo la mischia, al profano sembra di vedere una miriade di persone che corrono dissennatamente di qua e di là. Niente di più errato! Infatti qualche istante prima è stato urlato un numero che corrisponde ad una delle dozzine di sche-mi di gioco che i giocatori devono conoscere a memoria e allora alcuni correranno verso la meta, altri li difenderanno, uno infine saprà dove il lancio del quarterback cadrà per farsi trovare pronto a raccoglierlo e andare in meta. Potrà sembrare una conclusione individuale ma sarà il frutto dell’azione combinata e organizzata di ciascuno. Quello che qui definiamo schema di gioco fuor di metafora è appunto il metodo funzionale al gruppo, dove ognuno sa cosa deve fare, perché, in che modo e quindi capisce quanto sia contributi-vo al risultato finale. In una squadra di Debate ci sarà chi scrive gli speech, chi fa le ricerche, chi simula eventuali do-mande imbarazzanti, chi decide i ruoli ma tutti alla fine convergeranno verso l’unico obiettivo: far vincere la squadra. In questa fase il ruolo del leader che affida i compiti e verifica che vengano svolti in modo cor-retto, è di importanza essenziale.
Prima il gruppo poi l’io In un gruppo ben coeso, i membri percepiscono gli obiettivi comuni come prioritari rispetto a quel-li individuali. Questo è l’aspetto più critico da realizzare e qui il buon leader farà la differenza; egli deve essere in grado di far capire a coloro che costituiscono il gruppo che, alla priorità dell’obiettivo comune non dovranno essere sacrificati gli obiettivi individuali, bensì che solo realiz-zando l’obiettivo comune si potranno raggiungere anche gli obiettivi individuali. Immaginate un giocatore di basket e il suo obiettivo individuale di diventare il miglior realizzatore o il miglior rimbalzista; egli si troverà di fronte ad un bivio: usare i compagni di squadra per rag-giungere il suo obiettivo o mirare al successo della squadra affinché egli possa ottenere il proprio obiettivo. Un bravo leader lo farà optare per la seconda scelta e arriverà a togliere dalla squadra an-che una brava individualità che però non avesse senso del gruppo. Un altro bell’esempio cinematografico di quanto appena detto è il film “True blue. Sfida sul Tami-gi” la cui visione chiarirà meglio in concetto.
Buoni e cattivi leader Non è questa la sede per discutere l’eterno dilemma: leader si nasce o si diventa? Non ne abbiamo il tempo, non è questo l’oggetto essenziale del nostro discorso e poi probabilmente non vi è neppure una risposta univoca. Certo si nasce con alcune caratteristiche individuali quali:

46
capacità comunicativa ed estroversione, gestione dell’ansia capacità di decidere sotto stress intelligenza analitica
poi esperienze e circostanze ti fanno diventare un buon leader, ma come si comporta questa persona con i membri della sua squadra? Diciamo che vi sono due piani come sempre accade nella comunicazione: sul piano dei contenuti egli dovrà:
affidare i compiti definire i ruoli decidere tattiche e strategie
dal punto di vista della relazione egli dovrà:
dare feed-back sia positivi che negativi se del caso, ascoltare, valutare, assorbire l’ansia dei compagni e non far apparire la propria né tantomeno scaricarla sugli altri.
Starà solo a lei/lui decidere con quanta “democraticità” vorrà svolgere il proprio ruolo; le comples-sità di questo discorso richiederebbero un altro libro per essere affrontate, ma sia chiara una cosa. Un leader democratico ascolta le opinioni dei membri e arriva ad una decisione possibilmente con-divisa che comunque sarà una sua decisione. Un individuo che scarichi sul gruppo il peso della decisione non è un leader ma un vigliacco e an-che se potrà apparire una generalizzazione, tanti anni di esperienza vale la pena ripeterlo, mi hanno insegnato che dietro ad un buon gruppo c’è un buon leader e che un cattivo leader al contrario, da vita a gruppi scadenti.
Fare il punto del gruppo Uno dei presupposti della vita di gruppo è che le risorse dei singoli, intendendo per esse le compe-tenze, le capacità, le informazioni in possesso di ciascun membro, sono un patrimonio del gruppo; di contro ogni vincolo dei singoli, quali carenze formative, mancanza di esperienza problemi comu-nicativi sono un vincolo del gruppo che dovrà affrontarli insieme. Cosa significa questo da un punto di vista pratico? Immaginiamo ad esempio che un membro del gruppo sia particolarmente abile nel fare ricerche in Rete; egli dovrà mettere questa competenza al servizio del gruppo. Se qualcuno avrà quella capacità innata di individuare i punti deboli di un ragionamento, egli dovrà mettere in pratica questa compe-tenza con gli speech dei compagni e insieme a loro trovare il modo per superare questi punti deboli. Le argomentazioni andranno simulate stando insieme fino a quando non scorreranno logiche ma gradevoli all’ascolto e ciascuno dovrà considerare le critiche come un contributo utile e positivo. Dare feedback ai compagni in modo equilibrato, mai sarcastico, sarà determinante per la crescita di senso del gruppo e dello spirito di collaborazione.
Curare il gruppo

47
In conclusione è bene ricordare che il senso di appartenenza alla squadra di Debate avrà un peso considerevole nelle performance della stessa ma sarebbe superficiale credere che la squadra in quanto tale farà automaticamente gruppo. Sarà responsabilità principalmente del leader e dei mem-bri tutti curare la vita della squadra; in particolare si dovrà:
Valutare oggettivamente le prestazioni e correggere i gap, fare il medico pietoso non aiuterà a migliorare. Il gruppo dovrà avere la maturità di valutare se stesso e la performance dei singoli senza eccedere nella critica gratuita ma neppure nella collusione (siamo stati bravi ma i giudici non hanno capito nulla).
Come una vera squadra definire un programma di addestramento, facendo simulazioni, provan-
do gli speech, guardando filmati che possono fornire spunti di discussione, insomma miglioran-do in continuazione. La qualità della squadra non procede per grandi balzi ma attraverso piccoli progressi quotidiani.
Essere attenti alle dinamiche interne; definire cosa sia il clima di un gruppo sarebbe inappropria-to in questa sede, ma senza necessità di spiegazioni tutti siamo in grado di comprendere il clima che c’è in un certo ambiente anche se non sempre siamo capaci di capirne le cause. A chi non è capitato di arrivare a casa di amici e sentire un clima conflittuale o percepire che in un ufficio c’è un clima sereno? Qualora ci si accorgesse che vi siano problemi nelle dinamiche tra i mem-bri bisognerà intervenire immediatamente parlando con le persone coinvolte. L’errore più grave sarà fingere di nulla sperando che le cose si risolvano da sole; di regola le situazioni conflittuali, lasciate a se stesse tendono ad aggravarsi.
I ruoli in una squadra di Debate Abbiamo già accennato che una ben organizzata squadra di Debate non si compone esclusivamente dei suoi tre speaker, ai quali al limite se ne potrà aggiungere un quarto quale riserva. Una composizione tanto minimale potrà bastare qualora ci si limiti a qualche match prevalentemen-te giocoso; qualora invece le cose dovessero farsi più serie occorrerà una organizzazione più artico-lata; quella ideale potrebbe prevedere la seguente suddivisione dei ruoli:
Allenatori: gli oratori dovranno provare i propri speech ma a poco servirà se lo faranno in solitudine e senza confronto; gli allenatori sono coloro che segnaleranno quali potrebbero essere i dubbi e le incomprensioni degli ascoltatori, i passaggi più deboli da migliorare, cosa fare per rendere più gradevole il tono e il linguaggio del corpo. Potranno anche porre do-mande imbarazzanti affinché i debater si preparino qualora tali domande arrivino dagli av-versari.
Strateghi: pianificano il succedersi degli oratori e delle argomentazioni prefiggendosi come fine due obiettivi principali: il logico susseguirsi dei contenuti, la collocazione degli oratori in maniera tale che i rispettivi argomenti rimangano ben impressi nell’attenzione degli ascol-tatori.
Ricercatori: sono coloro che, partendo dall’argomento da dibattere, effettuano ricerche ed analisi delle fonti, le selezionano in base alla loro attendibilità, le sfrondano dalla miriade di informazioni inerenti ma non utili e, alla fine, redigono un documento dal quale i debater potranno attingere per le proprie citazioni.
Osservatori di supporto: queste persone durante le fasi del Debate appuntano quelli che han-no giudicato essere i punti salienti citati dalla squadra avversaria, propongono come confu-tarli o superarli e nelle pausa precedente all’ultima fase li segnalano agli oratori per aiutarli nella replica.

48
Riserve: oratori disponibili a sostituire i membri “di ruolo” in caso di loro impossibilità; ide-almente dovrebbero avere competenze simili a quelle dei debater sostituiti.
Capacità intellettive specifiche necessarie nel Debate
Che il Debate sia una disciplina complessa, credo ormai sia un concetto accettato e sarebbe erroneo credere che occorrano singole competenze intellettive, quasi che potessimo considerarle staccate l’una dall’altra. In realtà nei compiti complessi noi dobbiamo reagire con la totalità di noi stessi e quindi è l’insieme del nostro intelletto ad essere chiamato in causa. Ciononostante su alcune peculiarità possiamo e dobbiamo concentrare la nostra attenzione, vedia-mole di seguito:
Attenzione e concentrazione Una classica storia zen racconta di un allievo che chiede al maestro: “Maestro cosa mi occorre per riuscire nello zen?” e il maestro risponde: “Concentrazione” al che l’allievo perplesso insiste: “Potresti per favore essere più chiaro maestro?” “Hai ragione: concentrazione, concentrazione” “Però Maestro io ancora non ben capito” “Scusami, sarò più chiaro: concentrazione, concentrazione, concentrazione.” La concentrazione su uno stimolo o attenzione che dir si voglia, è il processo attraverso il qua-le si selezionano alcuni stimoli, li si mette a fuoco e se ne prende una chiara visione. Per riuscire a concentrare l'attenzione, bisogna riuscire a eliminare dal campo di coscienza tutti gli altri stimoli che risulterebbero di disturbo e sostenere lo sforzo e l'impegno per il tempo necessario. La capacità di concentrare la propria attenzione su un particolare tema o un particolare problema è una cosa molto importante per l'apprendimento e la memorizzazione dei concetti. Non si faccia però l’errore di credere che il tutto consista nel fissarsi su un concetto; la mente, come dice un vecchio proverbio orientale è una scimmia ubriaca ed è rarissimo riuscire a concentrarsi su di un argomento anche solo per pochi secondi senza distrarsi. Se poi si lavora in gruppo le distra-zioni si moltiplicano, occorrerà quindi una discreta forza di volontà e il leader del gruppo dovrà as-sumersi l’ingrato compito di richiamare i compagni al compito prefisso, senza perdersi in inutili di-gressioni. Attenzione però: in alcune discussioni esistono momenti di brainstorming nei quali le divagazioni sono previste e doverose e il lasciar fare alla mente collegamenti apparentemente illogici, fa parte del gioco stesso. La concentrazione su un singolo stimolo è un esercizio tipico del training autogeno e delle tecniche di rilassamento; apprenderle potrà essere di notevole aiuto nello sviluppo di questa importante com-petenza.

49
Capacità di analisi e sintesi Con questi termini che non riguardano capacità separate ma anzi, capacità che devono convivere armonicamente, si intendono due diverse abilità di una persona
quella di analisi ovvero il comprendere un problema in profondità e nelle sua ampiezza riu-scendo ad estrapolarne le varie sfaccettature,
quella di sintesi che interverrà successivamente ricomponendo tutti gli aspetti evidenziati in una visione unitaria e globale.
Come detto in premessa i due processi dell’analisi e della sintesi devono convivere tra loro in modo armonico. La sola capacità analitica, ci permetterebbe di esaminare approfonditamente l’argomento che stiamo studiando, ma fermandoci a questa fase rischieremmo di rimanere ad una visione frammentaria e parziale mancandoci così il quadro di insieme. La sola sintesi di contro, può aiutarci ad individuare i collegamenti tra i vari aspetti del problema in modo rapido e intuitivo, ci creeremmo così una visione generale della situazione che però potrebbe essere superficiale, avendo omesso di entrare in dettagli importanti. Come vedete non è facile riuscire a bilanciare questi due aspetti, ma ecco uno strumento che può aiutarci.
Il diagramma delle affinità Si tratta di un metodo semplice che richiede solo una lavagna (ma anche uno spazio vuoto su una superficie liscia può andare) e qualche blocchetto di post-it. L’ideale è usarlo in gruppo poiché in tal modo la produzione di idee sarà più ricca, ma in teoria nul-la vieta di usarlo anche individualmente. Immaginiamo all’interno di un assunto dato: “I social network compromettono la vita di relazio-ne” di voler approfondire con un processo di analisi e sintesi il concetto di social network. A tal punto distribuiremo una mezza dozzina di post-it ad ogni partecipante del gruppo e ciascuno dovrà scrivere tutti i concetti che gli vengono in mente se pensa all’assunto. La sola regola da ri-spettare è che: Non si possono scrivere più concetti in un unico foglietto; un
post-it = un concetto. Quando tutti avranno concluso il loro lavoro; il primo parteci-pante inizierà ad attaccare alla lavagna i proprio foglietti dando una rapida spiegazione, giacché lo spazio di un post-it non è tale da permettere grandi elucubrazioni. Ad esempio se sul piccolo riquadro c’è scritto “cyber bullismo” la persona spiegherà che i social sono l’ambito naturale di que-sto fenomeno che a volte, nei casi estremi, ha addirittura indot-to degli adolescenti al suicidio. Ogni volta che il singolo attaccherà un post-it, il gestore del

50
gruppo gli chiederà se vi sono attinenze tra l’ultimo che sta per attaccare e quelli precedenti. In caso affermativo egli dovrà attaccare la sua nota vicino a quella/e che ritiene più affini. Poiché tutti i partecipanti faranno la stessa cosa, alla fine sulla lavagna si noteranno dei naturali as-sembramenti di post-it ai quali potremo dare un nome che identifichi la famiglia, scrivendolo su un post-it di colore diverso. Immaginiamo allora che sia emersa una lista di post-it quale quella che segue:
1. cyber bullismo 2. profitto scolastico 3. confusione tra vita virtuale e vita reale 4. reputazione digitale 5. influenze sulla futura ricerca del lavoro 6. dipendenza 7. indispensabilità del mezzo 8. controllo genitoriale 9. problemi di postura fisica 10. ecc.
come si vede tra i post-it 3, 6, 9 c’è una certa correlazione e potremo mettere i relativi post-it sotto uno che citi: “Rischi alla salute fisica e mentale”. Tra le famiglie affini (da cui il nome dello strumento) tramite frecce di colori diversi, evidenziere-mo le correlazioni, gli influenzamenti reciproci, costruendoci così una visione che partita dall’analisi è arrivata alla sintesi e a quello che in inglese si definisce “the big picture” ovvero il quadro di insieme.
Saper fare una ricerca Nel momento in cui l’organizzazione del Debate comunicherà alle squadre l’oggetto del contendere ovvero l’assunto sul quale i contendenti si misureranno, insomma il BIRT, questi scopriranno pro-babilmente di avere dell’argomento una conoscenza che potrà essere più o meno ampia, ma spesso non sufficiente. Ricordiamo che questo oggetto verrà espresso come una proposizione sempre in forma affermativa, ad esempio:
“I videogiochi possono avere un fine terapeutico” Sia che si faccia parte del team Pro o affermativo che di quello Contro o negativo, bisognerà incre-mentare le proprie conoscenze e per farlo bisognerà essere in grado di fare una buona ricerca. Non cadiamo nel facile inganno di credere che oggi, avendo a disposizione la Rete e i motori di ri-cerca, svolgere questa fase sia diventato facile; certo sarà più facile avere accesso a molte informa-zioni, ma attenzione: l’eccesso di informazioni può diventare deleterio. Potremmo annegare tra dati, ricerche, statistiche e, come al solito, la nostra ciambella di salvataggio sarà darci un metodo. Vediamo dunque quali sono i passaggi da effettuare per svolgere una buona ricerca:

51
La lista della spesa Come chiunque debba organizzarsi per decidere cosa comprare, vi occorrerà una “lista della spesa”, iniziate dunque scrivendo da un lato tutte le cose che dell’argomento già conoscete. Dall’altro lato scrivete invece quelle che ritenete giusto approfondire e quelle che non conoscete affatto. Questo passaggio è necessario per delimitare l’ambito della vostra ricerca.
Saper fare la domanda giusta A volte il vero problema non è trovare le risposte ma farsi le giuste domande; la stessa cosa accade con una ricerca. Dovete chiedervi cosa vi prefiggete di ottenere, ovvero porvi domande quali:
cosa voglio dimostrare? cosa vorrei che colpisse gli ascoltatori? che tipo di emozioni voglio generare?
Ciò vi permetterà di dare una determinata impronta alla vostra ricerca. Dopo esservi chiesti il “co-sa” ora chiedetevi il perché. Torniamo all’esempio “I videogiochi possono avere un fine terapeutico”; nel porvi le domande ini-ziali avete definito di voler dimostrare che alcune tipologie di videogiochi possono addirittura con-correre a curare delle disfunzioni neurologiche (cosa). Ritenete che approfondire tale aspetto sia importante perché sull’argomento probabilmente vigono prese di posizioni estreme: da un lato qual-cuno adora i videogiochi, dall’altro qualcuno li disprezza. Se in fase di presentazione del vostro speech direte queste cose, avrete ben chiarito l’ambito nel quale parlerete e questo sarà di grande aiuto nell’essere ascoltati.
Non di solo Google……. Sarebbe superficiale pensare che la Rete contenga delle verità assolute, il Web è veloce ma non e-saustivo e a volte anche la famosa Wikipedia è incompleta se non addirittura inesatta. L’utilizzo di una buona enciclopedia sarà una buona idea ma potrebbe essere di grande aiuto una visita in biblio-teca; lì con i consigli e le indicazioni di chi ci lavora potreste individuare fonti specifiche e molto utili.
L’importanza delle esperienze specifiche Potrete citare fonti primarie o secondarie13, mostrare statistiche e risultati di ricerche, ma poco o nulla sarà convincente quanto citare un’esperienza specifica. Cercate quindi testimonianze di perso-ne che per motivi professionali o per altro sono coinvolte direttamente nell’ambito che discuterete. Immaginate dunque quale effetto potrà fare su giudici e ascoltatori, invece di citare i classici freddi numeri dire: “In una recente intervista, il professor Xxxxxxx, primario di neurologia all’ospedale di ………. ha dichiarato che da anni ormai nel loro reparto vengono usati i videogiochi nella cura di disturbi neurologici infantili.”
13
Le fonti primarie sono prove e documenti provenienti da persone che hanno avuto diretto contatto con una situazione. Le fonti secondarie sono quelle che discutono informazioni provenienti da fonti primarie. Ad esempio: il diario di un personaggio storico è una fonte primaria, il riportare quanto scritto da uno studioso che ha esaminato quel diario è una fonte secondaria.

52
Non restiamo impigliati nella Rete Prima si diceva che di troppi dati si può anche morire soffocati, infatti l’eccesso di informazioni non è certamente un bene; nella sua sovrabbondanza potremmo incappare in dati errati o quanto meno, lasciarci sfuggire informazioni importanti. Sarà determinante dunque saper fare una ricerca efficiente e questo significherà saper usare il giusto linguaggio; alla fine di questo piccolo manuale troverete una serie di consigli e trucchi su come u-sare bene quello che ormai è diventato un compagno perenne del nostro tempo: Google.
Anche un viaggio di mille miglia inizia con il primo passo14 E ora cominciate a scrivere; in base alle vostre preferenze potrete usare un quaderno o un software molto noto come Word di Microsoft. Il suo utilizzo potrà andare dal banale scrivere come se aves-simo una macchina da scrivere molto sofisticata a creare un ipertesto con link ad altri file o siti web e fotografie. Per qualcuno potrà essere piacevole un grande blocco per appunti, con foglietti e anno-tazioni in ogni dove.
Comunque scrivete! Solo iniziando a scrivere capirete man mano che direzione vorrete dare alla vostra tesi, cosa manca e va rafforzato, cosa scorre bene e vi sembra convincente. In ogni caso sarà un lavoro molto soddisfacente che miscela sapientemente il gusto per la scoperta con la curiosità dell’investigazione.
14
Lao-Tsu o Laozi (filosofo cinese del 500 a.C. circa)

53
Le fasi di un match di Debate Conduzione del Debate: Un match di Debate si apre con la squadra affermativa ovvero la squadra che supporta la risoluzio-ne, che presenta i propri argomenti tramite il primo debater; a questi seguirà un membro della squa-dra avversaria. Questa situazione si ripeterà per il secondo debater di ogni squadra. A tal punto ver-ranno dati alcuni minuti perché vengano preparate le confutazioni e infine ogni squadra avrà l'op-portunità per confutare gli argomenti della avversario. In quest’ultima tornata però parlerà prima la squadra negativa e alla fine quella affermativa. Nelle confutazioni conclusive non si possono presentare argomenti nuovi poiché non vi sarebbe più l’occasione per confutarli. Una tipica sequenza di dibattito, con suggerimenti circa le durate, è la seguente: Il primo oratore del team affermativo presenta ar-gomenti a sostegno della risoluzione.
Dai 5 ai 10 minuti Le loro argomentazioni, essendo le prime saranno chiaramente non legate a quanto detto dall’avversario. Le con-futazioni avverranno do-po
Il primo oratore della squadra avversaria presenta argomenti contrari alla risoluzione.
Dai 5 ai 10 minuti
Il secondo relatore sulla squadra affermativa presenta ulteriori argomentazioni a sostegno della risoluzione, identifica le aree di conflitto, e risponde alle domande che potrebbero essere stati sollevate dallo speaker dell'opposizione.
Dai 5 ai 10 minuti
Il secondo relatore della squadra negativa pre-senta ulteriori argomenti contro la risoluzione, individua ulteriori aree di conflitto, e risponde alle domande che possono essere state solleva-te dal precedente speaker della squadra affer-mativa.
Dai 5 ai 10 minuti
Le regole possono includere una breve pausa per le squadre affinché i debater possano pre-parare i loro confutazioni. Questo momento di pausa è altamente consigliabile.
5 minuti
La squadra negativa con il terzo relatore inizia con la propria confutazione; ovvero cercherà di difendere le argomentazioni oppositive e di sconfiggere gli argomenti a sostegno.
3 -5 minuti In questa fase si po-tranno rafforzare le ar-gomentazioni presenta-te e smontare quelle opposta ma non po-tranno essere aggiunte nuove informazioni.
La squadra affermativa con il terzo relatore i-nizia con la propria confutazione; ovvero cer-cherà di difendere le argomentazioni afferma-tive e di sconfiggere gli argomenti negativi.
3 – 5 minuti
I giudici tramite la compilazione delle griglie avranno qualche minuto per preparare le pro-prie valutazioni che dichiareranno per definire la squadra vincitrice. In pratica ogni giudice dovrà dire quanti punti ha assegnato ad ogni
3 – 5 minuti

54
debater. In certi casi, quando la valenza didat-tica è predominante i giudici potranno anche motivare i propri giudizi.
Impariamo dall’esperienza Quando il dibattito formale sarà ormai terminato, potrebbe essere opportuno lasciare del tempo per il de briefing e per la discussione; questa fase è importante perché consente di razionalizzare l’esperienza appena fatta e ricavare da essa degli importanti apprendimenti. Ai membri del pubblico dovrebbe essere data la possibilità di porre domande e di contribuire con i propri pensieri e pareri sugli argomenti presentati. I membri delle squadre che hanno dibattuto potrebbero anche riflettere su le loro prestazioni e cer-care feedback da parte del pubblico e dei giudici. Per esempio sarebbe importante per i debater capire i criteri di valutazione dei giudici e quindi di-venire consapevoli del perché abbiano ottenuto giudizi positivi o negativi. Anche se ogni giudice ragionerà in modo diverso e assolutamente peculiare, tutti comunque si rifa-ranno ad una griglia comune di osservazione e per un debater è importante comprendere i motivi delle valutazioni.

55
La strategia di gara e le fallacie logiche Quando si parla di strategia vige una regola:
Non ci sono regole! Aldilà dei giochi di parole, se dovete decidere come impostare il vostro speech, come contrastare i vostri avversari, quali accorgimenti usare, vi sarà di aiuto la fantasia, la creatività, la capacità di prendere decisioni su due piedi e tutto ciò ha poco a che spartire con regole rigide. Ciononostante qualche piccolo accorgimento converrà rispettarlo. Un match di debate ha sostanzialmente tre momenti topici:
1. l’introduzione, 2. la cross-examination (letteralmente interrogatorio incrociato) 3. la confutazione.
Vediamole in maggior dettaglio.
La fase introduttiva Forse è eccessivo dire che sia la più importante ma è sicuramente decisiva, infatti è quella che da l’imprinting al lavoro della vostra squadra; se non aggancerete subito l’attenzione degli ascoltatori potreste non riuscirci più. Se poi l’introduzione fosse fatta in modo anche corretto da un punto di vista tecnico, ma freddo e impersonale, probabilmente vi sarete giocati il match. Questa fase è contraddistinta dalla sigla BIRT (Be It Resolved That) ovvero si definisce che, si con-viene che, e l’assunto è sempre espresso in forma positiva mai al contrario. Ad esempio si dirà: Si definisce che la qualità di vita è migliore nelle piccole città che nelle metro-poli. Anche se, detta in forma negativa poco cambierebbe, non avremmo mai un BIRT così espresso: Si definisce che nelle metropoli la qualità della vita non sia migliore che nelle piccole città. Il primo oratore o debater deve assicurarsi che la risoluzione introduttiva sia chiaramente indicata e definita e ciò non ha solo una valenza formale; in ultima analisi gli ascoltatori e in particolare i giu-dici dovranno chiedersi: la squadra affermativa ha dimostrato la fondatezza della risoluzione intro-duttiva? Discorso opposto si farà per la squadra negativa. Sarà opportuno, dopo il BIRT, che presentiate i due o tre punti essenziali sui quali si baserà il vostro speech, quindi approfondite ciascuno singolarmente avendo l’accorgimento di partire dal più debole per arrivare alla fine al più forte. Sarà quello che in tal modo resterà più impresso. Alla fine, ricapitolate brevemente quanto detto.

56
La cross-examination Prende il suo nome da una parte importante del processo giudiziario anglo-americano, anche se ne-gli ultimi anni, questa possibilità per gli avvocati di porre domande 15 direttamente alla controparte è presente anche nel nostro ordinamento. È certamente la fase più difficile poiché vi obbligherà a decidere ed agire su due piedi, infatti voi non sapete cosa dirà il vostro avversario e quindi non avrete tempo di prepararvi. Dando per scontato che avrete ascoltato con attenzione, dovrete essere in grado di mettere in dubbio la validità di quanto detto dal vostro avversario nel suo discorso costruttivo minandone le fonti, le date, la pertinenza. Pensiamo a questo caso reale: match di Debate che ha come assunto di partenza “L’immigrazione può essere un investimento per il nostro Paese.” Riprendiamo un esempio citato quando si parlava di ascolto attivo. Il primo debater espone il punto di vista della squadra affermativa dichiarando che in Germania l’immigrazione ha risvolti economici positivi e la mano d’opera viene perfettamente integrata. È una prospettiva suggestiva alla quale il debater della squadra avversaria non sa rispondere, la-sciando così negli ascoltatori l’idea che anche lui ha dovuto prendere atto di questa “verità”. In realtà sarebbe bastato dire in tono interrogativo: “Italia e Germania hanno stessi sistemi occupa-zionali e sindacali, hanno la stessa produttività industriale, hanno numeri simili di grandi indu-strie? Direi proprio di no e quindi come può il mio avversario credere che ciò che funzioni da una parte possa funzionare anche da noi?” Dopo una domanda generale di tale tipo si potrebbe continuare con una più ficcante: “Consideran-do che in Italia circa l’80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti, come si riuscirebbe a gestire questo fenomeno con migliaia e migliaia di piccoli imprenditori e in aziende dove non esiste neppu-re una rappresentanza sindacale?” Ecco dunque l’essenza di questa difficile fase: essere in grado rapidamente di individuare i punti deboli delle dichiarazioni dell’avversario e porre domande aggressive ma corrette, che lo pongano sulla difensiva e mettano il seme del dubbio nella mente di chi ascolta. Potrà esservi di aiuto una competenza prettamente emotiva ovvero l’empatia; dovrete dunque essere in grado di immedesimarvi nei vostri avversari, pensare con la loro testa, chiedervi quali argomen-tazioni portereste se vi trovaste nei loro panni e quindi individuare gli elementi per confutarle. Ve lo avevo detto che si tratta di una disciplina complessa, no?
La confutazione Se nella fase precedente abbiamo fatto domande che minavano la credibilità di quanto detto dagli avversari, ora è il momento di criticare direttamente le loro argomentazioni sottolineandone le as-surdità, gli aspetti illogici, le incongruenze. In questa fase non andranno citati nuovi fatti (che non potrebbero più essere discussi) ma bisognerà dare una forte “stoccata” finale; qualcosa che rimanga impresso negli ascoltatori. Nel film (da vedere assolutamente per chi sia interessato all’argomento) “The great debaters. Il po-tere della parola.”, mentre è in discussione la liceità della disobbedienza civile, l’oratore finale nar-
15
A proposito della cross-examination sostiene il sito dei legali romani: la differenza sostanziale tra il sistema inquisi-torio e quello accusatorio risiede nel metodo di accertamento dei fatti, incentrato in un caso attorno alla figura del Giudice, nell’altro sul contrasto dialettico tra accusa e difesa davanti al Giudice, che ha il compito di decidere.

57
ra che nel suo Stato di provenienza, il Texas, i neri vengono impiccati in modo sommario. A tal punto pone gli ascoltatori di fronte ad un bivio: “…. di fronte a questa ingiustizia io nero potrei scegliere tra la violenza e la disobbedienza civile” e conclude: “pregate che scelga la seconda.” Insomma provocate emozioni, sono quelle che vengono ricordate, generate immagini mentali forti; non siate melodrammatici per non cadere nel ridicolo ma non dimenticate che la razionalità è un’illusione creata dagli uomini. Il processo decisionale è prevalentemente istintivo.
Qualche consiglio pratico Sarebbe stato forse troppo altisonante chiamare questo paragrafo: strategie e tattiche. Molte cose in un match di Debate si definiscono nel mentre accadono, troppe sono le variabili in gioco, impossibi-le prevederle tutte ma qualche consiglio pratico potrebbe permettervi di evitare passi falsi e figurac-ce. L’ordine di presentazione è solo casuale.
Non attaccate mai in modo diretto e personale i vostri avversari; i giudici vi considererebbe-ro scorretto e non è escluso che possiate essere sanzionato formalmente. Insomma una frase del tipo: “Capisco che essendo il signor……… nato in una famiglia più che benestante, fac-cia fatica a comprendere i problemi di chi non ha avuto tale fortuna” sarà da evitare assolu-tamente. La regola in questi casi è sempre quella dell’under statement.
Salvo casi eccezionali, non improvvisate o andate “a braccio”, il pubblico e i giudici se ne
accorgerebbero immediatamente; rispettate sempre e nei limiti del possibile quanto era stato programmato nelle fasi di preparazione. Ricordate inoltre che tutti i membri della squadra, devono essere ben consci di cosa diranno gli altri per evitare sovrapposizioni e ripetizioni.
Usate dei cartellini per ricordare la corretta sequenza
degli argomenti e per non dimenticare nulla, ma non leggete direttamente. Il vostro tono di voce cambiereb-be in peggio, inoltre perdereste quel contatto visivo che è importantissimo conservare con giudici e pubblico.
Fate una attenta ricerca sul vostro argomento; il modo
migliore per schiacciare una confutazione è una ricerca ben documentata. Se state sostenendo che la maggior parte della pasticceria industriale non è certo benefica per la salute, sarà facile per voi spiegare ciò che dozzine di medici e di ricer-che dicono sull’olio di palma presente nella maggioranza dei biscotti. Confutare questo fat-to sarà molto difficile.
I soli fatti non bastano; basare uno speech solo su dati, numeri e statistiche è l’elemento fon-
damentale per la costruzione della noia. Dati concreti vi serviranno certo, ma ricordate che come una buona pietanza, dovranno anche essere ben presentati. D’altro canto non citare le fonti dei vostri dati o non documentare le vostre affermazioni può portare a pesanti confuta-zione dai vostri avversari. Insomma dovrete, come un bravo equilibrista, trovare la sintesi tra precisione delle informazioni e gradimento della comunicazione ……... e non è facile.
Usate il senso dell’umorismo con delicatezza ma usatelo; servirà per creare un clima miglio-re con chi vi ascolta e alleggerirà l’ascolto di argomenti alquanto pesanti a volte. Se ne siete sprovvisti non provateci neppure, i risultati sarebbero imbarazzanti, in ogni caso non esage-

58
rate. Chi vi ascolta potrebbe giudicarvi poco serio o pensare che stiate svalutando la serietà dell’argomento in questione.
Quando l’argomento che state trattando rischia di sembrare astratto oppure è lontano
dall’esperienza di chi vi ascolta dovrete farvi aiutare dagli esempi o dalle metafore e, per non cadere in evidente contraddizione, facciamo un esempio. Immaginiamo che la risolu-zione introduttiva sia: “Si conviene che la nostra società deve funzionare in modo pret-tamente meritocratico”, voi potrete citare esempi esteri di università americane e inglesi dove i docenti vengono scelti tramite annunci sui giornali e dopo aver valutato pubblicazioni e curricula e non grazie a parentele o coperture politiche. Potrete menzionare libri famosi come quello di Roger Abravanel intitolato proprio “Meritocrazia”, ma in fondo continuere-ste ad essere teorico e forse lontano dai vissuti di chi vi ascolta, a meno che non ricorriate ad una metafora: “Signori giudici e signori del pubblico, tutti parliamo o sentiamo parlare di meritocrazia, ma in fondo e concretamente di cosa si tratta? La meritocrazia in una società corrisponde alle regole del gioco; queste sono conosciute da tutti e ciascuno sa che rispet-tandole o meno potrà ottenere risultati o, di contro, non avere nulla. Chi giocherebbe ad un gioco senza regole?” o meglio ancora ad un esempio: “Immaginate che vostro figlio o vo-stra figlia vi raccontino con grande rabbia che nell’azienda dove lavorano, sono stati sca-valcati per una promozione che sapevano di meritare, da una persona raccomandata ma immeritevole. Cosa provereste?”
Ricordate l’accorgimento di lasciare qualche secondo di pausa, dopo aver posto domande al
pubblico, affinché ciascuno possa darsi una risposta.
In genere sappiate che la metafora ha un forte potere evocativo e rimane impressa molto più dei fiumi di parole che a volte servono per spiegare un concetto. Pensa-te a quante definizioni, descrizione, cita-zioni dovreste adoperare per spiegare il concetto di disciplina nelle organizza-zioni e guardate invece quanto è sinteti-ca e chiara la metafora della stufa di McGregor. Le fonti di metafore varie non scarseggiano certo, ma non esitate a mettere in campo la vostra fantasia per inventarne di nuove. Il risultato è note-vole.
Fate molta pratica, ripetete il vostro discorso nella mente fino ad affinarlo e fino a quando
non diventi naturale e spontaneo; questo accorgimento vi permetterà anche di essere consa-pevoli dei vincoli di tempo. Non farà una buona impressione con i giudici “sforare” con il tempo; d’altro canto il moderatore probabilmente vi bloccherebbe rendendo impossibile la vostra conclusione. Pessima impressione darà anche terminare quando se ne ha ancora a di-sposizione; il buon utilizzo del tempo disponibile avverrà con la pratica e con tante, tante prove.
Qualsiasi argomentazione dei vostri avversari che non avrete confutato resterà integra nella
mente di chi ascolta, costui darà per scontato che doveva trattarsi della verità, giacché ap-punto non siete stato in grado di confutarla. Allo stesso modo, qualsiasi confutazione da

59
parte dei vostri avversari che non riuscirete a superare, verrà accettata per buona e svaluterà la vostra argomentazione.
Normalmente nella mente di chi ascolta le parti di un discorso che rimangono più impresse
sono la parte introduttiva e la parte conclusiva; per tale motivo non solo dovrete strutturare i vostri speech tenendo conto di questo fatto, ma in più sarà preferibile che (se la squadra è composta come di regola da tre debater) come primo oratore e più che altro come ultimo, vengano messi i migliori.
Infine ma non ultima, ricordate la regola che vincere è importante ma non è tutto. Giocate con dignità ed etica, non ricorrete a mezzi subdoli finireste per tradire lo spirito stesso del Debate.
Le fallacie logiche Immaginiamo una situazione abbastanza tipica: proviamo ad esprimere anche in forma soft una piccola critica ad una persona o al/alla nostra partner quale ad esempio: “Sai che quel vestito non ti sta granché be-ne?”, può esserci accaduto di sentirci rispondere: “Ma ti sei guardato/a allo specchio? Non è che il tuo ti stia molto meglio”
Ecco! Siamo incappati in una fallacia logica. Il perché è semplice da comprendere; può anche darsi che l’abito di chi ha espresso la prima critica sia davvero pes-simo, ma questo fatto non inficia minimamente la sua prima asserzione. Insomma il fatto che il mio vestito sia brutto e mi stia male non può essere una spiegazione né può attenuare la critica portata al tuo vestito. Ma che cosa si prefigge un comportamento siffatto? Semplice, se invece di avere una spiegazione anche secca: “A me piace come mi sta e non tengo conto dei giudizi altrui!!!” subisco una controaccusa, mi sentirò a mia volta tenuto a giustificarmi dimenticando la prima critica. Questo tipo di fallacia come molte altre che vedremo, ha il fine di confondere le acque, affinché chi la usa possa uscire indenne da un diverbio, …. senza aver discusso realmente dell’oggetto del con-tendere. Insomma si tratta di vere e proprie trappole mentali. Dobbiamo dunque conoscerle queste figure ambigue della comunicazione, in modo da poter-
cene difendere e poterle controbattere con efficacia. Il termine fallacia deriva dal latino “fallere” che significa ingannare. Il più delle volte tali ragiona-menti vengono costruiti ad hoc ed in modo tendenzioso da colui o coloro che li propongono, con l'intento di ingannare o anche persuadere l'interlocutore. Non si tratta di vere e proprie truffe, bensì di inganni logici nei quali non è difficile cadere, poiché appaiono verosimili e che danzano ambi-guamente sul confine tra onestà e disonestà. Un cliente che ha acquistato dei titoli e va nella sua banca a lamentare il fatto che il suo portafoglio ha perso il xx%, potrebbe sentirsi rispondere: “In realtà caro signore lei al momento non ha perso nulla poiché non ha venduto i suoi titoli. Finché questo non accadrà lei non monetizzerà la perdita e quindi le conviene tenersi i suoi titoli e aspettare tempi migliori.”
La fallacia logica; una trappola per la mente

60
Questa giustificazione tipica tra i bancari per calmare i clienti arrabbiati è decisamente fallace ovve-ro ingannevole, poiché le perdite non sono mai recuperabili giacché il tempo non torna indietro, ma ha rimandato a casa molti clienti tranquillizzati e ingannati….. Poiché potrebbero esservi diverse interpretazioni useremo il termine “fallacia” per quelle argomen-tazioni che, appaiono convincenti ma che in realtà non sono valide. Eh già, perché il tutto si gioca sul filo dell’ambiguità, infatti in logica un ragionamento può essere vero (le proposizioni con cui si enunciano gli argomenti sono vere) ma non valido (manca il legame tra premesse e conclusioni).
I vari tipi di fallacia logica Per capire meglio iniziamo ad esaminare la prima fallacia logica, essa ha un affascinante nome lati-no, come molte altre d'altronde: Post hoc ergo propter hoc (poiché è accaduto in concomitanza con questo evento, deriva dall'evento stesso); la fallacia consiste nel sostenere che una relazione tra due eventi – reale o percepita – sia necessariamente di tipo causale. Ho fuso il motore dell’auto mentre andavo in montagna, quindi è stato a causa di questo evento che è accaduto il danno alla mia auto. Ma ne siamo certi? Abbiamo fatto il cambio olio? C’era acqua nel radiatore? La guarnizione della testata poteva già essere dan-neggiata? Un politico come Salvini nelle sue periodiche uscite fa emergere che l'immigrazione clandestina è in notevole aumento (vero) che nel Paese vi sono forti problemi occupazionali (vero) e che quindi bloccando l'immigrazione si risolverebbero i problemi derivanti dalla disoccupazione (invalido). In-fatti vi sono due presupposti veri, ma niente nel ragionamento prova che siano legati logicamente alla conclusione. Tempo fa un’amica in totale buona fede mi raccontava di essere sopravvissuta ad un tremendo inci-dente d’auto insieme al fratello …. perché al mattino era stata in chiesa a pregare. “Capii che era stato Dio a salvarci”. Fallacia di composizione (fallacia compositionis): consiste nell’attribuire erroneamente la qualità complessiva di un oggetto alla buona qualità dei suoi singoli componenti. Se in una ricetta metti buoni ingredienti non potrà che venire una buona pietanza. È evidente che la buona qualità degli ingredienti sia importante, ma sostenere quanto appena detto significa che elementi come: proporzioni, abbinamento degli ingredienti, tempi e modi di cottura non abbiano alcuna importanza nella preparazione di una pietanza, o che mescolando casualmente ingredienti di buona qualità ma incompatibili da un punto di vista organolettico si ottengano buone preparazioni. A tal punti provate a mescolare dell’ottimo paté di fegato con dell’ottimo cioccolato belga e fatemi sapere. In ambito lavorativo chiunque abbia lavorato in un gruppo sa perfettamente che se mettete insieme un sacco di ottimi elementi non è detto in alcun modo che ne esca un ottimo gruppo e immagino che qualcosa di simile accada in una squadra di un qualunque sport come il calcio o il basket. La fallacia induttiva la riscontriamo quando si sostiene che da un particolare derivi sempre una conseguenza generale (ricordiamo dai vecchi studi di filosofia che un ragionamento induttivo è quello che prende spunto da un particolare per arrivare al generale) insomma che ciò che è vero in alcuni casi è vero in ogni caso. Il freddo deteriora le batterie delle auto quindi d’estate non vi sono rischi che una batteria si scarichi. Chiedetelo al vostro elettrauto e poi controllate per quanto tempo

61
ride. D’altronde è la fallacia preferita da mogli e compagne per rafforzare le proprie critiche. Non è il caso di farti cucinare; ieri per fare il caffè hai sporcato tutta la cucina. La petitio principii o circolarità semplice avviene quando già in partenza assumiamo come vero quanto intendiamo dimostrare. Viene detta "circolare" poiché tra le premesse dell’argomentazione figura la tesi che si vuole sostenere. Dio ha creato il mondo quindi è evidente che Dio esiste. Noi dovremmo dimostrare che Dio esista e per farlo, nella premessa ne diamo per scontata l’esistenza in quanto creatore del mondo. Naturalmente funziona anche al contrario. L’argomento fantoccio o falso scopo viene adoperato per negare una tesi senza affrontarla diretta-mente; a tal fine si costruisce una tesi apparentemente simile a quella che stiamo discutendo e poi la si controbatte dando l’impressione di aver controbattuto la tesi di partenza. Ad esempio se la tesi da confutare è: l’attività fisica periodica fa bene, si potrebbe creare il seguente argomento fantoccio: Jimmy Fixx, il padre del jogging sosteneva che l’attività da lui tanto sostenuta facesse bene a tutti e morì d’infarto mentre correva. Come possiamo dunque pensare che l’attività fisica faccia bene? In realtà l’argomento fantoccio è vero ma non è la tesi di partenza, anche se vi è una certa vicinanza logica. Riuscendo facilmente a controbattere l’argomento creato ad arte, si può dare l’impressione di aver superato la tesi di partenza, ma non è ciò che abbiamo fatto in realtà. In effetti abbiamo solo fatto una specie di gioco di prestigio, facendo scomparire la veri tesi per sostituirla con una falsa. In questa modalità è presente anche una seconda fallacia ovvero…… La fallacia dell'evidenza soppressa infatti chi ha adoperato la fallacia precedente non sa o ha volu-tamente omesso di dire che il povero Jimmy Fix in un check-up cardiologico, fu valutato “ad alto rischio” per ipertensione, cuore ingrossato, alto colesterolo, sovrappeso e arteriosclerosi; il fatto che avesse mutato la sua vita con il jogging aveva solo rimandato le conseguenze di questi fattori di ri-schio.16 In questo caso colui che propone una tesi, tace una premessa nascosta, poiché se le infor-mazioni taciute emergessero, disconfermerebbero completamente la conclusione L’affermazione del conseguente o vero conseguente in cui assumendo come verità una conseguen-za ne si fa derivare da essa l’assunto stesso. Quando Marco ha un incontro di lavoro mette sempre il suo doppiopetto grigio; ha il vestito grigio? Allora deve avere un incontro di lavoro. Conclusione invalida perché Marco potrebbe essere vestito così per diversi altri motivi, che non siano l’incontro di lavoro. Il grande Indro Montanelli sosteneva che chi ha carattere ha un brutto carattere; probabile nel senso che non è accondiscendente e facile al compromesso, ma ciò non significa che chi ha un attivo carattere abbia carattere, potrebbe essere solo aggressivo o maleducato. La falsa dicotomia è più frequente di quanto non si creda e di regola inizia con la classica frase: i casi sono due ….. in pratica si suppone erroneamente che fra diverse alternative ve ne sia una vera oppure che le alternative presentate siano le uniche possibili. Quindi la dicotomia viene considerata un assunto logico mentre non lo è affatto. Qui i casi sono due caro Rossi: o lei è molto discreto su quello che accade in questo ufficio o è un cattivo impiegato. Qui la falsità è evidente perché si può essere un ottimo impiegato ed essere indiscreto o al contrario essere muto come una tomba e una vera palla al piede come impiegato. L’argomentazione a catena o la brutta china la incontreremo quando la conclusione di un'argomen-tazione si basa su una possibile ma non certa sequenza di eventi concatenati. Se ad un adolescente 16
La dottoressa McQuillen che eseguì l’autopsia disse: “Non credo che sia stato il jogging a causare la sua morte, credo piuttosto che il jogging lo abbia aiutato a prolungare di parecchi anni la vita a sua disposizione, drasticamente segnata dai danni causati dalle pessime abitudini di vita dei suoi primi trentacinque anni”. Vedi per approfondimenti il link

62
compri lo smartphone, dopo un po’ vorrà il motorino, fare tardi alla sera, la macchina e chissà cos’altro. Questa modalità è stata adoperata da sempre da chi è contrario alla legalizzazione delle droghe leg-gere e motiva la sua posizione con l’asserzione che si inizia con la marijuana per poi finire alla co-caina. La qual cosa è possibile ma non logicamente correlata, poiché ci sono tanti che restano con-sumatori di droghe leggere senza mai passare a quelle pesanti e altri che entrano nel mondo degli stupefacenti direttamente usando coca o ecstasy. Insomma l’argomentazione a catena è la preferita di quei catastrofisti che iniziano i loro discorsi dicendo: di questo passo so bene dove andremo a fi-nire! L’argumentum ad hominem si ha quando si fa riferimento non all’oggetto del contendere, ma ad una o più caratteristiche di chi lo sostiene. Nella saggezza popolare è presente un modo di dire che può farsi risalire a tale fallacia (a dimostrazione che poi non è vero che i proverbi sono la saggezza dei popoli). Mi riferisco al detto: il bue che da del cornuto all’asino. In pratica si sosterrebbe che stante il suo essere naturalmente dotato di corna, il bue non può criticare nessun altro in questo campo. La fallacia logica è evidente: il bue sarà certamente cornuto, ma questo non esclude che la sua af-fermazione circa l’asino possa essere vera. Esistono vari tipi di argumentum ad hominem: la disconferma individuale ad esempio si ha quando invece di confutare l'argomentazione, si at-tacca l’avversario per sue caratteristiche quali l'età, la famiglia, le tendenze sessuali, l'etnia, lo status sociale ed economico, gli studi praticati, l'aspetto esteriore (abbigliamento tipico, struttura fisica, ecc.), l’idologia politica. Da piccoli ci saremo sentiti dire tante volte: cosa vuoi capirne tu che sei un ragazzino? Il non detto appare evidente: ciò che l’altro dice non è credibile proprio per le caratte-ristiche predette. Capisco l’ostilità del signor xxxyyy a proposito di nuovi fondi alle università pubbliche; d’altro canto lui è stato mantenuto in una famosa università privata dalla sua ricca famiglia. Non essendo in grado di contestare nei contenuti quanto detto da xxxyyy cerco di svalutare lui. Una ulteriore variante prende il nome simbolico di avvelenamento del pozzo; la similitudine è ben chiara. Poiché il pozzo è avvelenato tutto ciò che ne proviene deve essere rifiutato. Il New York Times scopre che Donald Trump per ben cinque volte ha evitato con alcuni escamotage il servizio militare. La domanda implicita è: “Elettori, vi fidereste di avere come Presi-dente degli Stati Uniti (e quindi comandante in capo delle Forze Armate) uno che con artifici ha evitato il servizio militare? Ma si otterrà un fine simile contestando sempre non la tesi dell’avversario ma le sue frequentazioni (fallacia per associazione o ad hominem indiretto) o i suoi eventuali interessi. Si pensi che in Italia per anni non si è potuto seriamente discutere della riforma della giustizia perché le proposte di una parte (quelle provenienti dal partito di Berlusconi), non venivano prese in considerazione poi-ché si davano per scontati (e probabilmente era vero) gli interessi personali del capo di quel partito. La falsa autorità, consiste nell’appellarsi ad una ipotetica fonte autorevole ma non ben definita per sostenere la propria tesi. Conosco più di un medico che sostiene che la marijuana fa meno male del tabacco. L’aneddotica la ascoltiamo molto spesso nei discorsi di tutti giorni ovvero quando citiamo o sen-tiamo citare un aneddoto o un singolo caso per sostenere o confutare una tesi, quasi che un singolo episodio, pur se vero possa confermare una teoria. Un mio vecchio zio fumava, mangiava carne due volte al giorno e beveva un litro di vino ed è vissuto fino ai 90 anni.

63
Come difendersi Se riduciamo all’essenziale il concetto di fallacia logica, vedremo una costante che torna: chi le a-dopera se ne serve per non rispondere all’argomentazione e distrarre l’avversario con una manovra diversiva. A tal punto non sarà difficile confutare la fallacia sottolineando appunto il tentativo di in-ganno. Il mio avversario non ha dimostrato la scorret-tezza dell’assunto che l’attività fisica faccia bene; ha solo narrato un episodio negativo mentre doz-zine di ricerche sostengono la nostra argomenta-zione. È vero, probabilmente il signor xxxyyy ha inte-ressi personali in questa situazione ma noi dob-biamo valutare la validità della proposta di legge e non gli interessi di xxxyyy. Il vero problema dunque non è controbatterle bensì riconoscerle immediatamente; esse infatti sono così radicate nel parlare comune (anche nel nostro, ammettiamolo) che spesso passano completa-mente inosservate. Lasciando però tracce nei giudizi di chi le ascolta. Una tattica che potremo usare sia in caso di fallacie logiche, che in genere nel Debate, ci proviene da questo aneddoto. Si racconta che il giovane Vittorio Alfieri poco prima di entrare nel collegio nel quale avrebbe stu-diato per un problema di salute dovette essere rasato a zero; il suo timore era quello di divenire lo zimbello dei compagni di studio che prima o poi, quando si fossero tutti tolte le parrucche che all’epoca usavano, si sarebbero accorti della sua disavventura. A tal punto escogitò una particolare tattica: alla prima ricreazione in cortile, si tolse la parrucca e iniziò a giocarci usandola come una palla. Pare che un compagno la raccolse, la spolverò e gliela porse senza alcun commento. La morale è che se sappiamo che le nostre argomentazioni possono avere un punto debole che l’avversario attaccherà, parliamone noi per primi. Potremo gestirle e l’avversario non potrà più u-sarle.

64
Utilizzi del Debate nel mondo del lavoro
Nelle prime pagine di questo libro abbiamo accennato al fatto che i naturali utilizzatori del Debate siano gli studenti, naturalmente quelli delle scuole superiori fino ad arrivare agli studenti universitari. Altro naturale ambito è chiaramente quel-lo della politica; si pensi a quanto sarebbe efficace, nelle scuole di formazione di partito o del sindacato, addestrare i futuri quadri a questa forma di dibattito che, come detto, non solo è un vero e proprio sport della mente e della parola ma è la sublimazione del dialogo democratico. Quanto detto però, non esclude che questa disciplina possa avere un ruolo sempre più importante anche nel mondo del lavoro. Non posseggo le competenze per appro-fondire gli utilizzi scolastici e politici del Debate, ma alcuni decenni di vita in azienda, come dipen-dente e come consulente, mi permettono di esplorare quest’ambito. In quali settori della vita aziendale questa disciplina può dare, e in alcune realtà sta già dando, un efficace contributo?
Nella “comunicazione aziendale interna” laddove con tale definizione si intende quella comu-nicazione rivolta a quelli che oggi si definiscono “stakeholder”, più precisamente dipendenti, sindacati, fornitori e che mira a diffondere e condividere la missione aziendale (perché esistiamo come azienda), la visione (cosa vogliamo rappresentare) e i valori cui si ispira per realizzare i due punti predetti.
Nella formazione, non come oggetto formativo ma come metodologia didattica, da usare anche
fuori dalla classica aula, anzi, meglio fuori dall’aula per sperimentare competenze quali il public speaking, la persuasione, l’ascolto e tante altre ancora.
Nell’advocacy, ovvero in quella capacità richiesta sempre più oggigiorno ai dipendenti, di rap-
presentare, sostenere e difendere l’immagine aziendale.
Il Debate nella comunicazione aziendale interna Si parta dall’assunto che un’azienda “è come comunica” e in questo aspetto essa non si differenzia di molto da una famiglia, da un gruppo di amici, da un partito. Se la comunicazione è vera, fluida, efficace il gruppo funzionerà bene, diversamente avverranno una serie di incomprensioni e ineffi-cienze che metteranno a rischio le performance, il clima interno e, in tempi lunghi la vita stessa dell’Organizzazione. Di contro sarà evidente che in gruppo disfunzionale la comunicazione è sca-dente, rara, inappropriata. Non a caso il primo sintomo di crisi di coppia spesso è proprio nella difficoltà di comunicazione.

65
Quindi non è esagerato sostenere che la comunicazione interna è l’ossigeno che l’azienda respira, ed in quanto tale è assolutamente vitale. Un’organizzazione che dialoga con i suoi dipendenti trasmette un messaggio chiaro: mi interessa parlare con voi, attribuisco peso alle vostre opinioni, voglio comprendere le vostre attese e, più che altro, voglio che camminiamo insieme verso obiettivi condivisi. Un comportamento siffatto migliora certamente il clima interno; quest’ultimo a sua volta, agisce sulla motivazione che è la principale alimentazione delle performance. Esistono più tipi di comunicazione interna,
la comunicazione commerciale che ha come destinatari i clienti e mira evidentemente a so-stenere e incrementare il fatturato e le vendite. Oggi in realtà, con l’utilizzo sempre più sofi-sticato dei social, dei gruppi di progettazione, dei lead users, dovremmo sostituire la parola destinatari con il termine più adeguato di interlocutori giacché il Web2 permette una reale contribuzione dei clienti ad alcuni processi aziendali,
la comunicazione finanziaria che, narrando la vita economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa trasferisce un’immagine di solidità e affidabilità presso gli investitori,
la comunicazione organizzativa che agisce all’interno dell’impresa, tra dipendenti, uffici, reparti e, grazie ai suoi scambi, permette all’organizzazione di funzionare.
la comunicazione culturale che mira a definire, diffondere e consolidare i valori ai quali l’impresa si ispira per raggiungere i proprio obiettivi. È la comunicazione che racconta come ci comportiamo tra noi, cosa è bene e cosa è male, come vorremmo essere percepiti dall’esterno.
I modi e gli strumenti tramite i quali l’organizzazione comunicherà al suo interno, sono diversi per efficacia e coinvolgimento delle persone come pure per efficienza e distacco dalle persone stesse; si andrà da una mail spedita ai dipendenti che sarà economica, efficiente, fredda e poco efficace, al colloquio a due che di contro sarà dispendioso in termini di tempo, efficace, coinvolgente ma poco efficiente. Tra questi due estremi troveremo le circolari e gli ordini di servizio, le mail personalizzate, le riu-nioni istituzionali e quelle in piccoli gruppi. Non dimentichiamo, laddove esistano, intranet azienda-le, newsgroup, bacheche (ormai solo elettroniche), house-organ. A tutto ciò viene dato il nome di comunicazione formale. Parallela alla comunicazione formale ma difficilmente misurabile, esiste anche la comunicazione informale; essa ha fini prettamente relazionali in quanto per suo tramite si creano amicizie, gruppi di interesse, alleanze, reti di relazioni. Nei momenti di tale comunicazione girano informazioni di-verse da quelle veicolate dalla comunicazione formale; nelle chiacchiere alla macchina del caffè, a mensa, tra colleghi, si potranno percepire i dubbi, le ansie, le attese il vero sentire dei dipendenti. Esiste una regola non scritta ma sulla quale sarà opportuno riflettere: tanto più debole e inefficace sarà la comunicazione formale, tanto più invadente e pervasiva sarà la comunicazione informale. In che modo dunque si potrà usare il Debate come strumento di comunicazione interna? Basterà ricordare che tale comunicazione opera all’interno di una strategia determinante nell’impresa ovvero la strategia di marketing e, più propriamente, il marketing interno. Quest’ultimo si prefigge di gestire e orientare gli atteggiamenti dei dipendenti, ad esempio verso i clienti, nei confronti dei prodotti o servizi venduti dall’impresa, verso il disegno organizzativo a-ziendale. Il marketing interno si enfatizza quando si voglia creare una nuova cultura del servizio, nelle cam-pagne promozionali di nuovi prodotti, quando si stia modificando il sistema premiante, ecc.

66
Tutto ciò discende da un assioma: i dipendenti sono il primo mercato dell’impresa e se un prodotto o un’idea non vengono ben venduti prima all’interno, raramente potranno essere venduti all’esterno. Prima di ipotizzare gli usi del Debate nella comunicazione interna, ricordiamo che esso è già stato sperimentato da chi scrive, in aziende di significative dimensioni e con un’organizzazione struttura-ta, il tutto con un notevole gradimento circa lo strumento, la sua flessibilità e i suoi possibili risulta-ti.
Progetti strategici Si pensi dunque ad un’azienda che voglia implementare il CRM (Customer Relationship Management)17; potrà presentarlo nei modi consueti ma non è con tale comportamento che esaurirà la necessità di far assorbire una nuovo cultura del lavoro negli addetti. Si potrebbero organizzare dunque dei match di Debate che abbiano come BIRT, ricordiamo questa sigla? Be it resolved that, (si assume che) assunti quali: L’utilizzo del CRM migliorerà la percezione di qualità dei nostri servizi da parte dei clienti oppure Il CRM incrementerà la condivisione e la diffusione delle informazioni Squadre di dipendenti di uffici e servizi diversi potranno scontrarsi su tali temi, dopo una opportuna preparazione; i giudici in questo caso potrebbero essere tutti i dipendenti dell’azienda che assiste-rebbero agli incontri per poi votare o, se possibile, fisicamente durante momenti dedicati, o veden-do i video dei match online. L’azienda potrebbe quindi non solo percepire realmente come le innovazioni proposte vengano ac-cettate e condivise dai collaboratori, ma potrebbe anche stimolare discussioni, sempre online, per avere suggerimenti, individuare eventuali aspetti dubbi, creare gruppi di miglioramento.
Le riunioni aziendali Le riunioni aziendali, per le quali si devono intendere quegli incontri di gruppi medio piccoli ovvero composti dalle tre alle dieci persone circa, aventi per oggetto un problema da risolvere, un progetto da implementare e poi seguire, una decisione da prendere in modo condiviso, sono la croce e la de-lizia della comunicazione interna, anche se più di uno sosterebbe trattarsi solo di croce senza alcuna delizia. La riunione in piccoli gruppi (da non confondere con quelle in grandi gruppi o eventi, nelle quali la comunicazione fluisce monodirezionalmente da un oratore agli ascoltatori) è certamente uno stru-mento abbastanza caldo anche se non caldissimo come l’incontro a due, pertanto possiamo sostene-re che si tratti di un metodo comunicativo importante e potenzialmente efficace. Allora perché spesso si esce dalle riunioni con una frustrante sensazione di inutilità, e più che altro di tempo perso? 17
Il CRM non è solo un sofisticato software relazionale ma è principalmente una filosofia di business, un'attitudine verso gli addetti ed i clienti, supportata dai processi e dai sistemi. Suo scopo è la costruzione di relazioni personalizzate di lungo periodo con il cliente, mediante la comprensione delle esigenze e delle preferenze del singolo, questo permette di costruire relazioni individuali con i singoli clienti, elevando in tal modo il più possibile il loro livello di soddisfazione e conseguentemente la loro lealtà all'azienda.

67
Il punto saliente è che una riunione funziona e quindi produce risultati, solo se i partecipanti sanno lavorare in gruppo e qui cade in modo fragoroso il famoso asino. Questo accade perché la modalità di lavoro in gruppo è qualcosa di a se stante, una sorta di lingua diversa con una propria grammatica e una particolare sintassi rispetto al consueto modo di lavorare. Se non si possiede questa nuova lingua, le riunioni spesso saranno defatiganti e inutili ovvero im-produttive. L’aspetto diabolico del problema è che quanto più la riunioni falliscono, tanto più nelle persone si radica l’idea che siano inutili; ciò le predispone in modo negativo innescando così un circolo vizio-so che alla fine ci farà dire: “L’ho sempre detto che le riunioni non servono a nulla…!” Altro aspetto determinante è che nei lavori di gruppo o nelle riunioni nelle quali si deve decidere per un’idea o una proposta spesso le persone fanno l’errore di badare più a come le cose vengono dette che al cosa viene detto, con la conseguenza grave che spesso si accettano o si rifiutano non tanto le idee quanto le persone che le portano. L’utilizzo delle tecniche di Debate in tali contesti potrebbe permettere notevoli benefici:
la valutazione guidata attraverso una griglia (Vedi allegato Griglia di valutazione dei deba-ters) quasi obbliga o comunque induce a esprimere un giudizio il più oggettivo possibile di quanto detto da una persona, chi dovrà esprimersi si chiederà se quanto detto sia stato rin-forzato da dati, fonti attendibili, precedenti concreti e la semplice antipatia o simpatia passe-rà in secondo ordine. Ciò potrebbe attenuare se non eliminare uno dei principali ostacoli del-le riunioni: la personalizzazione;
l’obbligo di dover parlare per un determinato numero di minuti obbligherà le persone ad es-sere sintetiche, si eviteranno così le perdite di tempo causate dai divagatori, dai prolissi, da coloro che amano il suono della propria voce;
il divieto di interrompere eviterà battibecchi e dispersioni di tempo e permetterà a ciascuno di esprimersi.
Insomma l’addestramento al Debate è una strada che porta ad un migliore lavoro di gruppo e a riu-nioni più brevi ma più efficaci. Apparentemente lo strumento del Debate in queste occasioni potrebbe apparire a dir poco perfetto! Economico, efficace, coinvolgente, cosa chiedere di più. Non ha dunque difetti? Uno c’è e non è marginale: come tutti gli strumenti della democrazia, lascia il potere ai singoli che a volte si fanno guidare più dagli istinti che da illuminate ragioni, come abbiamo di recente visto in situazioni politiche importanti quali Brexit ed elezione del Presidente degli Stati Uniti nel novembre 2016. Un’azienda o un’organizzazione sono disposte a cedere tale potere decisionale?

68
Il Debate nella formazione aziendale Partiamo da lontano; un’organizzazione alla stessa maniera di un organismo vivente deve apprende-re e deve farlo perché da come e quanto rapidamente apprenderà, dipenderà la sua stessa sopravvi-venza. Dimentichiamo quindi il dantesco “ricordate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtude e conoscenza”, bello, idealistico ma inappropriato. L’apprendimento è fun-zionale alla sopravvivenza; se l’organizzazione si chiama Kodak e non apprende che la fotografia digitale sta per cambiare completamente il mondo dell’immagine, rischierà la sopravvivenza propria e il benessere dei suoi membri, cosa in realtà accaduta. 18 In questo grande fiume che chiamiamo apprendimento organizzativo, la formazione si prefigge di generare apprendimenti all’interno dell’organizzazione per renderla sempre più adeguata alle prove ed alle sfide che l’ambiente esterno le pone. Ma cosa vuole dire apprendere? L’apprendimento si definisce come un cambiamento dei comportamenti, oggettivamente consta-tabile e relativamente permanente. Si tratta a ben vedere di una definizione molto comportamentista; in pratica si sostiene che se l’apprendere non è verificabile sulla base di comportamenti reali, i quali a loro volta dovranno esse-re oggettivamente visibili, allora….non possiamo neppure definirlo apprendimento. Opinabile ma comprensibile giacché in ambito aziendale ciò che interessa non è una generica sen-sibilizzazione cognitiva, ma una reale modifica dei comportamenti; fino ad ieri non usavi quel sof-tware, da domani devi imparare ad usarlo. Prima vendevi un certo prodotto ora ne venderai uno nuovo, ecc. Per riuscire in questo intento apparentemente facile ma all’atto pratico di non frequente realizzazio-ne, la formazione usa metodologie didattiche che spaziano da quelle classiche d’aula quali: docen-ze, esercitazioni, simulazioni, role-playing, a metodi più recenti quali la molto discussa FAD (for-mazione a distanza), studio di autocasi, testimonianze, tutorship, l’outodoor training e altro ancora. Per comprendere però per quale motivo il Debate potrebbe essere adoperato in formazione, dob-biamo accettare un assunto: indipendentemente da quanto appena scritto circa i metodi didattici l’apprendimento sarà direttamente proporzionale al coinvolgimento emotivo del discente. Non a caso la cosiddetta lezione frontale o docenza è la forma di didattica meno coinvolgente e quindi meno efficace, mentre i metodi attivi e, ancor di più, il training on the job ovvero l’apprendimento sul campo, stante il loro notevole coinvolgimento emotivo, generano gli appren-dimenti più duraturi ed efficaci. Ora si pensi ad un match nel quale la squadra affermativa debba sostenere tutti i motivi per acqui-stare un certo prodotto e quella negativa abbia il compito contrario. Non sarebbe più coinvolgente e perché no, divertente di una lezione sulle tecniche di vendita? Obbligherebbe i discenti a mettersi nei panni dei clienti per immaginare le obiezioni che farebbero ad un certo prodotto, li impegnereb-
18
Ricordiamo che la Kodak, pur avendo creato per prima una fotocamera digitale non comprese le potenzialità della sua stessa invenzione e nel 2012 il ramo fotografia della Eastman Kodak è finito in bancarotta; al momento l’azienda si limita alla produzione di stampanti e prodotti chimici

69
be nell’ascolto attivo dell’avversario per cogliere eventuali falle del suo ragionamento. Insomma accadrebbe in altra forma ciò che accade in ogni colloquio commerciale. Possiamo immaginare anche un corso di public speaking fatto in modalità totalmente esperienziale; niente più lezioni e teorie ma solo incontri di Debate su argomenti appropriati, una telecamera ri-prende i debaters e il docente potrà con l’aiuto del gruppo fare l’analisi di quanto accaduto eviden-ziando gli aspetti salienti della comunicazione verbale, della gesticolazione, della persuasività. Non ci sarà bisogno di teorie e lezioni sul tono di voce o l’utilizzo delle metafore; ci sarà il materiale che gli stessi discenti hanno creato che fornirà spunti di riflessione e possibili approfondimenti. Una eventuale docenza servirà dunque solo come sintesi conclusiva per concettualizzare le espe-rienze dei discenti. Abbiamo preso quali esempi, eventuali corsi sulla vendita piuttosto che sul public speaking, ma non sono da escludere altri contenuti formativi quali l’ascolto, la persuasione, il linguaggio del corpo. In ogni caso avremo un reale vantaggio didattico: non si discuterà di opinabili teorie che a volte i discenti potrebbero ritenere lontane dalla propria esperienze o inapplicabili nella realtà, bensì di qualcosa che i discenti hanno sperimentato e vissuto e quindi sentiranno come una parte di se stessi. Anche le conoscenze prevalentemente teoriche, ovvero basate sull’apprendimento di concetti, trar-ranno giovamento dall’uso del Debate. Immaginiamo uno dei più noiosi ma ahimè importanti ar-gomenti: la legge sulla sicurezza; con delle lezioni teoriche potremmo sostituire i più potenti degli anestetici, con la Formazione A Distanza indurremmo i discenti a “barare” e scambiarsi le risposte per fare prima, ma con dei match di Debate indurremmo le persone a studiare per poter competere e vincere. Tale discorso naturalmente potrà adattarsi a vari altri contenuti dall’uso di nuovi software gestionali all’introduzioni di nuove macchine in azienda. Anche in tal caso, come detto per la comunicazione interna sembrerebbe a prima vista possano es-serci solo aspetti positivi; il metodo è efficace, divertente, a costo zero. C’è un però: si tratta di una metodologia didattica che un formatore definirebbe “senza rete”. Le metodologie classiche sono prevedibili, i tempi programmabili in quanto consueti e dopo qual-che edizione di un corso, tutto scorre sui binari della normalita, ma questa non è una metodologia classica. Il formatore non sa quello che verrà fuori dai debaters, non può prepararsi e deve essere pronto ad individuare gli aspetti salienti di quanto emergerà dai partecipanti al gioco. Insomma il Debate come metodo didattico è consigliabile, a patto che il docente sia una persona non ansiosa e con una discreta esperienza d’aula.
Il Debate nell’Advocacy Alcuni anni fa in suo libro19 Fred Reichheld, considerato un esperto a livello mondiale della custo-mer loyalty, scriveva che se si volesse capire quanto i clienti siano fedeli ad una impresa, non oc-correrebbero complesse indagini o articolati questionari, ma sarebbe sufficiente una semplice do-manda, che egli definisce essenziale: “Tu consiglieresti la nostra azienda ad un tuo amico o pa-rente?”. Tale domanda essenziale sarà seguita da un’altra semplice e consequenziale domanda: “Puoi dirmi perché lo faresti o perché non la faresti?”.
19
Fred Reichheld. Buoni e cattivi profitti. Il cliente come promotore dell'impresa. Edizione ETAS 2006

70
Tutto qui. Coloro che a tale domanda daranno risposta positiva, potranno essere considerati “promoter” e in quanto tali, generatori di buoni profitti. Ci saranno quelli che daranno una risposta neutra; costoro non sono minacciosi ma certamente sono a rischio di abbandono, in quanto non si considerano in alcun modo legati al brand. Infine vi saranno coloro che risponderanno in modo negativo e che potremmo definire detrattori; costoro saranno un grosso problema per l’azienda, essi infatti diffonderanno il loro messaggio nega-tivo a quante più persone potranno.20 L’autore nella parte conclusiva del libro amplia il concetto di promoter, includendovi i dipendenti dell’impresa ai quali la domanda essenziale sarebbe posta in tal modo: “Tu consiglieresti ad un tuo amico o parente di lavorare nella nostra azienda?”. Ricordiamo che nel parlare di comunicazione interna abbiamo sostenuto che i primi promotori dell’azienda, del marchio, dei suoi prodotti, devo-no essere i dipendenti stessi in quanto sono stati i primi a “comprare” ovvero accettare prodotti, ser-vizi, messaggi della loro impresa. Questa è la chiave di lettura del concetto di advocacy o meglio di emplyee advocacy definendo in tal modo l’attitudine di segnalare, sostenere o raccomandare un marchio attraverso la propria credibilità verso terzi, siano essi amici, parenti o conoscenti. Non c’è bisogno di scomodare complesse analisi psicosociali per convenire che se una persona della quale mi fido mi racconta che nella sua azienda si sta bene, che le persone sono valorizzate, che i prodotti sono di qualità, quanto da lui o lei detto varrà per me molto più di uno spot pubblicitario. Se questo era condivisibile circa dieci anni fa quando Reichheld scriveva il suo libro, oggi in piena era Internet, la cosa assume aspetti impossibili da trascurare, infatti se c’è una cosa che la Rete ha agevolato esponenzialmente è la capacità di ingigantire e diffondere viralmente un messaggio pro-dotto da una persona, senza limiti di tempo né confini geografici, facendone parlare decine di mi-gliaia o a volte milioni di altre persone. E non conta quanto sia importante la persona dalla quale è nato il messaggio. Oggi uno sconosciuto cantante country può farsi ascoltare da milioni di persone e causare un danno di immagine immenso alla seconda compagnia aerea del mondo.21 Insomma oggi un’azienda, piccola o grande che sia, ha bisogno di “brand advocates” ovvero di per-sone che la sostengano, la difendano (come dei veri e propri avvocati del marchio) e può cercarli al suo esterno tra clienti e fornitori oppure al suo interno ovvero tra i suoi collaboratori. Per trasformare in brand advocates i propri clienti occorre una maniacale attenzione alla qualità del servizio, al recupero dei disservizi, ci vorranno investimenti in qualità del personale oltre, natural-mente nei tempi di WEB2, ad un grande impegno nella cura in rete della brand reputation; ma tutto ciò non è certo argomento di questo piccolo manuale. Riflettiamo invece su come trasformare in avvocati del marchio i dipendenti dell’azienda stessa.
20
Va ricordato che il passaparola negativo è molto più efficiente e rapido di quello positivo in quanto, se non è dato per scontato che un cliente soddisfatto parli bene dell’azienda, a meno che l’esperienza positiva non sia particolare, è certo che un cliente insoddisfatto parli della propria esperienza negativa a circa dieci persone, per compensare il suo desiderio di rivalsa. 21
Si cerchi in rete il caso di Dave Carroll che durante un volo nazionale ha subito un danno ad una sua chitarra di $ 3.500 con conseguente cattiva gestione della richiesta di risarcimento; egli non ha fatto causa alla compagnia ma ha messo in rete un video virale visto da circa 3.600.000 persone ed ha causato un danno di immagine da $ 180.000.000 alla United.

71
I dipendenti possono essere visti come un canale per trasmettere all’esterno il brand aziendale sia in modo propositivo sia, come ahimè accade in certi settori, in modo difensivo quando la visibilità di marchio è minacciata. Se può non apparire chiaro questo secondo utilizzo, si pensi alla situazione vissuta da certi marchi in alcuni momenti storici non proprio gratificanti. Facciamo qualche esempio: chi non ricorda il momento negativo di un marchio “alto” quale Merce-des in occasione della Classe A che cappotta alla “prova dell’alce”? ovvero a seguito di una sterzata improvvisa 22 . E che dire dello scandalo delle emissioni truccate di Volkswagen che costerà all’azienda miliardi di dollari mentre il danno di immagine non è quantificabile ma sarà sicuramente immenso tanto che il CEO del gruppo, Martin Winterkorn, si è detto "profondamente dispiaciuto per aver infranto la fiducia dei nostri clienti e del pubblico…” per poi dimettersi. E cosa dire ancora del disastro degli smartphone Galaxy Note 7? 2.500.000 di unità vendute in po-chi giorni e frettolosamente richiamate ritirate dal mercato, quindi la resa totale con l’interruzione completa della vendita. Cosa ne sarà della fiducia dei consumatori nel marchio? Per restare in situazioni più vicine a casa, si immagini cosa può accadere oggi, quando in un gruppo di nuovi conoscenti si inizino discorsi del tipo “e tu che lavoro fai?”. Se tra queste persone vi sarà un bancario è possibile che racconterà una bugia, pur di non dire che lavora in una odiosissima e chiacchierata banca. Chiunque operi in settori delicati e strategici quali la Sanità, alcuni rami della P.A. (immaginate co-sa significa essere un dipendente di Equitalia?), una compagnia di assicurazioni, ha provato la sgradevole esperienza di essere attaccato anche in momenti non lavorativi. In casi come quelli appena detti, potrebbe giovare un buon addestramento al Debate, insomma esse-re allenati a individuare rapidamente la risposta adeguata che consenta di dire in una discussione una frase del tipo: “è vero il nostro telefono Note che brucia è certamente un grosso problema che stiamo affrontando seriamente, ma tu sei preoccupato di essere colpito da un fulmine? Lo sai che in 80 anni hai una possibilità su 13.000 di essere colpito; i nostri telefoni difettosi sono stati 1 su 25.000.” Oppure reagire garbatamente alla classica frase che inizia “con…voi medici o voi infermieri… non capite i problemi dei pazienti” “Certo capisco che si resti colpiti dalle notizie negative e che quelle positive neppure vengono cita-te, ma la sanità bolognese risulta prima in Italia per qualità del servizio, le liste di attesa sono state abbattute e sono stati stanziati 150 milioni di euro per rinnovare le strutture”. Capacità di ascolto attivo ed analitico, conoscenza approfondita del fenomeno e prontezza nell’individuare il punto debole nell’assunto dell’avversario; sono queste le doti che sviluppa il De-bate e che lo rendono, come detto nella parte iniziale del manuale, il judo dell’intelletto. L’azienda dovrebbe dunque far si che la maggior parte dei propri dipendenti si impegni per dare vi-sibilità al proprio posto di lavoro, che difenda la propria organizzazione quando necessario dalle cri-tiche di chi non la conosce ma anche dalle critiche interne. Insomma il dipendente che ricopre que-sto ruolo ideale deve essere un vero e proprio advocate, sia online con la sua presenza social sia nel mondo reale con la propria credibilità e le proprie doti comunicative.
22
Dal 1998 il colosso di Stoccarda affrontò spese per oltre 150 miliardi di marchi per correggere quel difetto senza cal-colare il danno di immagine.

72
Per riuscire in questo intento bisogna generare una situazione di “employee engagement”, ma cosa intendiamo con questo ennesimo termine inglese? Una definizione ce la da l’autorevole movimento britannico Engage for Success: “L’employee engagement è un processo di management che consente ai dipendenti di essere coinvolti nel rispetto dei valori e nella realizzazione degli obiettivi, motivati nel contribuire al successo dell’organizzazione e capaci al tempo stesso di aumentare il proprio benessere.” Perchè nasca l’engagement (letteralmente fidanzamento ma anche e certamente in questo caso, im-pegno) nei dipendenti, l’azienda deve verificare che vi sia una sorta di parallelismo tra i valori dei dipendenti, la cultura aziendale e le reali esperienze nell’ambiente lavorativo, dovrà valorizzare la meritocrazia giacché quando i collaboratori si sentono correttamente valorizzati per loro impegno, saranno naturalmente portati a condividere positivamente la propria esperienza lavorativa. A queste condizioni imprescindibili si potrà naturalmente aggiungere una formazione atta a difende-re un punto di vista, a delegittimarne uno opposto, a sostenere, contestare , difendere attraverso ap-punto le competenze tipiche del Debate. Si pensi dunque ad un’azienda che organizzi una sorta di torneo dopolavoristico, dove squadre di dipendenti competano non in incontri di calcetto o di basket, ma dove i match vertano su temi ine-renti i valori che l’azienda vuole rappresentare, sulle iniziative commerciali, su eventuali cambia-menti organizzativi. Prendendo dalla carta dei valori di alcuni grandi gruppi, immaginate alcuni match di Debate cha ab-biano come BIRT (Be It Resolved That):
Essere accessibili ai nostri clienti e fornitori aumenta la nostra efficacia organizzativa. (dalla carta dei valori di Gruppo Unipol)
Solo con la partecipazione di tutti si può generare vera innovazione (dalla carta dei va-
lori di Gruppo Brunelli) L’utilizzo del tempo di lavoro che deve essere compatibile con le esigenze della vita
privata (dalla carta dei valori di Buzzi Unicem) Ma pensiamo anche a situazioni negative o, come definite nel marketing, di qualità difensiva tipo:
La fiducia nella nostra banca si può ricostruire cambiando il tipo di relazione con il Cliente.
Ecco quindi che una disciplina antica, nata nelle scuole di dialettica e retorica oltre duemila anni fa, ritorna oggi alla nostra attenzione a seguito di quella caratteristica altamente pervasiva che ha ormai assunto la comunicazione umana. Ciò che ieri era riservato ad una elite oggi si rivolge ai tanti che costituiscono il villaggio globale.

73
E adesso? L’obiettivo di questo manuale non era certo esaurire i contenuti relativi alle competenze che servo-no nel Debate; come detto nella parte introduttiva parliamo di una disciplina complessa che al suo interno comprende a sua volta competenze complesse, per cui possiamo dire di aver appena intra-preso il cammino che ci attende. Ma per proseguire cosa dobbiamo fare ora? A questo punto per chi volesse intraprendere la strada del Debate, si para davanti un importane bi-vio: incuriositi dall’uno o dall’altro dei vari argomenti incontrati finora potreste decidere di appro-fondirli con letture e ulteriori studi oppure potreste voler prendere la strada della pratica e iniziare a fare esperienza. Non mi sento i caldeggiare l’una strada a vantaggio dell’altra ma di una cosa sono certo: se ne sce-gliete una poco male, ma non dimenticate di tornare regolarmente sull’altra. Provo a spiegarmi meglio.
Come apprendiamo Ciascuno di noi ha un suo personale approccio all’apprendimento; ci sono quelli che preferiscono sperimentare e apprendere in un modo che viene definito “per tentativi ed errori”, altri amano prima osservare quelli più esperti e poi imitarli. È il metodo tipico della tutorship e con nome meno esoti-co lo si è praticato per secoli nelle botteghe degli artigiani di tutto il mondo.
Un modo abbastanza semplice per cono-scere nel dettaglio il proprio modo di ap-prendere consiste nel fare il test di Kolb sugli stili di apprendimento; in funzione delle risposte che darete rientrerete in una delle quattro categorie che questo educatore statunitense descrisse quali:
stile adattivo/accomodante ap-prende preferibilmente per esperienza concreta (concrete experience - CE)
stile divergente apprende preferi-bilmente per osservazione riflessiva (re-flective observation - RO)
stile convergente apprende prefe-ribilmente per concettualizzazione astratta (abstract conceptualization - AC)
stile assimilativo apprende preferibilmente sperimentazione attiva (active sperimentation - AS) Secondo quanto da teorizzato da Kolb, nessuno possiede tutti e quattro gli stili ma ciascuno svilup-pa nel corso di una vita e anche in funzione delle esperienze svolte, una preferenza per uno stile piuttosto che per l’altro. Il punto saliente è che l’apprendimento è ciclico e quindi i passaggi vanno effettuati tutti, indipen-dentemente da quello dal quale siamo partiti; facciamo un esempio. Se parto nel mio ciclo di apprendimento dall’esperienza concreta in questa fase sarò molto coin-volto nel fare e sarò influenzato dalle sensazioni e percezioni che l’azione mi causerà. Su tali sensa-

74
zioni però dovrò anche riflettere in seguito (osservazione riflessiva) valutando l’esperienza da più punti di vista per acquisire consapevolezza del mio vissuto. Il frutto di tale fase sarà l’elaborazione di concetti astratti più ampi (concettualizzazione astratta); verrà poi il momento di mettere alla prova i concetti elaborati in teoria (sperimentazione attiva).23 Quest’ultima fase genera una nuova esperienza in quanto ciò che è accaduto nelle fasi predette ha certamente agito sul nostro modo di fare e di pensare, modificandolo. Ecco la circolarità che ci invita a seguire tutto il ciclo delle fasi senza limitarci ad una sola di esse, ovvero a quella cui più naturalmente tendiamo.
Un test più semplice Il test di Kolb vi sembra complicato? In effetti non è funzionale ad un piccolo manuale che si pre-figgeva la semplicità come prima caratteristica. E allora ecco un test più immediato e facile che certo non vuole competere con Kolb ma servirà alla nostra bisogna. Voi quando acquistate un oggetto complesso, immaginiamo un gadget elettronico quale uno smar-twatch, un nuovo software, un televisore, siete di quelli che subito prova ad usarlo o appartenete al-la categoria che lo lascia religiosamente impacchettato per leggere prima il libretto di istruzioni? Scusatemi se lo chiamo ancora così, sebbene ormai il libretto non esista più sostituito da un manua-le on-line in formato PDF. Nel primo caso appartenete alla famiglia dei praticoni-smanettoni, nel secondo caso a quella dei teorico-pignolini. Per favore non andate a cercare queste categorie perché le ho appena inventate e con poca fantasia. Poco male in entrambi i casi ma attenzione: se vi limitate a smanettare senza leggere nulla proba-bilmente vi sfuggiranno molte delle funzioni del vostro nuovo oggetto. Nel secondo caso potreste anche imparare a memoria le istruzioni, ma se non vi mettete a fare pratica non diventerete mai pa-droni delle sue funzioni.
E con il Debate? Stesso discorso di quanto consigliato per il gadget tecnologico. Volete partire dalla pratica? Bene, iniziate a sperimentare subito ma nelle prime occasioni fatelo in un ambiente non ansiogeno, tra amici casomai, quasi per gioco, senza dare inizialmente peso alle regole. Ciò che al momento vi preme capire è come, voi e i vostri compagni, organizzate un discor-so, se siete in grado di controbattere ad una argomentazione dell’avversario, se rispettate i tempi, se riuscite a mettere enfasi nei vostri assunti e tante altre cose che vanno ben registrate prima di diven-tare dei bravi debater. Ma dopo qualche esperienza pratica, voi e la vostra squadra dovrete fermarvi e apprendere dall’esperienza, ovvero dovrete riflettere su ciò che avete fatto bene e ciò che invece va migliorato, sulle lacune e come colmarle. A seguito di queste riflessioni, da fare principalmente in gruppo, po-trete darvi degli obiettivi di miglioramento, quindi rifate pratica per verificare il raggiungimento dei predetti obiettivi e così via proseguendo in questo alternarsi tra pratica e teoria, tra esperienze e concettualizzazione.
23
Per approfondire: https://it.wikipedia.org/wiki/David_Kolb

75
Se al contrario vorrete partire dall’approfondimento teorico non farete altro che invertire il discorso ma con una attenzione: i bravi e vecchi debater sostengono che il Debate sia principalmente pratica e pratica e quindi ancora pratica. Buon Debate dunque e che la forza della Parola sia con voi.

76
Allegato 1; l’uso efficiente di Google
Usare al meglio
Spesso si trascura il fatto che Google, come tut-ti gli altri motori di ricerca, non ha intelligenza ma è semplicemente un procedimento che ri-solve un determinato problema attraverso un numero determinato di passi. Dimenticando questo aspetto le nostre ricerche rischiano di diventare difficoltose e inefficienti.
Limitiamo il campo di ricerca. Se stiamo cercando una ricetta e digiteremo nella riga dei comandi di Google: pollo alla ma-rengo, avremo circa 22.770 risultati. Ciò accade perché il motore cercherà tutte le pagine che contengono la parola pollo e la parola Marengo. Usando gli apici ovvero digitando “pollo alla marengo” avremo 15.400 risultati ovvero qua-si la metà con un evidente risparmio di tempo nella fase di ricerca. Inserendo gli apici all’inizio ed alla fine di una precisa frase, a-vremo detto a Google di cercare solo quella specifica frase. Se poi aggiungeremo un ulterio-re elemento di distinzione digitando: “pollo al-la marengo” ricetta, avremo come esito l’individuazione di 6.010 risultati ovvero avre-mo escluso quasi il 75% dei risultati iniziali
Ce l’ho sulla punta della lingua Se non ricordiamo l’aggettivo esatto usato da Shakespeare in uno dei suoi più famosi mono-loghi, (spegniti spegniti piccola?? breve?? cor-ta?? candela) potremo sostituire la parola che ci sfugge con un semplice asterisco ovvero * e Google ci aiuterà.

77
Eliminiamo quello che non ci serve Se vogliamo cercare informazioni sul minerale calcio e digitiamo solo la parola calcio avremo qualcosa come 120.000.000 di risultati. Se in-vece scriveremo calcio –sport (attenzione, il segno meno deve essere attaccato alla parola, quindi niente spazio) i risultati si dimezzeran-no, non solo ma al primo posto avremo il calcio come elemento chimico. Se poi digiteremo cal-cio elemento chimico –sport, avremo 161.000 risultati ovvero quasi un decimo della prima ri-chiesta.
Cercare in un sito Se abbiamo letto nel sito del Corriere della Sera un articolo che vorremmo ritrovare digiteremo : legge di stabilità site:corriere.it
Accadde tanto tempo fa Se vogliamo fare un ricerca in vecchi giornali ci basterà digitare http://news.google.com/newspapers e ci com-parirà una vasta scelta di giornali di tutto il mondo che in alcuni casi risalgono al 1880
Le mappe senza Google Maps Restando nel motore di ricerca possiamo digita-re: da via Stalingrado, Bologna a via Rizzoli, Bologna e ci comparirà il percorso desiderato.

78
Cosa significa? A volte ci capita di sentire frequentemente un termine senza sapere davvero cosa significa ad esempio i commentatori economici citano spes-so la parola: default che comunque sentiamo anche in informatica. In tal caso basterà digita-re: definizione:default e immediatamente a-vremo i due significati tipici della parola.
Dove l’ho già visto? Salviamo la foto che vogliamo cercare sul pc. Potremo cercarla nelle Immagini Google atti-vando la funzione Fotocamera (con un semplice click sul disegnino della fotocamera presente sulla barra di ricerca) e selezionando l’opzione «Carica un’immagine». Google ci presenterà una carrellata di immagini simili presenti sul web.
Ampliamo la ricerca Stiamo cercando non solo una parola ma anche i suoi possibili sinonimi; usando la tilde “~” (ALT+126) davanti alla parola cercata, Google restituirà i links relativi ai sinonimi. Ad esempio: cercando ~camion avremo rispo-ste su camion, autocarri, autoarticolati, ecc.
Due ricerche in una Se digiteremo in Google ad esempio “legno imbarcazione” la ricerca si orienterà verso quei link che soddisfano entrambi i termini; ma se useremo “OR” faremo una doppia ricerca, ot-tenendo i risultati della stessa ricerca con una parola o l’altra.
Ricerche, ricerche Particolarmente indicato per gli studenti Goo-gle Scholar restituisce di un termine cercato bi-bliografia, citazioni ecc. ed è quindi ideale per le ricerche scolastiche.

79
Inoltre permette anche di definire lo spazio del-la ricerca, ad esempio: la bibliografia dal 2003 in poi circa un certo soggetto.
Al top; ricerca avanzata Se proprio abbiamo bisogno di effettuare una ricerca molto sofisticata ed analitica Google ci offre il più complesso e preciso dei suoi stru-menti. Dovremo semplicemente nella barra dei comandi digitare: ricerca avanzata e potremo accedere alla “Ricerca avanzata Google”; in es-sa ci comparirà una pagina con diverse opzioni che renderanno la nostra ricerca perfettamente mirata.

80
Allegato 2; Regole e consigli per i giudici di una gara di debate I giudici
1. non devono essere vicini in qualche modo ai giocatori di una delle squadre coinvolte in-somma vige per loro ciò che per i magistrati si definisce “legittima suspicione”,
2. possono richiamare il pubblico degli osservatori qualora vengano praticati comportamenti inappropriati quali parteggiare apertamente per una squadra, applaudire, usare i cellulari. In-somma gli osservatori devono essere tranquilli e silenziosi,
3. sono garanti di un atteggiamento di reciproco rispetto da parte dei debaters, 4. non possono inviare ai debaters segnali verbali o non verbali di approvazione o disapprova-
zione, 5. devono prendere appunti durante la gara possibilmente usando la scheda allegata per essere
il più possibile coerenti e oggettivi 6. devono garantire la tempistica degli interventi qualora non vi sia un cronometrista designato 7. devono essersi informati sulla materia dei dibattito, 8. qualora un debater citi informazioni non note al giudice questi ha facoltà di chiedere appro-
fondimenti e fonti, 9. devono compilare una scheda che motivi le loro decisioni e i punteggi ciò affinché il giudi-
zio abbia un fine prettamente educativo, 10. esprimono giudizi positivi o di critica ma sempre costruttivi e comunque valutano i debaters,
non tanto per le sensazioni (aspetto sicuramente inevitabile) ma la qualità della loro ricerca, l’approfondimento e l’analisi dei contenuti, l’abilità nel porre domande, la completezza delle risposte, la chiarezza di espressione.
Un aiuto al giudice può arrivare da uno strumento come quello che segue e che gli permetta di strut-turare in modo ordinato le sensazioni provate ascoltando i singoli debater.

81
Griglia di valutazione dei debaters
Debater
Squadra
Area di osserva-zione
Domanda Si/No Punteggio24
Contenuti e capaci-tà analitica
Il debater ha presenta-to contenuti corredati di informazioni?
Ha risposto alle do-mande in modo com-pleto?
Nelle sue risposte c’era sufficiente uso della logica, fatti, e-sempi, e / o il parere di esperti?
Le sue informazioni erano adeguatamente documentate?
I suoi contenuti erano pertinenti al tema?
Totale punteggio area
Area di osserva-zione
Domanda Si/No Punteggio
Organizzazione del discorso
In fase introduttiva il debater ha ottenuto l’attenzione del pub-blico?
Ha fatto una chiara sintesi del tema?
Ha fatto un uso effica-ce di esempi e metafo-re?
Ha dedicato agli ar-gomenti il tempo ade-guato?
Nella sua presentazio-ne c’era una progres-sione logica?
In conclusione ha rias-sunto brevemente quanto detto?
Ha concluso in modo efficace?25
24
Attribuire un punteggio pari a 1 per i si e 0 per i no

82
Totale punteggio area
Area di osserva-zione
Domanda Si/No Punteggio26
Modalità di presen-tazione dei conte-nuti
Il linguaggio era ade-guato al tipo di pubbli-co?
Il linguaggio era cor-retto grammaticalmen-te?
Il modo di parlare ap-pariva spontaneo e na-turale?
Il volume di voce era appropriato?
Il tono di voce era ap-propriato?
Il debater ha mostrato sufficiente varietà di ritmi, uso di pause, en-fasi?
La gesticolazione era varia e adeguata?
Il debater ha mantenu-to un buon contatto vi-sivo con gli ascoltato-ri?
Totale punteggio area
Totale generale punteggio
25
Per conclusione efficace intendiamo una conclusione che rimanga impressa, che colpisca emotivamente o che inviti gli ascoltatori a riflessioni o azioni. 26
Attribuire un punteggio pari a 1 per i si e 0 per i no