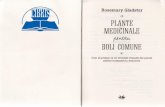83/2004 del 5 marzo 2004 Trimestrale dei Fratelli delle ... in italia/n 45.pdf · la coscienza del...
Transcript of 83/2004 del 5 marzo 2004 Trimestrale dei Fratelli delle ... in italia/n 45.pdf · la coscienza del...

Trim
estr
ale
dei F
rate
lli d
elle
Scu
ole
Cris
tiane
- R
egis
traz
ione
pre
sso
il Tr
ibun
ale
Civ
ile d
i Rom
a -
Sez
ione
per
la S
tam
pa, n
. 83/
2004
del
5 m
arzo
200
4P
oste
Ital
iane
S.p
.A. S
pedi
zion
e in
Abb
onam
ento
Pos
tale
- D
.L. 3
53/2
003
(con
v. in
L. 2
7/02
/200
4 n°
46)
art
. 1, c
omm
a 1,
DC
B R
oma

DIRETTORE RESPONSABILEMARIO CHIARAPINI
Consiglio di redazione:Gabriele Di Giovanni - Maurizio DossenaLorenzo Filippi - Gabriele MossiGiuseppe Norelli - Guido OrsiAlberto Tornatora
Collaboratori e Corrispondenti:Bruno A. Bordone, Alberto Castellani, GiuseppeEusepi, Maria Ferrer, Jorge Gallardo, Chiara Lai,Piergiorgio Lattanzi, Raffaele Norti, CarlaPollastri, Serena Pegorin
Archivio fotografico:Fausto Guarda, Sergio Saini, Claudio Laconi,Iconografia lasalliana.
La rivista viene inviata gratuitamente.Chi desidera contribuire alle spese puòservirsi del
C/c postale n. 52041001IBAN IT27A02008 05020000005215702
causale: Lasalliani in Italia
Per il cambio di indirizzo comunicare anche il vecchio
Direzione e redazione:Lasalliani in ItaliaVia Gian Battista Pagano, 7100167 [email protected]
Amministrazione e Edizione:Provincia della Congregazionedei Fratelli delle Scuole CristianeViale del Vignola, 56 - 00196 Roma
Rivista associataall’Unione Stampa Periodica Italiana
Stampa e spedizione:Stabilimento TipolitograficoUgo Quintily spa - V.le E. Ortolani, 149/151.Zona Ind. di Acilia, 00125 [email protected]. 06-52169299
Finito di stampare: Maggio 2015
Italia
LASALLIANI in ItaliaRivista trimestrale della Provincia Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane Organo di stampa dei Lasalliani: Fratelli, Amici, Docenti, Alunni, Ex-alunnihttp://www.Lasalleitalia.net
Giugno 2015 - Anno XII • n. 45
SOMMARIO
Estate, tempo di vacanze 3di Mario Chiarapini
La Società chiama, l’Istituto risponde 4di Jorge GallardoLa parola per te 7di Gabriele MossiTemi lasalliani: Incidenza dell’educatore testimone del suo annuncio 8di Bruno Adelco BordoneTestimoni contemporanei: Fratel Teodoreto e Fratel Gregorio 11di Raffaele Norti
Un racconto credibile 13di Giuseppe NorelliProteggere la famiglia per difendere la società 15di Maurizio DossenaIl balletto della politica 18di Lorenzo Filippi
Consiglio internazionale dei giovani lasalliani, 21 - Visita del card. Berhaneyesus D. Souraphiel, 21Rito di ammissione al postulantato e al noviziato, 22 - I Fratelli e i giovani in missione, 22Incontro Vocazionale Universitario, 23 - La presenza delle Suore Guadalupane de La Salle, 23Fratel Rafael Matas nominato Consigliere Generale, 24 - Il Papa a Pompei, 29Il Superiore nella Regione PARC, 29 - Mensa serale dei poveri, 29 - Medaglia d’Oro al La Salle-URL, 30Solidarietà con il Sud Sudan, 30 - 6° Trofeo Fratel Roberto Roberti, 31 - XX Congresso ASSEDIL, 31Nuovo direttivo nazionale Confederex, 32
25di Mario Chiarapini e Carla Pollastri
Un grande della musica: Goffredo Petrassi 33di Mario Chiarapini
Incontro MGL “costruire sulla roccia” 36di ELP-Equipe Lasalliana Pastorale
La solidarietà lasalliana è fatta anche di gocce 38di Serena Pegorin
Cinquantenario visita di Paolo VI al Pio IX 39di Gabriele Di Giovanni
Tra stipendio e dono: il lavoro dell’insegnante 40di Piergiorgio Lattanzi
Tris da ombrellone 41di Alberto Castellani
La Salle e Don Bosco: due Santi per i giovani 43di Raffaele Norti
Pagelle ed esami: è tempo di bilanci 45di Guido Orsi
Grafologia: un altro modo per conoscere l’uomo 47di Giuseppe Eusepi
Una persona semplice e sensibile: Fratel Riccardo Bucossi 48
Consigli per la lettura 51a cura di Alberto Tornatora
EDITORIALE
NOTIZIE dall’Italia e dal mondo
APPROFONDIMENTI
RIFLESSIONI
IN LIBRERIA
EX-ALUNNI FAMOSI
Fratel Muziano, il fratello che obbediva
DIDATTICA
TESTIMONIANZE
L’ULTIMA CAMPANELLA
CONSIDERAZIONI
TEMI EDUCATIVI
ESPERIENZE
Trim
estr
ale
dei F
rate
lli d
elle
Scu
ole
Cris
tiane
- R
egis
traz
ione
pre
sso
il Tr
ibun
ale
Civ
ile d
i Rom
a -
Sez
ione
per
la S
tam
pa, n
. 83/
2004
del
5 m
arzo
200
4P
oste
Ital
iane
S.p
.A. S
pedi
zion
e in
Abb
onam
ento
Pos
tale
- D
.L. 3
53/2
003
(con
v. in
L. 2
7/02
/200
4 n°
46)
art
. 1, c
omm
a 1,
DC
B R
oma

Estate, sinonimo di lunga vacanza, non per tutti naturalmente, e nonsolo per chi non se le può permettere, ma anche per coloro che nehanno una sensazione di vuoto, per il fatto che è un periodo in cui nonsi ha nulla da fare o, per assurdo, si può fare ciò che si vuole, perfinoperdere del tempo prezioso. Molti, durante le vacanze, provano la felicesensazione di sentirsi più liberi: né scuola né lavoro, maggiore socializ-zazione, andare al mare o in montagna, incontrare persone care, viag-giare! Alcuni vorrebbero che non finissero mai, mentre altri, permancanza di occupazioni e trovando eccessivo il tempo del riposo, siannoiano da morire e non vedono l’ora che tutto ritorni alla normalitàcon i vari impegni della vita quotidiana. Il termine vacanza, dal latinovacare (essere vuoto, sgombro, libero, senza occupazioni), riguardaanche ruoli e cariche, detti appunto vacanti, quando nessuno li ricopre.In questi casi, si vive una situazione gravida di incognite, che necessitauna pronta soluzione. Effettivamente, quando si va in vacanza, anche
le case e gli uffici si svuotano; si desidera staccare la spina e mettere da parte ogni preoccupazione. L’estate,dunque, si distingue per la sua eccezionalità, per la sua natura extra-ordinaria in cui, tramite la vacanza èpossibile decidere, in totale autonomia, come impiegare il proprio tempo, perché la vacanza dà anche lapossibilità di esprimersi, di realizzare i propri desideri, di rilassarsi psichicamente e di riposare fisicamente,ma sarebbe davvero un peccato se ne derivasse anche uno svuotamento dei cervelli. In vacanza, dunque,ci si può lasciar andare all’ozio, ma non secondo la moderna accezione di non fare niente per pigrizia o peraltri impedimenti, ma secondo quella dei latini, che consideravano l’otium una caratteristica dell’uomolibero che, secondo le sue attitudini, si dedica alla ricerca intellettuale e agli hobby preferiti; un privilegioche era invece negato agli schiavi, dediti al negotium, termine che indica un’occupazione lavorativa svoltaper necessità o per costrizione.
Mario Chiarapini, FscDirettore
Ed it o ri a l e
L’estate e le vacanzeoffronotante opportunità,non solo di riposo, ma anche di crescita e di realizzazionepersonale. Importante viverleintelligentemente.
Nella Parola di Dio trovi la gioia di vivere.La Salle
Estate, tempo di vacanze
3

4
riflessioni
Giappone. Come messicano, tantoin Giappone che in Italia, ho capitoche la stessa sfida si può osservare,sentire e interpretare in modo dif-ferente. Tuttavia, tra le sfide che sipossono considerare “universali”,potremmo ricordarne sette che po-trebbero essere collegate alla nostramissione lasalliana: l’onnipresenzadella tecnologia digitale, l’ingerenzadel sistema bancario nel mondo po-litico, l’emancipazione della donna,
Jorge Gallardo,vicario generale, Fsc
l’accelerazione dei cambiamenti de-mografici, la dicotomia tra voca-zione e professione, la radicalizza-zione della religione, la mancanzadi consapevolezza per il bene co-mune.a. La tecnologia nella comunicazione
è una realtà onnipresente e ci dàl’illusione che si possa sempre eimmediatamente entrare in comu-nicazione con chiunque vogliamo,indipendentemente dalle distanzespaziali o temporali. Ci rendiamoinvece conto che la tecnologia creaisolamento, rendendo difficile, avolte, la comunicazione perfino concoloro che sono fisicamente a por-tata di mano. La scuola con i suoiagenti, studenti, insegnanti e ge-nitori, come pure tutto il sistemadi istruzione e il processo di inse-gnamento-apprendimento sonoprofondamente influenzati dallatecnologia.
b. L’influenza del sistema bancario in-ternazionale nelle decisioni dellapolitica ha stravolto la situazionee ciò che in origine era stato con-cepito come servizio alla gente, hacambiato direzione e ora serve gliinteressi finanziari di pochi, con ilrisultato di creare una voragine piùampia e profonda tra ricchi e po-veri. Se l’educazione ha un costo,
Nuove tecnologie, sistema bancario internazionale,emancipazione della donna, insicurezza sociale
e fragilità dei rapporti umani, diritti individuali e sociali,movimenti migratori... sono solo alcune delle sfide,
cui l’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristianeè chiamato a dare delle risposte.
LA SOCIETÀ CHIAMA,L’ISTITUTO RISPONDE
1. Le attuali sfide della società cheinterpellano il nostro carisma
Ogni volta che si parla del mondo glo-balizzato, in genere si pensa che tuttosia uniforme e che ci siano poche dif-ferenze tra le culture. In realtà, non ècosì: prima di definire le sfide che lasocietà rivolge al nostro carisma la-salliano, è necessario capire di qualesocietà si sta parlando. Prima di venire a Roma vivevo in

riflessioni
5
il risultato è solo uno: non ci saràeducazione per quelli più poveri.
c. Il ruolo della donna nella società enella Chiesa continua ad acquistareuna meritata rilevanza che per se-coli le era stata negata. Il nostroIstituto, il cui carisma è una for-mazione in un contesto di Chiesa,non è estraneo a questo cambia-mento significativo: il 52% deglieducatori lasalliani è costituito dadonne e nelle nostre classi il nu-mero delle ragazze è in crescita.
d. I movimenti migratori e il controllodelle nascite hanno avuto un im-patto molto evidente nella demo-grafia dei Paesi. Per quel che ri-guarda il mondo lasalliano, separliamo dei Fratelli, si rileva chein Europa ce ne sono sempre menoe sempre più anziani, mentre inAmerica Latina, Africa e Asia sonopiù giovani.
e. C’è stato un tempo in cui tra pro-fessione e vocazione non c’era al-cuna differenza. Quando eravamobambini, noi adulti abbiamo vissutoun periodo nel quale il lavoro, lafamiglia, il carattere individualeerano un tutt’uno: sia che si trat-tasse di una famiglia di contadini,di artigiani, di medici o di artisti.Oggi è possibile avere un lavoroche si può fare senza errori ma an-che. . . senza passione. La passioneper la campagna non necessaria-mente è legata al lavoro del con-tadino. Come lasalliani, l’educa-zione è il nostro lavoro, possiamoanche dire che è la nostra voca-zione e che tutto ciò che ha a chefare con l’educazione ci appassiona.O forse no....
f. Di fronte alla crescente insicurezzasociale e alla fragilità dei rapportiumani, una delle false risposte èdare alla religione un valore magicoper attaccarsi a delle verità appa-rentemente assolute, che ci diconoche le cose sono chiaramente onere o bianche, senza le tonalitàintermedie di grigio. L’educazionereligiosa nelle nostre scuole si ètrasformata in una scommessa co-stante per evitare di formare gio-
vani che cadono nella facile solu-zione di catalogare in modo super-ficiale il vero dal falso, senza con-siderare la formazione del pensierocritico e la coscienza morale.
g. Formare la propria individualità nonè qualcosa di negativo, invece lo èquando ciò comporta un interessequasi nullo per gli altri, chiunqueessi siano, soprattutto mancandola coscienza del bene comune. Daigoverni si esige che assicurino ilbene comune, invece quando par-liamo di noi come semplici citta-dini, in genere pensiamo solo ai no-stri diritti individuali che esigiamovengano rispettati.
2. Dovere dell’Istitutodi rispondere
Dalla sua fonda-zione, nella Franciadi Luigi XIV, Gio-vanni Battista de LaSalle ebbe l’idea cheil primo dovere delnostro Istituto fossequello di assicurareu n ’ e d u c a z i o n eumana e cristiana aigiovani, soprattuttoai poveri. Ciò ri-chiede una pro-fonda conoscenzadella realtà circostante per impri-merle, secondo le nostre possibilità, ivalori fondamentali del nostro Isti-tuto: Fede per riconoscere la presenzadi Dio in tutto ciò che siamo e fac-ciamo; Servizio per realizzare tutte lenostre azioni per amore a Dio e Co-munione nella missione, per incarnareGesù tramite la nostra associazionenelle comunità e nelle opere. Questatriade deve confrontarsi continua-mente con le sfide della realtà circo-stante.Così facendo, queste sfide diventanodomande la cui risposta non è sem-plice: riguardo alla tecnologia, qualevantaggio si ha per rinforzare i nostriprogrammi scolastici e per promuo-vere un apprendimento interculturale
con altri lasalliani al di fuori del pro-prio ambito scolastico? Cosa stiamofacendo per far sì che i nostri allievifacciano distinzione tra informazionee formazione?Davanti al crescente divario tra ricchie poveri, quali opportunità stiamo cre-ando per la formazione e l’esperienzaalla giustizia sociale dentro le nostreistituzioni? Sono efficienti i nostriprogrammi di solidarietà? Come pos-siamo evitare che i nostri studenti conminori disponibilità economiche la-scino le nostre scuole? Come cambiareil maleficio che trasforma gli esseri
umani in oggetti di mercato? Considerando il potere
crescente delladonna nella so-cietà, che tipo diformazione dil e a d e r s h i p
stiamo offrendo alle nostre alunne?Quali opportunità di lavoro in postiamministrativi stiamo offrendo alledonne nelle nostre istituzioni? Comevivere e sviluppare la chiamata allasantità di tutti, uomini e donne, laicie religiosi nella Chiesa?Con la realtà demografica delle operelasalliane in Italia ci ritroviamo conmeno Fratelli e più laici impegnatinella missione Lasalliana; con più al-lievi di fedi religiose e culture diverse.Siamo consapevoli delle risorse cheabbiamo? Dove e per chi dobbiamoinvestire le nostre risorse umane e fi-nanziarie? Dalla nostra realtà indivi-duale e comunitaria (famiglia, scuola,lavoro) come vivere il richiamo di “an-dare più in là delle frontiere”?

6
riflessioni
La scuola sognata da Giovanni Batti-sta de La Salle includeva il sogno im-possibile “che tutti si salvino” (cf. M193); la salvezza terrena prevede chel’alunno lasalliano sia pronto ad af-frontare la vita e che viva la sua pro-fessione con passione. Come adat-tiamo i nostri programmi di studioalle sfide lavorative, alle quali si con-frontano i nostri ex-alunni? Come se-guiamo formalmente i nostri ex alunniuna volta che entrano nelle Universitào nei posti di lavoro? In questa situa-zione, cosa facciamo per proporre levocazioni di servizio, soprattutto lavocazione del Fratello come un’op-zione di vita?Contro la radicalizza-zione dell’esperienzareligiosa, cosa stiamofacendo per promuo-vere il dialogo interre-ligioso? Stiamo soltantotollerando la presenzadi allievi o compagni dilavoro di altre religionioppure stiamo facendoqualcosa per svilupparela maturità del lorocredo e per approfon-dire, al tempo stesso, lenostre radici cristiane?Che valore diamo allatestimonianza della nostra vita cri-stiana di fronte alla sfida di quelli chenon condividono la nostra fede o nonla professano? Nelle nostre scuole, nelpromuovere la libertà responsabile,come inculchiamo i valori cristianidella misericordia e della carità? Cheopportunità diamo per promuoveredelle attività in favore del bene co-mune e della responsabilità civile?
3. Quali risposte in atto?
I problemi globali richiedono soluzioniglobali che coinvolgano in manieracoordinata tutta l’umanità. Questonon è possibile, non facciamoci illu-sioni. Però, d’altra parte, sappiamo chela rete lasalliana è capace di raggiun-gere e trasformare in maniera positivamolte vite. Basta considerare che, non
importa che ora sia del giorno, né inquale giorno dell’anno si stia vivendo,perché in qualche luogo del mondoc’è un educatore lasalliano con ungruppo di alunni che sta provando arendere reale la visione del nostroFondatore: il dovere di “toccare i cuoridei nostri alunni per avvicinarli a Dio”. In modo un po’ più organizzato, nelConsiglio Generale, abbiamo pensatoche, per poter muovere i cuori in ma-niera più efficace, nei prossimi anni,sarà necessario invitare tutti i lasal-liani a unirsi per sviluppare annual-mente, a livello locale, delle attivitàdi riflessione e di azione intorno a un
tema centrale e a uno secondario. Questo programma è presentato indettaglio nella circolare 470. Il temacentrale, in sintonia con papa Fran-cesco è “Vivere insieme la gioia dellanostra missione”. Con l’attitudine fra-terna, gioiosa e impegnativa che iltema centrale ci suggerisce, affron-teremo ogni anno una delle sfide pre-cedentemente elencate, con l’idea dispingere alla riflessione e all’azione,partendo dalle nostre realtà locali.• Per il 2014/15 l’argomento è lo stesso
del 45° Capitolo Generale: “Questaopera di Dio è anche la nostra”.
• Per il 2015/16, l’argomento sarà:Un’esperienza di Vangelo.
• Per il 2016/17, Una chiamata, moltevoci.
• Per il 2017/18: Lasalliani senza fron-tiere.
• A metà del nostro mandato, come
Consiglio Generale, nel 2018/19,l’argomento sarà: “I nostri cuori ar-dono dentro di noi” e, per comme-morare il 300° anniversario dellamorte di San Giovanni Battista deLa Salle, l’anno sarà dichiarato:“L’anno delle vocazioni lasalliane”.
• Per il 2019/20: “Grandi cose sonopossibili”.
• E per l’anno 2020/21 l’ultimo delnostro mandato e prima del 46° Ca-pitolo Generale, l’argomento sarà:“La nostra visione, la nostra pas-sione e il nostro futuro”.
4. Quali risposte ancora da dare?
Incamminarsi verso unasfida significa affron-tare le difficoltà condecisione. Nel ConsiglioGenerale intendiamoaffrontare tutte le sfideinsieme a tutti i lasal-liani del mondo, par-tendo dalle circostanzeconcrete di ogni luogoin cui l’Istituto è pre-sente. Da qui nasce la propostaannuale di riflessione edi azione intorno allesfide fin qui elencate.
Con piccoli gesti possiamo cominciarea cambiare le cose, a “fare miracoli”,come dice il santo Fondatore: “Anchevoi potete compiere miracoli nei vostriconfronti e nel vostro ministero. Neivostri confronti con una piena fedeltàalla grazia, non lasciando sfuggirenessun movimento di spirito senzacorrispondervi; nel vostro ministerocercando di penetrare nel cuore deiragazzi più difficili, prendendo ognimezzo per renderli docili e fedeli allemassime evangeliche (…). Questi sonoi miracoli che Dio richiede da voi eche voi potete compiere con il suosanto aiuto” (M 180.3). Ognuno di noiha qualche cuore da muovere. Noipossiamo dare delle indicazioni, mal’unica persona capace di fare questomiracolo sei solo tu. ◆
(traduzione dallo spagnolodi Maria Ferrer)

77
DOV’È L A TUA FEDE...? (Lc 8, 22-25)
Accolgo l’invito, Signore, e con te prendo il largolontano dal fango di una terra impastata di miseria e di interessi materiali
dalla folla anonima ubriaca di curiosità morbose e di gossip grotteschida un mondo effimero di piccoli uomini egoisti, vestiti di vanità …
Con i miei fratelli punto la prora della speranza verso l’altra riva (Lc.8,22)che attira il mio cuore col fascino del Mistero trascendente ed eterno.
Ma sul lago della vita spesso incombono le tenebre della solitudinele tempeste improvvise del dubbio e della pauraper gli orrori e le immani tragedie che devastano il creato: ingiustizie, violenze, dolori, malattie col volto della morte …
Sulla mia angoscia di fragile creaturac’è chi sputa beffarda la sua irrisione: “dorme il tuo Dio?” (Lc.8,23)
Lo so, Signore, che tu sei sempre con me e non mi lasci solo.Ma stordito da tanti problemi a volte ti sento lontano, assentee beato l’urlo della disperazione se sveglia la mia fedee le fa gridare: “Maestro, salvami, sono perduto!” (Lc.8,24)
Divina la tua onnipotenza placa le forze della natura, vince il malee nel cuore torna la pace serena che solo Tu mi puoi dare.Accorato, affettuoso e incoraggiante il tuo rimprovero: “Dov’è la tua fede?” (Lc.8,25)
Quando il mondo sembra caderti addosso, la malattia ti morde le carnie il tuo spirito è ferito dal lacerante mistero del male, dov’è la tua fede?Quando il tuo Signore muore nei suoi figli più cari, abbandonati da tuttisenza pane di dignità e speranza, sgozzati per dar gloria a dio …e Lo pensi un fantasma quando Risorto ti viene a cercare, dov’è la tua fede?
Quando nelle situazioni più assurde, nelle prove più dolorosedimentichi la moltitudine dei veri cristiani testimoni dell’Amore, dov’è la tua fede?
Stupito e affascinato dalla sacralità della tua Persona di uomo-Diocon cuore trepido mi chiedo: “Chi sei, Signore?” (Lc.8,25)
pericoloso rivoluzionario inchiodato alla croce delle sue illusionitaumaturgo incantatore di folle con miracoli prodigiosiuomo eccezionale che ha cambiato radicalmente la storia …?
Profeta potente, giusto, santo e senza peccatostella radiosa del mattino e Luce del mondoatteso Messia salvatore e redentore degli uominibuon Pastore mite e umile di cuore che vuole misericordia e perdonoVia Verità e Vita per ogni creatura di buona volontà …
Con la fermezza della fede, il respiro della speranza, la forza dell’amore ogni giorno sulle pagine del mio vivere inquieto voglio scrivere a lettere di sangue:“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt.16,16).
LA PAROLA PER TE!
Gabriele Mossi, Fscprofessore di filosofia
LA PAROLA PER TE!

8
lasallianità
Giovanni Battista de La Salle ebbeun’educazione completa dallasua infanzia fino all’ordinazione
sacerdotale a 28 anni di età. Fu edu-cato da bambino in famiglia, in seguitoalla scuola dei Bons Enfants; determi-nanti furono i 18 mesi passati al semi-nario di Saint Sulpice e infine laformazione personale con la direzionespirituale del canonico Nicolas Roland.Quando fu ordinato sacerdote, in ri-tardo negli anni a causa delle vicendefamiliari che lo hanno visto tutore deisuoi fratelli minori e amministratore deibeni di famiglia, era un giovane cheaveva raggiunto la piena maturità edera pronto ad affrontare gli incarichipiù impegnativi.
Non abbiamo nessuno scritto diquali fossero le sue prospettive di vitain quel momento né egli ha potuto in-dicarcelo con la sua maturità perché èintervenuto il Signore nel modo a cuiegli certamente non pensava, dandouna svolta determinante nella sua vita.
Due differenti concezioni di scuolaAnche con una scarsa conoscenza
del La Salle è possibile ricondurre que-sta svolta all’incontro fortuito fra Gio-vanni Battista e il maestro AdrianoNyel proveniente da Rouen con l’inca-rico specifico da parte della convertitasignora Maillefer di aprire una scuolaper fanciulli poveri a Reims. La storia cidice che Giovanni Battista solo per ilsuo prestigio di nobile, canonico edotto è intervenuto riuscendo ad aprirela scuola nella parrocchia di Saint
trezzature, orario, programmi, ma cer-tamente tutto doveva realizzarsi nelprovvisorio come sempre avvienequando si intraprende dal nulla una ini-ziativa.
Tuttavia non pare che Nyel fossepreoccupato perché, visto il cresceredegli alunni, si determinò di favoriresubito l’inizio di una seconda scuola.Preoccupato invece si è dimostrato il LaSalle che aveva un concetto ben piùcompleto di scuola. A impensierirloerano soprattutto i maestri reclutati dalNyel i quali, se forse erano un grado didare i primi rudimenti di istruzione,erano ben lontani dall’ideale di educa-tori. Su questo argomento si differenziasostanzialmente la finalità della scuolatra il La Salle e Nyel: questi si interessadell’istruzione dei fanciulli, mentre il LaSalle è preoccupato della loro educa-zione. Di qui hanno inizio le diversestrade percorse dai due protagonistidell’inizio dell’istruzione popolare: ilNyel è tutto proteso ad aprire nuovescuole mentre il La Salle lo frena pre-occupato dell’inesperienza dei respon-sabili scolastici: i maestri.
La svolta decisiva nella vitadel La Salle
Il La Salle non è interessato in primapersona nella gestione della scuola manon può considerarsi estraneo di frontea un problema di cui sente la gravità,tanto da non riuscire a rimanere indif-ferente, essendone in qualche manieracoinvolto. Sono note le iniziative cheegli assume spinto solo dal desiderio divenire incontro alle esigenze del Nyel:innanzitutto affitta una casa perchéquesti possa dare una formazione aimaestri, ma egli non ha la sensibilitàper rispondere alle richieste del La Sallee continua a impegnarsi nell’aprire
Bruno Adelco Bordone, Fsclasallianista
Temi lasalliani 20
Maurice, evitando così il pericolo di ca-dere nei meandri della burocrazia mu-nicipale che avrebbe bloccato ilprogetto nel timore di dover intervenirecon sovvenzioni e realizzando unascelta innovativa per quei tempi. Se ilcanonico La Salle è stato un autorevoleiniziatore nell’aprire la scuola, nonmeno efficace è stato il Nyel nell’orga-nizzare dal nulla l’inizio delle lezioniscolastiche. Con la sua intraprendenza,benché egli fosse forestiero, è riuscitoa trovare tra la popolazione locale iprimi maestri improvvisati che almenosapevano leggere, scrivere e fare diconto e sensibilizzare le famiglie chefrequentavano la parrocchia a mandarei loro figli a scuola. Nessuno dei primibiografi ci ha tramandato i particolaridell’inizio della scuola: ambienti, at-
La missione educativa è efficacequando è accompagnata dal “bon exemple”,
cioè da una testimonianza autentica.Istruzione ed educazione
devono andare di pari passo.
INCIDENZA DELL’EDUCATORETESTIMONE DEL SUO ANNUNCIO

lasallianità
9
lutare bene le richieste e accettaresolo quelle che garantivano un futuro.
Importanza della testimonianzaDopo questi accenni alla storia
della formazione dei maestri come te-stimoni, passiamo ora a considerarequali sono stati i contenuti di questaformazione. La principale fonte la tro-viamo nelle Meditazioni in cui si rias-sume il suo pensiero ascetico. Il primotema che ci balza all’occhio riguardal’incidenza della testimonianza. L’inse-gnamento del La Salle è perentorio:“Volete che i vostri alunni facciano ilbene? Fatelo voi per primi. Li convin-cerete molto meglio con una condottasanta che non con tutte le parole chepotete dire loro” (M 33,2). In altra me-ditazione specifica: “Il ‘bon exemple’ èassolutamente necessario affinché lavostra missione diventi davvero effi-cace. La vostra condotta, pertanto,deve essere per gli alunni un continuoesempio di saggezza e di pietà, tali dalasciare in loro un viva impressione. Ildisinteresse con cui vi impegnate viaiuterà a darvi alla vostra missione peramore di Dio, con tutto il cuore. Così ilvostro lavoro sarà fruttuoso perché be-nedetto da Dio” (M 133,2). Il temadell’incidenza della testimonianza èmolto caro al La Salle prova ne sia chelo riprende in varie meditazioni. Ne ci-tiamo ancora una: “La virtù non puòrestare nascosta: quando risplende at-tira e l’esempio che si dà fa un’impres-sione così grande in quelli che lavedono praticare da spingere i più al-l’imitazione. È questo il risultato dellavostra condotta sui vostri alunni? Essaè il mezzo principale di cui dovete ser-virvi per portarli a Dio” (M 158,2).
Sfaccettature della testimonianzaPer il La Salle non basta chiedere ai
suoi figli spirituali la testimonianza perl’efficacia della loro missione educa-tiva: egli specifica anche le caratteri-stiche che essa deve assumere perchésia autentica. Prendiamo in considera-zione alcuni di questi aspetti traendolida un’attenta lettura delle Meditazioni.
Innanzitutto la testimonianza deveispirarsi al Vangelo. Così egli insegna a
sformazione esistenziale:non portare i poveri,anche con sana inten-zione, nel mondo dei ric-chi ma farsi egli stessopovero perché la sua pa-rola abbia il supportodella testimonianza.
Preminenza formativadella testimonianza
I primi biografi del LaSalle non ci hanno tra-mandato quale sia statoil contenuto della forma-zione data dal La Salle aimaestri. Solo ci riportanola soddisfazione del Nyelnel notare la loro trasfor-mazione verso uno stiledi vita più impegnato siaa livello esistenziale cheprofessionale. È facile in-tuire però che egli abbiadonato quei principi chepoi ha profuso nei suoiscritti, e specialmentenelle Meditazioni, aimaestri che lo hanno se-guito e sono diventatisuoi figli spirituali comeFratelli.
I temi trattati, dun-que, sono i più vari, maassumono un’importanzaparticolare quelli che siriferiscono alla dignitàdel maestro, in dettaglioil “bon exemple”, cioèl’esigenza di assicurareagli alunni il valore dellatestimonianza prima che
dell’istruzione. Per questa sua richiestadi coerenza non tutti i maestri lohanno seguito nella costituzione diuna comunità che ha assunto la di-mensione di vita religiosa, fino a co-stituire la “società” dei Fratelli delleScuole Cristiane. Da questa loro fisio-nomia di educatori, e non solo di in-segnanti, conseguì quella solidità dellescuole che fu l’attrattiva per cui que-ste vennero richieste da parrocchie emunicipalità con tale insistenza alpunto che il La Salle fu costretto a va-
altre scuole. Di fronte a questa situa-zione non rimane insensibile il La Sallee si sente chiamato direttamente incausa per assicurare egli stesso la for-mazione dei maestri: li invita ai pasti incasa sua per dare loro la formazioneche già assicurava, come tutore, ai suoifratelli minori, ma poi si accorge chequesto non è sufficiente a garantireuna continuità formativa ai maestri, al-lora li ospita in casa sua per poterli se-guire personalmente. È da questocontatto diretto del La Salle con i mae-stri che matura in lui una radicale tra-

lasallianità
tutti gli educatori nelle Meditazioniper il tempo del ritiro: “Parlando agliapostoli il divin maestro diceva: ‘Vi hodato l’esempio perché come ho fattoio, facciate anche voi’. Volle inoltre chei discepoli fossero testimoni della suamissione affinché, osservandone ilcomportamento, potessero formarsisul suo esempio. Comportatevi nellastessa maniera voi che siete stati sceltifra tanti per essere suoi cooperatorinell’opera della salvezza” (M 196,2). Enella stessa meditazione: “Per com-piere bene il vostro insegnamento nonbasta conformarvi esternamente almodo di comportarsi di Gesù per con-vertire le anime; è necessario che vimettiate dal suo punto di vista e nepenetriate le intenzioni. ‘Io sono ve-nuto perché abbiano la vita - egli dice- e l’abbiano in abbondanza’. ‘Le paroleche vi ho dette sono spirito e vita’, pro-curano cioè la vita spirituale a coloroche le ascoltano volentieri e le prati-cano con amore” (M 196,3).
Un secondo aspetto della testimo-nianza è la coerenza con l’annuncio. Si
tratta di un atto di fede per cui non siparla se non per esprimere il vissuto.Insegna il La Salle: “ Il vostro zelo pergli alunni che istruite sarebbe limitatoe darebbe pochi frutti se si esprimessesolo con parole. Per renderlo efficace ènecessario il vostro esempio…; il vostrozelo diventerà perfetto se voi per primipraticate ciò che insegnate” (M 202,3).E insiste: “Se volete impartire ai vostrialunni una vera educazione cristianabisogna presentarsi come modelli sianell’agire che nell’insegnare: gli alunniimparano innanzitutto dal comporta-mento dell’educatore quanto dovrannopraticare” (M 132,1).
Altra caratteristica della testimo-nianza è quella di essere convincente.Si tratta di un convincimento interioreper cui l’educatore si comporta coeren-temente e crede come realtà oggettivache l’efficacia del suo insegnamentodipende dalla pratica personale. Il LaSalle si rivolge ai Fratelli fondandosisulla Parola di Dio: “Voi esercitate unamissione in cui tutti vi osservano. Sietedunque obbligati a praticare il consiglioche san Paolo dà al suo discepolo Titoquando gli scrive: ’Mostrati modello diopere buone; nell’insegnare mostra ret-titudine e gravità’. Vi osservano i vostrialunni, perciò siete obbligati a dare loroil buon esempio, imitando in questonostro Signore che, secondo Luca negliAtti ‘cominciò a fare e poi a insegnare’.Questo vi darà autorità dinanzi a essi.(M 69,1).
Infine, una caratteristica della testi-monianza, fondamentale per il La Salle,è la dimensione comunitaria. Sappiamoquanto questa fosse importante per lui,infatti non accettò mai di aprire una
scuola se non era sostenuta da una co-munità di Fratelli. Insegna: “Se voleteche il vostro zelo sia utile agli alunni,dovete innanzitutto esercitarlo tra divoi. Ricordatevi che dovete contribuirea mantenere il buon ordine nel vostroambiente educativo tanto da renderloun vero paradiso terrestre fatto diamore e di pace” (M 81,2). “Il vostroministero è stato istituito per procurarelo spirito del cristianesimo ai vostrialunni. Ora non potrete realizzare que-sto scopo né raggiungere la perfezionenel praticarlo se innanzitutto nonavrete lavorato in modo concreto perla vostra santificazione” (M 186 2).
ConclusioneSu queste pagine di appunti lasal-
liani ripetiamo sovente che, quanto nelLa Salle si riferisce agli alunni, noi pos-siamo estenderlo a tutte le nostre co-munità educanti. A sottolinearel’importanza della testimonianza nel-l’educazione ci è di sostegno il La Sallestesso che raccomanda ai primi Fratelli:“Il vostro ministero richiede continuerelazioni con ogni genere di persone.Vigilate dunque per presentarvi semprein atteggiamento edificante tanto daessere considerati il buon profumo diCristo, come dice san Paolo. Dio vuoleche in questo modo si compia la vostramissione educativa” (M 98,2).
A conclusione di queste brevi rifles-sioni sulla testimonianza, accogliamoun pensiero di Papa Francesco che èsintesi di tanti aspetti del suo insegna-mento: ogni cristiano è chiamato a es-sere evangelizzatore con la vita e conla parola in ogni luogo dove egli abitao lavora. ◆
10

11
Raffaele Norti, Fsc Vicepostulatore
FRATEL TEODORETO
Una realizzazione con
l’aiuto del Cielo
Quest’anno ricorre il 25° del De-creto Pontificio, il 3 marzo 1990,lo ha reso Venerabile, ultimopasso per giungere alla Beatifi-cazione e poi alla Canonizza-zione. Dopo la fondazione dell’IstitutoSecolare “Unione Catechisti”, laCasa di Carità Arti e Mestieri è laseconda grande opera realizzatada Fratel Teodoreto, aperta sudiretta ispirazione dal Cielo.Tutto ha origine nel 1919quando Fratel Isidoro, Direttoredella Scuola Elementare di SantaPelagia a Torino, intende aprireuna prima Scuola Professionalein città, nella linea di quelle giàsorte in Francia e in Belgio. Si ri-volge ai Superiori e agli Ex Allievidelle Scuole della R.O.M.I. (RegiaOpera Mendicità Istruita) gestitedai Fratelli da 90 anni e cioè findal 1829 per volere del Re CarloFelice, ma sorgono difficoltà in-sormontabili soprattutto di ca-rattere finanziario. A questo punto, come altrevolte, si manifestano piani supe-riori che sfuggono alle logicheumane. Gesù rivela a Fra Leo-poldo, che trasmetterà subito aFratel Teodoreto, il seguentemessaggio che diventerà il mani-festo programmatico della Casadi Carità: “Per salvare le anime,per formare nuove generazionisi devono aprire Case di Carità,
per far imparare ai giovani Arti eMestieri”. In questo modo, vienesuggerito anche il nome con cuichiamare la nuova opera.Fra Leopoldo, un mistico con ipiedi per terra, ne parla all’Inge-gnere Rodolfo Sella (Zelatoredell’Unione) e al suo figlioavvocato Riccardo che se nefanno promotori presso unComitato di persone in-fluenti nella società torinese.Seguono in tempi ravvicinatialtre comunicazioni di Gesù aFra Leopoldo, puntualmentetrasmesse a Fratel Teodoreto:“Ormai è tempo che si mani-festi la mia volontà: vogliouna Scuola Casa di Carità Artie Mestieri… Non voglioun’opera umana. Voglioun’opera divina e un anda-mento, nella Casa di Carità, se-condo il mio Cuore”.In effetti, fondi e persone dispo-nibili arrivano e con essi il de-collo della nuova Opera:apertura delle prime classi in viaS. Massimo (1920), l’inizio di unaScuola festiva di tipo industrialepresso la Parrocchia Regina dellaPace (1925), dal 1929 al 1950funzionamento dei Corsi in viaFeletto e nel 1940 acquisto delterreno (10.000 mq) per la co-struzione della nuova attualeSede Centrale della Casa di Ca-rità.Nel 1958 la “Casa di Carità”vienecitata in Parlamento come Mo-dello di Istituto Professionale.Nel 1968 viene approvato ilNuovo Statuto (Soci fondatori i
Fratelli delle Scuole Cristiane el’Unione Catechisti). Nel 1974viene aperta una Casa di Carità aGrugliasco (TO) e nel 2002 unasede ad Arequipa in Perù.Attualmente l’opera fondata daFratel Teodoreto è diventata
“Fondazione Casa di Carità Artie Mestieri” - Onlus - Ente di For-mazione Professionale. Funzionain Piemonte con ben 20 Sedi, 1 inVeneto e 1 in Sardegna oltre aquella d’oltreoceano in Perù.Scopo delle Case di Carità nelpensiero di Fratel Teodoreto:“Elevare nello spirito gli operai,avviarli agli ideali della fede, po-nendo con ciò solidi fondamentialla soluzione dei problemi so-ciali… Necessità di educare ope-rai e dirigenti ai principi delSanto Vangelo e alle regole so-ciali emanate dai Sommi Ponte-fici…”.Fratel Teodoreto era preoccu-pato inizialmente di continuarela formazione degli Ex Allievidella Scuola Elementare di SantaPelagia. Con lo stesso spirito difede e zelo, guidato dalla Prov-videnza, allarga a mano a mano
FratelTeodoreto
FratelGregorio
testimonicontemporaneitestimonicontemporanei

In tutte le nostre necessità materiali e spirituali, ricorriamo all’intercessione dei due nostri Fratelli Venerabili.Per inviare offerte a favore delle Cause di Beatificazione dei due Fratelli Venerabili, servirsi di:
c/c postale N. 1013755416 intestato a Provincia di Torino Fratelli S. C.Bonifico IBAN: IT05B0760101600001013755416
Causale: Causa Beatificazione Fr. Gregorio e/o Fr. TeodoretoPer informazioni e relazioni di grazie, rivolgersi a:
Vicepostulatore Fratel Raffaele Norti - Istituto San GiuseppeVia San G. B. de La Salle, 5 - 20132 Milano - tel. 02/272.077.28 - 338.248.29.34 - [email protected]
FRATEL GREGORIO
In Cielo dopola Comunione
Sono trascorsi venti anni daquando nel 1995, alla fine dei dueProcessi canonici celebrati presso ladiocesi di Napoli e successivamentepresso la Sacra Congregazione perle Cause dei Santi in Vaticano, Gio-vanni Paolo II ha proclamato ilServo di Dio Fratel Gregorio Bühl“Venerabile”. Considerata la lunghezza a voltesecolare di tanti Processi di Beatifi-cazione e Canonizzazione, nel no-stro caso si è trattato di tempirealmente molto brevi. Dopo in-fatti appena nove anni dalla suamorte, avvenuta l’11 dicembre1973, si pensò subito di avviare lacomplessa macchina per il ricono-scimento ufficiale da parte dellaChiesa di una santità che era ap-parsa eccezionale in vita e cheavrebbe avuto ancora molto da in-segnare a tutti, soprattutto aquanti impegnati in campo educa-tivo.Così nel 9° anniversario della suamorte, l’11 dicembre 1982 l’Arcive-scovo di Napoli il Cardinale CorradoUrsi, aprì ufficialmente nella Sedecompetente della sua Diocesi il Pro-cesso per la Causa di Beatificazionee Canonizzazione di Fratel Grego-rio che da quel giorno diventò“Servo di Dio”.Bastarono quattro anni per conclu-dere positivamente nel 1986 que-sto primo Processo e per passare
quindi i relativi Atti alla corrispon-dente Sacra Congregazione per leCause dei Santi di Roma per il defi-nitivo Processo (con Teologi e Car-dinali) terminato nel 1995 con ilDecreto Pontificio sulle virtù eroi-che praticate da Fratel Gregorio, dacui il titolo di “Venerabile”.In una lunga lettera dell’8 dicem-bre 1980 inviata a Giovanni PaoloII dal Card. Corrado Ursi e firmatada tutti i Vescovi della ConferenzaEpiscopale Campana si leggeva:“Oggi, mentre molti religiosi si in-terrogano sulla identità della lorovocazione, Fratel Gregorio CesareBühl ha un discorso efficace, con-vincente, inoppugnabile da por-tare avanti con la sua vita chepresenta una sola problematica di
fondo: Gesù Cristo, l’amore divino,lo zelo per le anime e ripete, con lametodologia di apostolo educa-tore, che soltanto l’amore educa esolo in Dio si amano veramente ifratelli”.Dopo i sogni giovanili di spenderela sua vita in qualche terra di mis-sione, i piani di Dio lo chiamavanoinvece a un servizio di ben cinquan-t’anni consecutivi a favore dei gio-vani in formazione, futuri religiosieducatori nell’Istituto dei Fratellidelle Scuole Cristiane.Per concludere, c’è da dire chetranne due indisposizioni en-trambe superate nel 1939, FratelGregorio godette sempre ottimasalute tanto da confidare, ormaiavanti negli anni, a un suo confra-tello: “Non so proprio di qualemale dovrò morire, perché nonsento alcun disturbo importante”. Il primo malore, che lo colpì lieve-mente nell’uso della parola, loebbe nel 1970 mentre pregava incappella. Un successivo leggero at-tacco al cuore tre anni dopo, inagosto, mentre parlava con un Su-periore. Il ricovero all’ospedale Ma-resca di Torre del Greco, suconsiglio del medico, avvenne l’8dicembre, festa dell’Immacolata alui tanto cara, solo tre giorni primadi morire. In quei pochi giorni didegenza tanti i particolari edifi-canti che si potrebbero raccontare.Spirò serenamente la mattinadell’11 dicembre mentre, da solo incamera, ringraziava il Signore perla Comunione appena ricevuta. ◆
testimoni contemporanei
gli orizzonti dei suoi interessifino ad abbracciare l’intera vitadelle anime che il Signore gliaveva affidato e di cui altri a suoesempio avrebbero dovuto occu-parsi a vantaggio dell’intera so-cietà.
Da tempo fisicamente debilitato,ma lucido fino alla vigilia dellamorte quando ricevette la visitadel Cardinale Maurilio Fossati,Fratel Teodoreto si spense sere-namente al Collegio San Giu-seppe il 13 maggio 1954. Il suo
funerale, a spese del Comune,vide il concorso di molte perso-nalità, tra cui il sindaco AmedeoPeyron, e della cittadinanza cheapertamente lo acclamavano giàcome santo e benefattore dellacittà.
Un cordiale ringraziamento a coloro che hanno inviato un’offerta per le cause dei Venerabili.
12

rubrica
13
pur fingendo il contrario. Molto rumoreper nulla, anzi molti rumors per nulla.
Nel tam tam mediatico dove la si-tuazione è angosciante e la direzioneincerta – flusso delle informazioni aparte - un punto fermo lo mette papaFrancesco. “La sfida che oggi ci si pre-senta è reimparare a raccontare, nonsemplicemente produrre e consumareinformazione”. E per far questo nonbisogna rinnegare le origini. Nel testoper la 49a Giornata mondiale delle co-municazioni il Papa giunge a questaconclusione partendo dalla famiglia.Perché, ci dice il Pontefice, la famigliaè il primo luogo dove impariamo a co-municare e a convivere. La famiglia è
al centro diun’approfonditariflessione eccle-siale - con un Si-nodo appenacelebrato e unoconvocato per ilprossimo ottobre- perché il Papavuole ricordare atutti da dove ve-niamo e quantosia importante lafamiglia per la so-cietà.
Un fatto che nessuno mette in di-scussione, anche se l’unità di misuradella nostra vita sembra essere il Pil ei suoi valori. Valori ai quali - sia comesocietà che come individui - spessosacrifichiamo direttamente o indiret-tamente - e forse neppure troppo in-consciamente - proprio quelli dellafamiglia.
Certo, se la famiglia viene vistacome un terreno di battaglie ideolo-giche o di opinione, surrogato deitempi andati delle ideologie, alloranon c’è da meravigliarsi: l’astrazionedel modello cozza con quella realtà diprossimità dove invece si percepisceche altri ci hanno preceduto, ci hannomesso nella condizione di esistere edi generare, di fare qualcosa di belloe di buono.
La famiglia dunque è il luogo pri-vilegiato della comunicazione, dovetutti impariamo cosa significa comu-nicare nell’amore ricevuto e donato.Possiamo dare perché ci hanno dato.Ci hanno amato per primi. È nella fa-miglia che viene in evidenza per laprima volta la dimensione religiosadella comunicazione, l’amore di Dioche si dona a noi e che noi doniamoagli altri.
È in famiglia, che è già società,
Giuseppe Norelligiornalista ex-alunno
UN RACCONTO CREDIBILE
La famiglia è il punto
di riferimento del Messaggio
della 49a Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali.
Nella famiglia impariamo
cosa significa comunicare
nell’amore ricevuto e donato.
UN RACCONTO CREDIBILE
13
I canali dell’informazione non sicontano più: le news ci avvolgonoanche senza i-Phone o tablet,
anche se non siamo connessi. Il di-sarmo non vale, gli schermi ci aspet-tano, inesorabili: in metro, nellebanche, alla posta, alle fermate; conlo schermo dietro l’angolo le notiziec’inseguono.
I sentieri dei media non danno tre-gua: siamo informati, super informati,ma spesso non ci capiamo, o - peggio- non comunichiamo. E lo sappiamo,
magistero

14
magistero
anzi è quella parte di società con cuiveniamo prima a contatto, che si co-mincia a vivere la comunicazionecome scoperta dell’altro. In questapalestra si impara la convivenza, nelledifferenze. Differenze in relazione,differenze generazionali, di genere,etniche, che si accolgono perché co-municando si riconoscono e ricono-scono il vincolo che le unisce. E piùlargo è il ventaglio di queste relazioni,più ricca diventa questa capacità dicomunicarsi e comunicare, più riccodiventa il nostro ambiente di vita.
Naturalmente questo movimentodell’incontro vicendevole, se moti-vato, se vocazionale, se accolto confede non solo vincola, ma comportaun’uscita verso l’esterno. È in questomovimento che si riconosce il respirodi una famiglia che, aprendosi oltre sestessa, comunica la sua comunione, lasua vitalità, la sua gioia di essere, por-tando conforto e speranza anche allefamiglie più ferite. Con capacità diproposte credibili e di avvicinare a uncammino di fede. Facendo crescerecosì la Chiesa stessa, che è famiglia difamiglie.
Bello, ma quante sono le famigliecon queste capacità? Non esiste la fa-
miglia perfetta, ci diceil Papa; ma non bisognaaver paura dell’imper-fezione, del limite; il li-mite come il conflittonon va negato ma af-frontato in maniera co-struttiva.
Una comunicazioneche si logora si puòriannodare e far cre-scere. Nel perdono. Per-ché il perdono è unadinamica di comunica-zione che appartieneproprio alla famiglia,dove - al di là dei limiti- ci si vuole bene. IlPapa indicando unbambino come esempioci indica la strada peressere nella società co-struttori di pace e ri-
conciliazione: imparare ad ascoltaregli altri, parlare in modo rispettoso,esprimendo il proprio punto di vistasenza negare quello altrui. È in questacostruzione che la famiglia, in unmondo dove si parla male, può por-tare una comunicazione di benedi-zione. Anche ritrovando quel silenzio- spesso a torto ignorato - che valo-rizza il contenuto delle parole e che,quindi, non può non far parte inte-grante della comunicazione.
In questa direzionalità della co-municazione, all’interno e versol’esterno, si rende di nuovo possibilequell’incontro ca-pace di non sna-turare l’identitàdi società e fami-glia. Infatti néuna società puòignorare la fami-glia, né questa –che vive se re-spira aprendosioltre se stessa -può pensare di“rinchiudersi neipropri apparta-menti”. Come direcentro e periferia
hanno un senso solo se non ignoranola posizione che non gli appartiene.
Alla luce di queste dinamiche imedia moderni sono un ostacolo sediventano un modo per sottrarsi al-l’ascolto, un volano se lo rendono dinuovo possibile. E anche qui i genitori,insieme alla comunità cristiana che èchiamata ad affiancarli, devono saperinsegnare ai figli “a vivere nell’am-biente comunicativo secondo i criteridella dignità della persona umana edel bene comune”.
Se la famiglia vuole farsi protago-nista della società deve saper comu-nicare – partendo dalla sua storia -“la bellezza e la ricchezza del rap-porto tra uomo e donna, e di quellotra genitori e figli”.
Dobbiamo reimparare a raccon-tare, “l’informazione è importantema non basta”: troppo spesso sem-plifica scivolando verso visioni piùcomode o - peggio - di comodo, co-munque parziali. Lo sguardo d’in-sieme può venire solo daun’autenticità, solo da un coinvolgi-mento delle nostre storie. “Da un sìpronunciato con fede scaturisconoconseguenze che vanno oltre noistessi e si espandono nel mondo” cidice papa Francesco. Così le nostrevite esprimono pienamente il lorovalore perché insostituibili nella vo-cazione che le caratterizza.
È la vocazione che le declina e le ri-conosce in quella trama unitaria chene rende credibile la comunicazione. ◆

riflessioni
Maurizio Dossena,Ex-allievo
“F amilia, seminarium reipu-blicae”: la saggezza oanche semplicemente il
buon senso del mondo antico arrivasino a noi, a confermare questa evi-dentissima realtà che oggi tanta pocasaggezza e tanto poco buon senso -ma anche tanto disordine di carattereetico, politico, culturale - stanno cer-cando – abbondantemente vi sono giàriusciti – di mettere in crisi. “La fami-glia è il motore del mondo e della sto-ria”, ci ricorda paternamente il Papa, e,come precisano alcuni saggi osserva-tori, è, più modestamente, l’ancora disalvezza dell’Italia. Quell’Italia nellaquale diminuiscono a vista d’occhio imatrimoni, aumentano i divorzi, e chemanifesta un immenso problema didenatalità che ne fa il fanalino di codadel mondo per numero di figli perdonna e che già induceva a GiovanniPaolo II la drammatica espressione«suicidio demografico».
Ma ricapitoliamo con ordine i ter-mini di tale complessa riflessione sullafamiglia, visto che dobbiamo inevita-bilmente procedere su due binari pa-ralleli, ancorché coordinati, quellodella degenerazione sociale derivantedallo sfacelo dell’istituzione famigliare– che ne fanno un problema cospicuoper chiunque, cattolici e non, credenti
e non - e quello - per noi di chiaro va-lore aggiunto - della visione cristianadel matrimonio quale sacramento edelle connessioni per quanto concernela cura della Chiesa Cattolica, a livellosia dottrinale sia pastorale, per il valoredi esso e le sue ricadute a livello eccle-siale.
Momento di sensibile diversifica-zione dell’approccio è costituito dallaGaudium et Spes In precedenza, rivol-gendosi ai suoi figli battezzati, laChiesa necessariamente parla diun’economia della grazia radicata nelBattesimo e riversata attraverso il ma-trimonio sacramentale; prima deglianni ’60 le questioni approfondite sonola fedeltà, la fertilità, l’educa-zione cristiana dei figli, tutte ac-compagnate dal richiamo aimezzi classici di santificazione:preghiera e sacramenti e, in par-ticolare, l’eucaristia domenicale.Una certa linea innovativa eragià apparsa con la Casti connu-bii di Pio XI nella (santifica-zione degli sposi).
Familiaris consortio costitui-sce un ulteriore momento dipassaggio di grande portata, percui nel 1981 colui che volevaessere ricordato come il “Papadella famiglia” dotò la Chiesa
degli strumenti necessari per coordi-nare la sua attività pastorale a favoredelle istituzioni del matrimonio e dellafamiglia, un’azione pastorale condottacon intensità da Giovanni Paolo II (esuccessivamente da Benedetto XVI)nella considerazione della famigliacome un ambito di azione pastoraledella Chiesa necessitante di un’ideaadeguata della famiglia stessa e delmatrimonio su cui si basa, per cui,nella necessaria unità di tutti i pa-stori “cum Petro et sub Petro”, si de-termina un’azione autorevole dellaChiesa sulle questioni connesse con lavita della coppia e delle famiglie.Quello di Giovanni Paolo II fu un ma-
Un monito al disincantosu quanto ci circonda
e un invitoad affidarci alla Chiesa
PROTEGGERE LA FAMIGLIAPER DIFENDERE LA SOCIETÀ
15

riflessioni
gistero profetico, che lo vide come ilmigliore interprete del pensiero perso-nalistico, rivolto non a un “uomo”astratto, bensì concretamente storico,creato, caduto nel peccato e poi re-dento da Cristo. “Uomo e donna locreò”, questo il significativo titolo dellecatechesi del Santo Papa sulla “teolo-gia del corpo”, che si basano innanzi-tutto sul fondamentale recupero dellapiena interpretazione delle Scritture, illibro della Genesi prima, i Vangeli poi.Sono i concetti che ritroviamonella Mulieris dignitatem e nei nume-rosi sviluppi che successivamentehanno arricchito l’antropologia teolo-gica, per confermare come il matrimo-nio cristiano abbia quale particolarevocazione quella di esprimere un pocodel mistero che unisce Cristo lo Sposoe la sua Chiesa in un’unione eterna. La“Evangelium vitae” ci ricordò poi ancheche la vita non può essere messa alvoto.
Nel Sinodo del 2012 è stato ben ri-badito che non vi sarà nuova evange-lizzazione senza una forte azionepastorale nella direzione delle famiglie;
Benedetto XVI, in quegli stessi giorniaffermava che “solo nel dono di sèl’uomo raggiunge se stesso, e soloaprendosi all’altro, agli altri, ai figli,alla famiglia, solo lasciandosi plasmarenella sofferenza, egli scopre l’ampiezzadell’essere persona umana. Con il ri-fiuto di questo legame scompaionoanche le figure fondamentali dell’esi-stenza umana: il padre, la madre, il fi-glio; cadono dimensioni essenzialidell’esperienza dell’essere personaumana” “Non si può pensare unanuova evangelizzazione senza sentireuna precisa responsabilità verso l’an-nuncio del Vangelo alle famiglie esenza dare loro sostegno nel compitoeducativo”. La Relatio del recentenuovo Sinodo sulla famiglia insiste sutaluni punti di grande e materna aper-tura della Chiesa: l’ascolto, lo sguardofisso sul Cristo, il confronto alla luce diLui per “discernere le vie con cui rin-novare la Chiesa e la società nel loroimpegno per la famiglia fondata sulmatrimonio tra uomo e donna”: sap-piamo bene quale intenso contrastosia in atto, anche fra le pieghe del Si-
nodo, fra duevisioni, unaprofondamenteradicata sull’in-s egnamen totradizionale delMagistero eun’altra radi-calmente diver-gente (sorvolosulle posizioniintermedie), suquesto non mipronuncio e at-
tendo con fiducia l’ultima parola delSinodo stesso e del Papa.
Se, comunque, da un lato vediamocrescere l’atteggiamento di attenzione,ascolto e comprensione nella dimen-sione pastorale della Chiesa, resta, incampo dottrinale, la fermezza sui prin-cìpi di base, che hanno fatto dire alcardinale Primate d’Italia che “la fami-glia non può essere umiliata e indebo-lita da rappresentazioni similari che inmodo felpato costituiscono un vul-nus progressivo alla sua specifica iden-tità, e che non sono necessarie pertutelare diritti individuali in larga mi-sura già garantiti dall’ordinamento”(2013) e, più recentemente, lo stessostigmatizzare il fatto che “la persona,anziché in relazione con gli altri, [sia]concepita come individuo sciolto dalegami etici e sociali, perchè l’unicacosa che conta diventa la libertà indi-viduale assoluta. Si dice famiglia, masi pensa a qualunque nucleo affettivoa prescindere dal matrimonio […] e daidue generi. Si parla dei figli come sefossero un diritto degli adulti e un og-getto da produrre in laboratorio, anzi-ché un dono da accogliere. In Europasi vuole far dichiarare l’aborto come undiritto fondamentale così da impedirel’obiezione di coscienza, e si spingeperché sia riconosciuto il cosiddettoaborto “post partum”! […] Per questo,se la famiglia è il baricentro esisten-ziale da preservare, l’impegno nellavita sociale è aspetto irrinunciabiledella presenza dei cattolici nel nostroPaese.[…]”: e questo, nel primo riferi-mento del Card.Bagnasco al prossimoconvegno ecclesiale di Firenze “In GesùCristo il nuovo umanesimo”.
Ed è Papa Francesco a monitorarein continuità la centralità della fami-glia e a condannare quella “colonizza-zione ideologica” (Filippine 2015), dallaquale guardarsi e alla quale opporsi, ri-badendo la “fiducia nell’uomo, nontanto in quanto cittadino, né in quantosoggetto economico, ma nell’uomo inquanto persona dotata di una dignitàtrascendente” (al Parlamento Europeo).
E veniamo al lavorìo politico-cultu-rale che sta segando il ramo su cui pog-gia la famiglia naturale e che ha fatto
16

riflessioni
dire agli attivisti in materia che«l’unione civile non è un matrimonio piùbasso, ma la stessa cosa, con un altronome per una questione di realpolitik»,un’affermazione tanto ardita quantotale da disvelare ogni voluto equivocoin materia. I punti di convergenza ever-siva nell’etica sociale sono diversi. Ve-diamoli: innanzittutto il divorzio sprint,che ha visto una maggioranza parla-mentare schiacciante, rispetto allaquale anche le forze che in precedenzaavevano dimostrato “moderazione” inmateria o sono andate sotto o si sonomessi sotto i piedi la coerenza.
La Corte Costituzionale ha dato ilvia libera, in data 9 aprile 2014, alla fe-condazione eterologa, dichiarando an-ticostituzionale la legge 40 del 2004(“tecniche di procreazione medical-mente assistita”) la quale aveva postotaluni paletti, fra cui il veto per l’ete-rologa: non certo una legge cattolica
– che sarebbe stata ben più integralein materia -, ma indubbiamente fruttodella massima convergenza parlamen-tare trasversale allora possibile.
Se, a livello parlamentare, sembraapparentemente dormire il d.d.l. Scal-farotto, per il quale – se rimarrà comeora si presenta – sarebbe conculcata lalibertà costituzionale di affermare lapropria opinione sulle differenze ses-suali e sulla famiglia tradizionale, iprossimi mesi saranno certamente de-terminanti e arriveranno in Parlamentole unioni civili: è il cosiddetto “mariagepour tous”, che maschera di libertà co-stituzionali l’estremo affossamentodella famiglia naturale e la cui propa-ganda (gender) cercherà di penetrareulteriormente anche nelle scuole ( sap-piamo come ci hanno già provato colmateriale UNAR ): è ormai quella “dit-tatura del relativismo” denunciata dalCard. Ratzinger come la caratteristica
del nostro tempo e che ospita qualsiasiposizione culturale tranne quella di chiafferma che ci sono princìpi fonda-mentali per il bene comune.
Certo abbiamo anche forze attivea contrastare tutto ciò: Manif pourtous, Sentinelle in piedi, Il Comitato“Sì alla famiglia” e altri, a cui va datoatto di aver sinora contrastato e ral-lentato tale valanga antiumana, an-tisociale e anticristiana. Il lavorodovrà continuare ad animare il dibat-tito civile, culturale, giornalistico,educativo, scolastico, certi, da un lato,della fondatezza del diritto naturale edella legge naturale quale leggecreata da Dio; consapevoli, dall’altro,di quanto ci insegna il Papa con il suo“rifiuto per ogni tipo di sperimenta-zione educativa con i bambini” e conil suo “sostegno al diritto dei genitoriall’educazione morale e religiosa deipropri figli.” ◆
Un santo che ho sempre ammirato per la sua umanità, per il suo equilibrio e per il suo coraggio è sanTommaso Moro. Scrittore e politico cattolico (Utopia la sua opera più famosa), da buon inglese ap-prezzava molto il senso dell’umorismo. Perfino sul patibolo, al boia incaricato di decapitarlo dice: “Sta’attento: il mio collo è corto. Vedi di non sbagliare il colpo. Ne andrebbe della tua reputazione”. Durantela sua prigionia, scrisse numerose preghiere, tra cui: “Signore, donami una buona digestione e anchequalcosa da digerire”, oppure,“Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla”.E ancora: “Dammi il dono di saper ridere di una facezia, di saper cavare qualche gioia dalla vita e anchedi farne partecipi gli altri. Signore dammi il dono dell’umorismo” (Tommaso Moro, 1587, Preghieredella Torre). Da grande umanista riusciva a cogliere la grandezza dell’uomo anche nei suoi limiti, dalmomento che l’uomo è la creatura più amata da Dio. “Dammi Signore, un’anima che abbia occhi perla bellezza e la purezza, che non si lasci impaurire dal peccato e che sappia raddrizzare le situazioni.Dammi un’anima che non conosca noie, fastidi, mormorazioni, sospiri, lamenti. Non permettere chemi preoccupi eccessivamente di quella cosa invadente che chiamo io”. Quando nel 2000 papa GiovanniPaolo II lo ha proclamato patrono dei governanti e dei politici, ha considerato di lui, oltre all’eroismonell’affrontare la morte pur di non tradire la fede e le sue convinzioni religiose, anche il suo senso deldovere. Con realismo, il nostro santo si è impegnato, nel suo onesto servizio allo Stato, a cambiarequello che era possibile migliorare, a distinguere quello che poteva essere migliorato da tutto il resto,a riconoscere gli aspetti positivi della vita sia da un punto di vista etico che estetico, infine, a pensaresempre in modo positivo. Un’altra sua preghiera, ricca di tanta saggezza e umiltà, recita così: “Signoredammi la forza di cambiare le cose che posso modificare e la pazienza di accettare quelle che nonposso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza tra le une e le altre”.
The dreamer
SestanteIL SENSO DELL’UMORISMO NEL PATRONO DEI POLITICI
17
IL SENSO DELL’UMORISMO NEL PATRONO DEI POLITICI

considerazioni
stro Paese è diffusa o è molto diffusa.Il fenomeno è ancora più accentuato
tra i politici. Le conseguenzesono un crescente indeboli-mento del senso etico e unegoismo accentuato. Il Ban-comat della politica sono legrandi opere che sforano ab-bondantemente i preventivi ele casseforti opache e antide-mocratiche sono le Fonda-zioni. Una specie di teatroeterno dove ognuno recita lasua parte mentre gli spetta-tori si distraggono. A un par-lamentare, a un dirigente dipartito, a un ministro non ba-
stano più un ottimo stipendio e legratificazioni connesse all’incarico.Vuol vivere come i personaggi chefrequenta.
La rottamazione risulta fasulla neiterritori dove in occasione delle pros-sime regionali tutto rimarrà salda-mente nelle mani callose dellevecchie consorterie elettorali. La sin-drome del segno più ha contagiato
18
brano i più attivi del globo. Annuncisu annunci, promesse di leggi, masolo promesse, riforme garantitecome se piovesse. Insomma un granblaterare. Da quando Cottarelli se n’èandato, la cosiddetta “spending re-view” pare totalmente dimenticata.La crisi di questi anni ha aumentatole tensioni sociali e la politica è di-
ventata troppo ingorda. “Per fortunapensare è ancora gratis, ma tra poco,scatteranno gli aumenti. Sbrigatevi afarlo!”.
Si è persa la fiducia nella politica.Per la gente trovare un politico onestoin Italia è un po’ come andare in Gro-enlandia per abbronzarsi. Secondouna recente indagine condotta dallaMakno, il 98% degli Italiani intervi-stati ritiene che la corruzione nel no-
Cari lettori, dopo due mesi passati alla“revisione” per poter far girare libera-mente e senza attriti le mie rotelline“ingrippate”, questa volta, credo che,per voi, sarà tosto virare oltre la boadella prima colonna, perché il pen-siero si è arruffato e incartato, impri-gionato dalle abitudini calde erassicuranti di una vita, calde e rassi-curanti come vecchie cia-batte e la scrittura èdiventata poco fluida, am-messo che prima lo fosse. Idecenni volano ma sonocerte giornate in ospedaleche non passano mai! Noncredo che si possa tornareindietro, premendo CANCsulla tastiera della propriamemoria. Ho imparato,però, che nella profonditàdell’inverno dentro di noic’è un’estate invincibile diun celeste primaverile con qualchenuvoletta di bambagia bianca. Dionon gioca a dadi, tiene il banco. Anzise lo vuoi far ridere raccontagli deituoi progetti, imprigionati dalle abi-tudini di una vita.
Visto che parliamo di confusione,è d’obbligo parlare dei nostri gover-nanti. Governanti che, a parole, sem-
Lorenzo Filippi, Fscopinionista
Il balletto della politica
Gli italiani assistonoimpotenti al balletto della politica,ai litigi dei politici,alle loro infinite lungaggini,a rottamazioni solo annunciate;intanto gli onestipagano le tasseanche per gli evasori disonestie la criminalità continuaad avere una corsia preferenziale.

considerazioni
19
ogni atto di questo Governo, tanto daritenere che la corruzione si possa co-modamente combattere aumentandole pene o allungando le prescrizioni.L’effetto “cipria” si rintraccia facil-mente sullo stato purulento della giu-stizia italiana, con l’illusione che conl’aumento delle pene e una spennel-lata di cipria tutto sarà aggiustato.
In nessuno stato moderno si for-merebbero partiti per i giudici o con-tro i giudici, plastica dimostrazioneche la certezza di giustizia in questopaese è una chimera. In Italia, novefurti su dieci rimangono impuniti masolo perché le forze dell’ordine nonacciuffano i malfattori, non perché imalfattori pensano di cavarsela conpene irrisorie. L’aumento delle pene è
quindi una solenne presa in giro. Imagistrati sono brave persone che ti-rano avanti in strutture a cui mancaquasi tutto. È vero purtroppo che al-cuni cadono nel protagonismo: sareb-bero capaci di riaprire un fascicolo perla morte di Giulio Cesare.
Per i politici la realtà supera digran lunga la fantasia. Gran villa vistamare come l’industriale, le disponibi-lità finanziarie di un banchiere, la po-polarità di un calciatore, l’influenza diun intellettuale. Vogliono tutto. Sonoimprevedibili ma amano la routine. Ecosì un cinico politicante viene fattopassare per uno statista di alto li-gnaggio. Riesce a grattugiare un mo-
ralismo buono per qualsiasi tipo dimaccherone. I suoi sostenitori invecedi allarmarsi, glielo concedono. Moltecose sono state dette, dopo la scaricadi inchieste, arresti negli ultimi anniriguardo la ricostruzione post-terre-moto, l’eolico, la Maddalena, la sanitàlombarda, le banche, l’Expo, il Mose,Mafia Capitale, grandi infrastrutture.Sono partiti corposi ordini di custodiacautelare (sono sempre corposi gli or-dini di custodia cautelare mai anores-sici).
In Italia abbiamo troppe leggi incircolo e sono diventate più imper-scrutabili dei disegni divini. Spesso siricorre ai decreti legge per l’urgenza.Tuttavia questa viene contraddettadalle doglie interminabili con cui
nasce un prov-vedimento, peresempio, il de-creto sblocca-Italia deciso afine agosto maricevuto in Qui-rinale a metàsettembre; il de-creto sullabuona scuolatenuto in nafta-lina per moltotempo.
Nel frat-tempo accadeche i ministri ra-dunati nel Con-
siglio votino non sul testo scritto,bensì “salvo intese”, e gli altri ministriannuncino modifiche a norme inesi-stenti, perché non sono ancora ema-nate dal Capo dello Stato. E glistudenti scendono in piazza contro labuona scuola, pur essendo una ri-forma senza forma. La riforma dellascuola, uno dei fiori all’occhiello del-l’esecutivo, si sta arenando tra prote-ste di piazza e annunci di sciopero,oscillazioni e modifiche continue daparte dello stesso Governo. In chi sioppone al progetto di riforma, tor-nano vecchi atteggiamenti sindacalidagli slogan evergreen contro “l’at-tacco alla scuola pubblica”, alla diffi-
denza verso ogni cultura della valu-tazione (intanto, è indicativo che losciopero dei sindacati della scuola siastato fissato per il 5 maggio, giornoin cui nelle scuole Primarie dovevanotenersi le prove Invalsi).
Appena arrivato a palazzo Chigi ilPresidente del Consiglio aveva giusta-mente annunziato un piano di lavoriedilizi per la messa in sicurezza dellescuole; ma è stato fatto poco o nulla.
Poi tutta “la buona scuola” è sem-brata riassorbita dalla questione del-l’assunzione dei precari, quasi 150mila, poi 100 mila, poi chi sa. Con-temporaneamente si è sostenutoqualcosa che va contro una logicaelementare. Su strade lastricate didossi, e per lo più sono dossi sconclu-sionati, uno vince e l’altro perde. È lavita, ma nella vita politica italianapuò succedere che perdano tutti, nes-suno escluso. Durante una dei suoi ul-timi annunci, Renzi ci ha informatiche entro cinque anni la “Sua” ri-forma, che ancora non c’è, sarà co-piata. L’impeto di segnare un goalnella porta avversaria genera spessodelle capriole logiche. Così ciclica-mente il Governo annunzia un lietoevento, appende un fiocco rosa sul-l’uscio di Palazzo Chigi e poi… sivedrà…! I Nostri politici, in questo,sono campioni del mondo nell’arte diarrangiarsi. Tutto sta a vedere chibrandirà il bisturi che asporteràl’enorme bubbone che sta deva-stando, corrodendone gli organi vitali,uno Stato cui di vitale sono rimastesolo le correnti dei numerosi partiti ele tangenti per sovvenzionarli.
Quando dissero al Cancelliere te-desco K. Adenanauer, che aveva vintole elezioni politiche con due soli votidi maggioranza, rispose: ”Uno è ditroppo” e poté governare tranquilla-mente e risollevare la Germaniauscita distrutta dalla guerra. Da noinon si governa, neanche con unamaggioranza assoluta, figuriamoci.Perciò per gli Italiani la politica è im-pedire alla gente di occuparsi di ciòche la riguarda; è l’arte di mentire,avendo l’aria di dire la verità; i politici

considerazioni
predicano l’acqua e poi bevono vino.La politica è l’arte di costruire pontilà dove non ci sono fiumi; dicono chesono pacifisti e poi per una stupidag-gine litigano con il vicino, dicono pa-role d’oro seguite da fatti di piombo.La politica è l’arte di sbarcare il luna-rio a spese dei cittadini creduloni chevotano.
In un’intervista di tanto tempo fa,l’allora Segretario di Stato USA, HenryKissinger dichiarò che avrebbe visi-tato l’Italia e incontrato il Presidentee il Governo per parlare di alcuni pro-blemi impellenti, avrebbe parlato ditutto meno che di politica, perchéquella italiana era per lui troppo dif-ficile da capire. Eppure era conside-rato un uomo intelligente e brillante.Ma, a distanza di anni, vogliamo ras-sicurarlo. A non capire la politica ita-liana sono in tanti compresi i 60milioni di Italiani, più quelli che lafanno. Anzi, molti si domandanocome sia possibile che ogni giorno sirinnovi il miracolo di un Paese che so-pravvive a se stesso. Prendiamo latanto sbandierata “Spending review”.
Il Governo ha dimo-strato che i tagli li hafatti ma con le forbicispuntate. A cominciaredal giuramento del Go-verno: una suggestiva eaffollata cerimonia deinuovi Sottosegretarisvoltasi, per ragioni dispazio, allo Stadio Olim-pico. Ai Ministri senzaportafoglio sono stati as-segnati dei Sottosegre-
tari senza portamonete, il che vuoleessere un modesto ma significativoavvio all’auspicato taglio alla spesapubblica secondo i meccanismi delCodice Cencelli che regola la compo-sizione del Governo. Il suddetto Co-dice prevede un minuzioso dosaggionon per soddisfare i cittadini, ma peril pluralismo e la completezza degliappetiti dei tanti deputati, dei tantipartiti e delle tante correnti, tutti de-vono essere rappresentati. Come pureè difficile capire l’applicazione dellalegge Severino: Maurizio Lupi, Mini-stro della Repubblica non indagato,dimesso; Vincenzo De Luca, candidatoa Governatore della Campania, con-dannato in primo grado per abusod’ufficio, non dimesso; Francesca Bar-racciu, indagata, candidata governa-tore della Sardegna, dimessa, poipromossa sottosegretario. Potremmocontinuare senza sforzi a mettere infila le contraddizioni palesi sui capi-toli come welfare, spending review,giustizia, politica industriale, sicu-rezza interna, politica internazionale.
La parola, non basta più, c’è tanto
malessere. Le percentuali che segna-lano il malessere sono l’input per in-dicare linee d’azione, nellaconvinzione che le forme repressiveda sole non bastano. Ecco allora l’in-dicazione del rafforzamento del si-stema etico di valori e gli elementi sucui puntare: da un lato i media (per lacapacità di costruire una cultura delleresponsabilità) e i giovani (tocca aloro infrangere le cattive abitudini).La cesura con il passato e l’avvio diuna fase virtuosa, non solo deve es-sere favorita dalla cultura ma deveessere messa decisamente al centro.È la leva da attivare per risollevarsidalla crisi economica. Il futuro auspi-cabile e possibile dovrà passare attra-verso la formazione di una nuovaclasse dirigente, ma anche da unaconsapevolezza più diffusa, da unarinnovata etica che spazzi via frasi deltipo: ”Si è sempre fatto così”, per eli-minare anche quel paradosso eviden-ziato dal confronto tra nazioni, doveproprio l’Italia e la Grecia, che pos-sono vantare un patrimonio culturaleimponente, sono le prime a frustarnel’accesso e la fruizione.
Concludo con un sorriso. Alcunistudiosi della storia dell’arte sono fi-nalmente riusciti a spiegare il miste-rioso sorriso della Gioconda. Hannodetto: ”Visto quello che succede inItalia è contenta di essere emigrataper tempo!”. ◆
LASALLIANI IN ITALIA ringrazia gli amici sostenitori
Marasi Liliana - Gino Lucchi - Ramella BernardoFamiglia Pennacchio - Maiorano Antonio - Strona RinaldoDeodati Fratel Silvestro - Servino Mario - Foschini FilippoViganò Pier Gaetano - Paleari Maurizio - Pipitone Giorgio
Andronici Francesca - Mastrecchia Adriano - Chessa FrancescaFerrero Sergio - Sacchi Maddalena - Del Ferraro Arnaldo
Berghenti Maria Teresa - Vivelli Franca - Bovone ArnaldoFogliano Ugo - Famiglia Marcucci - Papacchini Fausto
Cursi Cesare - Napoli Roberto - Mazzarella Aldo
20

notizie
21
Il Consiglio Internazionale deiGiovani Lasalliani (ICYL) si èriunito a Roma tra il 16 e il 20febbraio scorso. È stato il 19° incontro del ICYLdalla sua fondazione, 12 anni fa.L’obiettivo primario dell’in-contro è stato quello di arti-colare e definire un pianostrategico per lo sviluppo delMovimento dei Giovani Lasal-liani nel corso dei prossimi 5-6 anni.Per raggiungere questoobiettivo, l’ICYL ha studiato eanalizzato le relazioni deiquattro incontri Lasalliani in-ternazionali svoltisi tra mag-gio 2013 e giugno 2014:Educatori Lasalliani e ammini-
stratori; Giovani fratelli; Gio-vani Lasalliani; Fratelli ditutto l’Istituto da tutto ilmondo. Ogni assemblea haavuto l’intento di valutare leesigenze attuali della Mis-sione Educativa Lasalliana epreparare il futuro. Nel corsodella riflessione, l’ ICYL ha in-dividuato riferimenti e impli-cazioni per il gruppo cherappresenta, cioè, gli adole-scenti e i giovani adulti nellaMissione Educativa Lasal-liana.Nel corso della settimana, iConsiglieri ICYL hanno anchetenuto alcuni incontri con ilConsiglio generale, con i re-sponsabili dei vari servizi e uf-
fici della Casa Generalizia econ il Superiore Generale. Gliincontri hanno permesso al-l’ICYL di condividere i pro-getti preliminari e, al tempostesso, capire in che modoquesti si completano conquelli degli altri servizi egruppi dell’Istituto e della Fa-miglia Lasalliana.
ROMA
Casa GeneraliziaConsiglio Internazionale dei Giovani Lasalliani
Casa GeneraliziaVisita del Cardinale Berhaneyesus Demerew Souraphiel
Fresco di nomina il Cardinale Berhaneyesus Demerew Souraphiel,Arcivescovo di Addis Abeba, giovedì 19 febbraio è andato allaCasa Generalizia per una visita al Superiore Generale. Si è fer-mato poi a pranzo con la Comunità. Al termine ha preso la pa-rola ricordando con calore e riconoscenza gli anni passati allascuola dei Fratelli. Ha concluso con espressioni di apprezzamentoe gratitudine per l’opera che i Fratelli e i loro collaboratori svol-gono ora in Addis Abeba.

22
notizie
Il 22 marzo, un centinaiodi persone hanno parte-cipato al rito di ammis-sione di sei giovani al
postulantato e di sette al no-viziato. La celebrazione euca-ristica si è svolta nellacappella di San José di UniLa-
Salle a Canoas/RS e hannopartecipato Fratelli, soggettiin formazione, familiari eamici.La gioiosa celebrazione eu-caristica, che ha avuto comecelebrante Padre Adelino Pi-lonetto, è stata animata daicanti diretti dal professorEdson e da due postulantidel 3° anno. È stato un mo-mento intenso e significativoche ha segnato due impor-tanti tappe del cammino diformazione che porta a es-sere Fratelli delle Scuole Cri-stiane.
BRASILE
Rito di ammissione al postulantato e al noviziato
Come ogni anno, durante laSettimana Santa, fino algiorno di Pasqua, i Fratelli e igiovani in formazione di Haiti
si spargono per le varie cittàper condividere la fede, lavita e l’impegno con le variecomunità cristiane, special-
mente dove la presenza di unsacerdote non è sempre pos-sibile.Con lo slogan “Missione Pa-squa 2015: Con i consacraticelebriamo con gioia il Cristorisorto”, dopo un incontro dipreparazione e con le paroled’incoraggiamento del Fra-tello Paul Wallinx, responsa-bile del settore, il gruppoformato da 16 aspiranti, 8 po-stulanti e 6 giovani Fratelli,ha dato inizio alla missione,animando le attività e le cele-brazioni liturgiche dei varigiorni. L’organizzazione èstata coordinata dal gruppodi Pastorale Vocazionale.
HAITII Fratelli e i giovani in missione

notizie
23
Dio Chiama quando vuole
Si è svolto l’Incontro Vocazio-nale Univeristario in una casadi ritiri a Iztapalapa a Cittàdel Messico.L’incontro è stato una grandeopportunità per i giovani par-tecipanti di incontrare Dio efare domande sui progetti divita e sulla sua volontà. Coloroche hanno partecipato hannovissuto intensamente, in unospirito di dialogo e di aperturanel vedere e riconoscere i se-gni di Dio nella nostra vita,nella nostra storia, nei nostripiani attuali e futuri.Allo stesso tempo, i responsabilidella Pastorale Vocazionale ci
hanno riempito di speranza, sa-pendo che Dio continua a chia-mare, e lo fa in diversi momentidella vita.La situazione e il cammino diogni giovane sono molto di-versi, e non possiamo fare ge-neralizzazioni sulle condizioniumane e spirituali, che circon-dano una chiamata vocazio-nale per essere un Fratello oun altro tipo di chiamata, cheDio fa ad ogni giovane cheha già scelto una opzioneprofessionale che impegna ilsuo progetto di vita, peròche osa chiedermi se ci po-trebbe essere qualcos’altro.Siamo sicuri che questo per-
corso della cultura professio-nale a livello universitario èsolo all’inizio; ciò può dipen-dere da quello che ognuno dinoi deciderà di fare.
Incontro Vocazionale Universitario
Sono 250 le Suore Guadalu-pane nel mondo, donne chehanno deciso di dedicare laloro vita ai più poveri tra i po-veri. Lo fanno seguendo lostile di San Giovanni Battistade La Salle. La loro presenzafino ad ora è in 11 Paesi delmondo. In Madagascar, sonopresenti da 25 anni. Fin dalloro arrivo hanno ricevuto ri-chieste da parte di giovaniche desideravano entrare afar parte della loro famigliareligiosa.Le prime due Suore Guada-lupane de La Salle sono arri-vate nell’isola malgascia dalMessico nel 1991. Da allorala loro crescita non si è maifermata, come anche la loro
collaborazione con i Fratellidelle Scuole Cristiane, pre-senti in Madagascar da quasi150 anni. Oggi vi sono 48Suore indigene, raggruppatein 8 comunità distribuite in 6
diocesi. Esse dirigono 6scuole e aiutano in altret-tante parrocchie, oltre a cu-rare il santuario del BeatoFratel Raffaele Rafiringa inAntananarivo.
La presenza delle Suore Guadalupane de La Salle
MESSICO
MADAGASCAR

notizie
La Regola (120c) consente alSuperiore di aggiungere unoo due nuovi membri al Consi-glio Generale. Nel corso della sessione ple-naria del mese scorso, il Con-siglio Generale ha preparatola Circolare 470, Verso l’Anno2021, che traccia i piani e gliobiettivi per l’Istituto, in baseal mandato conferito dal 45°Capitolo Generale. Si è po-tuto verificare che le aree dicui c’è necessità sono: la pa-storale vocazionale, in parti-colare la vita dei Fratelli,
l’accompagnamento dei varigruppi all’interno della Fami-glia Lasalliana e la presenzaal Consiglio di un Fratellodella Regione con la piùgrande concentrazione diFratelli, molti dei quali avanticon gli anni: RELEM. In con-formità a queste aree di biso-gno, il Superiore Generale hanominato Fratel RafaelMatas Consigliere Generale.Fratel Rafael è stato dele-gato al 45° Capitolo Gene-rale. Attualmente èimpegnato in Haiti. Come
tutti i Consiglieri Generali,assisterà il Superiore Gene-rale nel governo e nell’ani-mazione dell’Istituto.
ROMA
Fratel Rafael Matas nominato Consigliere Generale
Fratel MUZIANOIl Fratello dell�obbedienzaLuigi Giuseppe Viaux nasce in Belgio nel 1841. A 15 anni entra nella Con-gregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, inizia il Noviziato, prende ilnome di Fratel Muziano e a 18 anni gli affidano una classe a Malonne, inun grande collegio. Ma Fratel Muziano è giovane e inesperto e fallisce. Isuperiori pensano sia meglio, per il buon nome del collegio, chiedere aFratel Muziano di lasciare la Congregazione. Lo salva un confratello, FratelMassenzio, che riesce a intravedere le doti spirituali di quel “maestro fal-lito”. Questi, da un giorno all’altro, lo trasforma da insegnante in assistentedi musica e disegno, anche se non sono materie per le quali Muziano sentaparticolari predisposizioni. Questo incarico lo svolge per 50 anni, umil-
mente e docilmente. Quando gli diranno di iniziare a suonare l’armonium, Muziano comincia a eserci-tarsi sulla tastiera con tenacia e umiltà fino a diventare insegnante di musica agli alunni delle Magistrali.E questo fino alla morte. Impara anche a suonare il flauto, il pianoforte, il contrabbasso. Insomma, isuperiori ordinano e Fratel Muziano obbedisce sempre, anche quando gli affidano di suonare la cam-panella ogni mattina alle 4 e trenta. Assolve al compito con puntualità invidiabile per 58 anni, fino adue giorni prima della morte: solo quel giorno i confratelli si accorgono del servizio umile che egli hasvolto con assoluta fedeltà. Ogni giorno, dalle 9 alle 10, fino a 75 anni suonati, si esercita all’harmonium,secondo l’ordine ricevuto 55 anni prima; così l’assistenza dei ragazzi nel cortile, come gli è stato ordi-nato. Fratel Muziano è stato uno che ha fatto dell’obbedienza un modo per capire la volontà di Dio,verificandola ogni mattina in ginocchio davanti al tabernacolo. Muore il 30 gennaio 1917 e già da quelgiorno si segnalano miracoli ottenuti per sua intercessione. Paolo VI lo beatifica nel 1977 e GiovanniPaolo II lo proclama santo nel 1989.
24

FRATEL MUZIANO, IL FRATELLO CHE OBBEDIVA SEMPREdisegni di Carla Pollastri testi di Mario Chiarapini, Fsc
25
Il parroco del paese glisuggerisce di entrare nellaCongregazione dei Fratellidelle Scuole Cristiane e cosìLuigi Giuseppe, a Pasqua del1856, entra al Noviziato deiFratelli a Namur e il 1° lugliodello stesso anno, nellacerimonia della Vestizionereligiosa, prende il nome diFratel Muziano.
Si impegna molto nel suocammino formativo e fa lesue prime esperienzedidattiche. Insegna aibambini più piccoli prima aNamur poi a Chimay.
In quegli anni, in Belgio, sisviluppa un violentomovimento contro la Chiesa ele scuole cristiane; malgradotutto, le scuole dei Fratellihanno ovunque un grandesuccesso. Fratel Muziano vienetrasferito all’istituto SanBerthuin di Malonne il 6settembre 1859.
“Andiamo in chiesa a pregare! ”.È Luigi Giuseppe, il figlio del fabbro di Mellet, cheinvita i suoi compagni. Luigi è destinato a fare ilfabbro, ma sente dentro di sé una chiamata par-ticolare.

Nel grande istituto viene incaricato diinsegnare in una classe piuttostoturbolenta. Fratel Muziano non hasuccesso, si dimostra incapace di ottenerela disciplina.
Il direttore della scuola è costretto asollevarlo dall’incarico e qualcuno vor-rebbe addirittura che lasciasse la Con-gregazione perché inadatto all’inse-gnamento.La decisione viene messa ai voti cherisultano propendere per l’uscita dal-l’Istituto di Fratel Muziano.
Fratel Massenzio, al quale non era sfuggitala grande bontà e religiosità di FratelMuziano, convince la comunità di affidargliil giovane Fratello per destinarlo ad altriincarichi e per prendersi cura di lui.
Su suggerimento del suo tutore, FratelMuziano si assume l’incarico dellasorveglianza dei ragazzi e di insegnare asuonare l’harmonium, il pianoforte e ilflauto; ma prima di tutto si impegnapersonalmente a imparare prima lui asuonarli.
26

Nel 1860 Fratel Muziano chiede di tenereil catechismo ai ragazzi del paese. Egli è at-tento ai più piccoli, ai più deboli e ai piùpoveri.
Nel 1868, a Fratel Muziano muore lamadre. L’anno successivo, quando siconsacrerà definitivamente alSignore con la Professioneperpetua, gli muore anche il padre.
Gli anni passano e la vita di Fratel Muziano ècontrassegnata dal lavoro e dalla preghiera, oltre che datanta umiltà e pronta obbedienza. Ogni giorno va arecitare il Rosario davanti alla grotta della Madonna.Tutti lo chiamano il “Fratello del Rosario” e anche il“Fratello che prega sempre”.
Nel 1880 a Fratel Muziano viene affidato il corso di dise-gno tecnico che terrà per quattordici anni. Gli alunni sonoentusiasti del suo insegnamento.
27

Quando qualcuno cerca Fratel Muziano, sa di trovarlo inchiesa a pregare. Si alza anche di notte a fare un’ora diadorazione davanti al tabernacolo.
Tra gli altri incarichi, Fratel Muziano ha anchequello della sorveglianza durante le ricreazionidei ragazzi. È sempre puntuale e svolgel’incarico anche in pieno inverno quando fatanto freddo.
28
Nel 1914, scoppia la Prima Guerra Mondiale e ilBelgio è invaso dalle truppe tedesche. L’istituto SanBerthuin viene requisito dall’esercito. In questotempo di angoscia, Fratel Muziano ha la gioia divedere un suo nipote farsi Fratello e un altrodiventare sacerdote.
Superati i settant’anni di età, FratelMuziano si indebolisce sempre dipiù. Soffre di reumatismi e dicontinue emicranie, ma fino alla finevuole essere fedele alla Regola e nonmanca a nessuno dei suoi incarichi.A un certo punto è costretto amettersi a letto. Continua a pregareogni momento e, in preghiera, losorprende la morte il mattino del 30gennaio 1917.

notizie
Papa Francesco ha scelto Pom-pei come prima tappa del viag-gio a Napoli dove si è rivoltoalla Vergine Maria pronun-ciando la “piccola supplica”. Inun momento della visita aPompei (sabato 21 marzo),Papa Francesco si è intratte-nuto per qualche istante conFratel Mauro Spinelli, Direttoredell’Istituto Bartolo Longo.
POMPEI
Fratel Robert Schieler ha ef-fettuato la sua prima visitapastorale alla Regione PARC.Ha iniziato con le istituzionidi Singapore incontrando indue momenti i Fratelli delleotto scuole ivi esistenti, in-
trattenendosi con loro e in-formandosi sui modi di dire-zione dei vari complessi. Hachiesto informazioni partico-lari al riguardo della “La SalleHope House”.Ha insistito molto sulla neces-sità di essere innovativi nel-l’insegnamento e zelanti nelpromuovere la vocazione del“Fratello”. Ha anche sottoli-neato l’importanza di fornireun insegnamento lasallianodi qualità, con programmi ri-volti in particolare agli ultimi,ai dimenticati e ai poveri.Fratel Robert Schieler ha in-contrato anche diversi gruppi
di giovani. I gruppi lasallianisono molto cresciuti in questiultimi anni, hanno creato unarete e partecipano alla mis-sione lasalliana prestandoservizi nel campo dell’appren-dimento e del volontariatosia nella città di Singaporeche fuori di essa..
SINGAPOREVisita Pastorale del Fratello Superiore Generale
Lunedì 13 aprile a Torino hapreso il via la mensa serale(“merenda sinoira” per i pie-montesi) per i senza tetto.Sarà aperta 365/366 giorniall’anno. Un progetto che
vede coinvolti i Fratelli, ilGruppo Arco, la Caritas dioce-sana, l’associazione MariaMadre della Provvidenza. Èuna concreta risposta all’in-vito di papa Francesco ad
unire le forze per risponderealle nuove povertà. È una ri-sposta originale, diversa daaltre presenti sul territorio. Èl’inizio di un cammino che ciauguriamo lungo e fruttuoso.
TORINOMensa serale dei poveri
29

30
notizie
Nell’ultima sessione plenaria,il Consiglio Comunale ha ap-provato l’assegnazione dimedaglie d’oro per ricono-scere personalità del mondodello sport, della gastrono-mia, della cultura e dellascienza e il loro ruolo nellacittà.La Fondazione Università eTecnologia La Salle riceverà laMedaglia d’Oro al Merito
Scientifico per i suoi 50anni di lavoro preziosonello sviluppo scientifico etecnico, nonché per le co-noscenze pratiche nei set-tori di Ingegneria,Gestione, Architettura ealtre discipline.Quest’anno La Salle Cam-pus di Barcellona-URL fe-steggia il 50° anniversario dellancio della prima Scuola Uni-
versitaria di Telecomunica-zioni di Catalogna, creata nel1965.
SPAGNALa Salle - URL riceve la Medaglia d’Oro al Merito Scientifico
della città di Barcellona
È un progetto che è statocreato per aiutare a miglio-rare l’infrastruttura di basedel Sud Sudan, in partena-riato con la Chiesa Cattolicalocale, per il popolo di questopaese attraverso la creazionee lo sviluppo della forma-zione di insegnanti, operatorisanitari e la prestazione diservizi pastorali per sostenerela Chiesa locale.“La situazione nel Sud Sudanè migliorata, ci dice Fratel Jo-seph Alak Deng, durante il
mio terzo anno di servizio, inparticolare ad Agok e nellaregione di Abyei. Ciò che at-tualmente mi motiva, è es-sere utile nell’aiutare ilpopolo del Sud Sudan. Al mo-mento la questione della sicu-rezza non è una delle miepreoccupazioni, anche se al-cuni membri del SSS hannolasciato il paese per questo.Le comunità SSS situate nellecittà si trovano vicine a par-rocchie e seminari”.Queste comunità religiose of-frono uno spazio di preghierae di vita comunitaria; cioè,forniscono un’atmosfera pro-pizia per qualunque personareligiosa.I membri di SSS sono religiosidi diverse congregazioni, ma-schili e femminili, e di diversenazionalità e culture.Ognuna di queste congrega-zioni ha inviato alcuni deipropri membri, tre o quattro,per un servizio a seconda del
proprio carisma. Attual-mente, i Fratelli delle ScuoleCristiane sono tre.Solidarietà con il Sud Sudan(SSS) si è impegnata in trecampi: l’istruzione, la salute ela pastorale dei giovani edelle donne. Due dei centri diformazione di SSS formanoinsegnanti, ma l’unico centroche funziona attualmente è aYambio, perché a Malakal lescuole sono state distruttedurante la guerra dello scorsoanno. Esiste anche un centrodi formazione di infermieri ediversi centri pastorali per igiovani e l’emancipazionedelle donne.
SUD SUDANSolidarietà con il Sud Sudan (SSS)

notizie
31
Lunedì 30 marzo 2015 si èsvolto il 6° Trofeo Fratel Ro-berto Roberti, torneo di calcioa 8 per gli alunni dellescuolesecondarie e di calcio a 5 perquelli delle primarie, riservatoagli istituti lasalliani. Comenelle precedenti edizioni, aospitare l’iniziativa è stata lascuola S. G. B. de La Salle divia Pagano, i cui splendidicampi immersi nel verde sonostati “calpestati” da circa 170atleti. Si sono sfidati con en-tusiasmo, lealtà e sana com-
petizione gli alunnidi Villa Flaminia,Colle La Salle, StellaPolare (parrocchiaLa Salle), Pio XII e LaSalle; inoltre, per laprima volta nellastoria di questo tro-feo, hanno parteci-pato anche duesquadre composteinteramente dabambine, La Salle eVilla Flaminia. Vinci-trice assoluta, con accordo
unanime, è statal’amicizia.
Il fischio di inizioè stato per tuttialle ore 9.00.Spalmate suquattro campi, sisono disputate 40partite, permet-tendo ai piccolicalciatori di alter-nare alla tensioneagonistica mo-menti di svago.
Anche il sole, dopo un avvioincerto, ha deciso di illumi-nare i partecipanti e di ren-dere migliore una giornatasportiva che non ha deluso leaspettative del pubblico, de-gli insegnanti di educazionemotoria e dei ragazzi coin-volti. Tutti i giocatori sonostati premiati con un’ele-gante pergamena che ripor-tava la foto ricordo della pro-pria squadra.
Chiara Lai,docente lasalliana
ROMA6° TROFEO FRATEL ROBERTO ROBERTI
Il XX Congresso dell’ASSEDIL (8 -11 aprile) ha visto la partecipa-zione di 128 membri, delegati eospiti riuniti sotto il tema:L’identità lasalliana: una forzaper la nostra scuola.Da sottolineare l’intervento di
fratel Jean-François Morlier che,ricordando gli inizi dell’ASSEDIL,ha presentato le intuizioni dellasua fondazione e l’evoluzionedelle fasi iniziali.
Il Consigliere Generale Fratel
Aidan Kilty, nel suo discorso, hasottolineato il ruolo chiave dellaleadership nella costruzione diuna comunità educativa lasal-liana spesso senza la presenzadei Fratelli.
IRLANDAXX Congresso ASSEDIL

32
notizie
Rinnovo quadriennale della di-rigenza nazionale per la Con-federex (Confederazione As-sociazioni Ex allievi ScuoleCattoliche), nel corso di un re-cente convegno (10-11-12aprile 2015) ad Abano Terme(PD) sul tema“Famiglia prota-gonista nellascelta della li-bertà educativa”.
Il cambio dellaguardia al verticedell’Associazioneriguarda la nuovapresidenza nazio-nale da ClaudioAndreoli (Padova,Fratelli Scuole Cri-stiane) a LilianaBeriozza (Milano,Dorotee). Vice-Presidenti desi-gnati sono: Michele Panajotti(Chioggia VE, Salesiani), Ros-sella Scarpitti (Roma, SacroCuore) e Maurizio Dossena(Piacenza, Fratelli Scuole Cri-stiane). Rinnovate anche le al-tre cariche sociali statutarie econfermate le importanti rap-presentanze presso la Con-sulta Nazionale delle Aggre-gazioni Laicali (ove ilrappresentante della Confe-derex fa parte, per nominaC.E.I., del Direttivo), pressol’OMAEEC e presso il Forumdelle Famiglie. Al summit diAbano sono convenuti gliesponenti delle diverse realtà,sia di carattere istituzionale (lediverse congregazioni reli-giose che gestiscono scuole
cattoliche) sia territoriale (re-gioni, province, diocesi).Il tema del convegno trova alpresente fortissimo motivo diattualità, sia per la rinnovataesigenza di alleanza educativatra scuola e famiglia, sia per il
difficile momento di crisi dellafamiglia medesima, sottopo-sta, in tutti i suoi aspetti, a duriattacchi; sia nel permanere diquello che rimane, più chemai, lo specifico dell’impegnodella Confederex, vale a direla promozione della paritàscolastica autentica, fondatasulla naturale esigenza dellafamiglia quanto a libertànell’educazione e istruzionedei figli (art. 33 e 34 della Co-stituzione), confermata dauna legge (62/2000) ma am-piamente inattuata nei fatti:una situazione di piena ano-malia che la politica di tutti icolori non è stata sinora ingrado di sanare e che vedepronti ad autentica mobilita-zione gli autentici difensori
dell’istru-zione li-bera e pa-r i t a r i a(cattolica e non), pubblica alpari di quella statale. Il fortetesto convegnistico è stato
trattato adAbano dal Prof.Roberto Pasolini,Preside dell’Isti-tuto “Leopardi”di Milano e com-ponente il Consi-glio NazionaleScuola dellaC.E.I., e dal PadreGiuseppe Turrin,Assistente Eccle-siastico nazio-nale della Confe-derex, salesiano.Presente ai lavoripadovani anche
il Dott.Giuseppe Mariano, Pre-sidente di UMAEC, l’organi-smo europeo di coordina-mento corrispondente allaConfederex.
Predisposto dal nuovo Diret-tivo Confederex anche un ade-guato progetto di prepara-zione al prossimo convegnoecclesiale di Firenze “In GesùCristo il nuovo umanesimo”,che si articolerà previsional-mente in un momento di stu-dio sul tema “Dal ‘GravissimumEducationis’ alla tutela della di-gnità umana e della famiglia,educando alla vita buona delVangelo”.
Maurizio Dossena,Segretario Diocesano e
Referente per l’Emilia-Romagna
NUOVO DIRETTIVO NAZIONALE CONFEDEREXLiliana Beriozza subentra a Claudio Andreoli
I partecipanti al Convegno Confederex di Abano Terme

ex-alunni famosi
Mario Chiarapini, Fsc
Dalla natia Zagarolo si trasferì ingiovane età a Roma. Frequentò lascuola Angelo Braschi di San Salva-tore in Lauro e fece parte dei puericantores, chiamati a cantare nellapontificia Cappella Giulia. È qui chericevette la prima formazione musi-cale, esperienza che avrebbe lasciatotracce importanti nella maturazionedel suo percorso artistico.
Tra i suoi compagni, vi fu EnnioFrancia (poi Monsignor Francia),amico di una vita, fondatore dellaMessa degli Artisti. Con la mutazionedella voce, dovette lasciare il coro e,all’età di 15 anni, divenne commessoin un negozio di articoli musicali, daqui la scoperta delle sue grandi dotimusicali. Si iscrisse al Conservatoriodi Santa Cecilia a Roma, ma inizial-mente, i Fratelli delle Scuole Cristiane,suoi maestri a San Salvatore in Lauro,nella persona di Fratel Pacifico1 (Fran-
cesco Ferrarelli), avendo in-tuito il talento musicale delragazzo, si fecero carico dellespese, dal momento che la fa-miglia non aveva sufficientipossibilità economiche. Ma lagratitudine del musicista neiconfronti di Fratel Pacifico an-dava al di là degli aiuti econo-
mici ricevuti. Più di una volta, affermòche Fratel Pacifico era stato per lui“un secondo padre”. Quando, il 5 di-cembre 1956, Fratel Pacifico morì,dopo essere stato per cinquantaseianni Prefetto della Schola Cantorum,tra i primi ex-alunni che andarono ascuola per onorarne la salma vi fuGoffredo Petrassi, BonaventuraSomma, il sindaco di Roma il senatoreUmberto Tupini, Armando Antonelli,Stanislao Fusco e tantissimi altri.
Da una biografia2 raccontata dalmaestro e raccolta, nel 1986, daEnzo Restagno, si legge:
“A sette anni (nel 1911), mio padredecise di trasferire anche me a Roma(dalla natia Zagarolo), perché tutta lafamiglia mi aveva già preceduto; ioero rimasto solo, affidato alle cure diun mio zio. Feci il viaggio a Roma su
un carro a vino. È un elemento folclo-ristico, ma ha una spiegazione moltosemplice. Dovevo viaggiare solo e miopadre non poteva pensare che viag-giassi sulla piccola ferrovia locale: al-lora mi affidò a un suo amico, uncarrettiere a vino, che trasportavaquasi giornalmente barili di vino per ivari clienti, per le varie osterie. Mipare - se ben ricordo - che partimmoverso le sei del mattino. A mezzo-giorno ci fermammo in un’osteria diposta. A mezzo cammino mangiammoe verso le sei arrivai a Roma. La miafamiglia abitava nel quartiere di viadei Coronari, in una grande stanza alvicolo della Volpetta, che era un quar-tiere a quel tempo molto popolare,direi di un popolo minutissimo. Que-sto quartiere, che del resto è un quar-tiere straordinario a pensarci oggi (maoggi è diventato un quartiere quasi dilusso), era a quell’epoca oltre che po-
Da Zagaroloa San Salvatore in Lauro
fino a diventare uno dei maggioricompositori italiani del Novecento,
raggiungendo la fama mondiale
Un grande della musicaGOFFREDO PETRASSIUn grande della musicaGOFFREDO PETRASSI
33
“”
1 Il 20 novembre 1955, Fratel Pacifico, da tuttiriconosciuto come un grande educatore e ungeniale maestro, venne insignito della “Meda-glia d’oro Pro Ecclesia et Pontifice” e della“Medaglia d’oro dei benemeriti della educa-zione popolare”. 2 Enzo Restagno, Una biografia raccontatadall’autore e raccolta da Enzo Restagno,in Petrassi, a cura di Enzo Restagno, EdT,Torino 1986.
(Zagarolo 16/07/1904 - Roma 02/03/2003)

ex-alunni famosi
polarissimo, anche leggermente mal-famato, perché vicino c’era una stradaabbastanza losca di commerci pocolodevoli e di facilità di coltello. Inquesta strada - che era via dei Coro-nari - arrivai e mia madre, al mio ar-rivo, si occupò subito della miaeducazione, facendomi seguitare lescuole elementari che avevo comin-ciato a Zagarolo. La ricerca non futanto difficile, perché proprio là, apiazza San Salvatore in Lauro, collo-cata a metà di via dei Coronari, esi-steva quella scuola di Fratelli delleScuole Cristiane, dei Carissimi3 delleScuole Cristiane. Era una scuola ele-mentare, detta anche scuola degli“Ignorantelli”; perché la scolarescaera formata soltanto da ragazzi che,invece di stare per la strada, anda-vano alle elementari4.
Nell’istituto c’era una schola can-torum formata da fanciulli cantori.Tra gli allievi delle scuole elementari,sceglievano quelli che avevano unavocina più gradevole o più assennatadegli altri e li istruivano nella scholacantorum. Io fui ammesso - non ri-cordo bene - all’età di sette o ottoanni nella sezione dei soprani. Era unaschola cantorum importante ai suoitempi, perché non eravamo dilettanti,ci insegnavano la musica e noi can-tavamo con la musica, non soltanto amemoria. La schola forniva il gruppo
dei ragazzi cantori, rinforzati moltospesso da certi sopranisti5 che ancoraesistevano, alle basiliche romane ealle chiese quando era necessario. Ilnostro servizio quotidiano fisso era labasilica di San Pietro, alla CappellaGiulia. Ogni mattina c’era una messacantata e la schola forniva un piccolonumero di ragazzi. […] Il repertoriogenerale che ho affrontato nei cin-que, sei anni in cui ho frequentato lascuola, toccava brani di Palestrina,Animuccia, Anerio, i maestri fiammin-ghi, Josquin Desprès, ma anche autoriottocenteschi e moderni, quando sifaceva la musica con gli organi. […]Oltre alle grandi occasioni, c’erano iservizi nelle piccole chiese o nei ca-stelli romani: un’attività molto in-tensa che permetteva a tutti noi diassorbire un vastissimo repertorio dimusiche che potevano andare dallepiù sublimi alle più sprovvedute, allepiù banali. Tutto questo ha rappresen-tato per me una specie di deposito in-teriore che naturalmente con gli anniho cercato di selezionare critica-mente; tuttavia l’impulso che hoavuto dalla schola cantorum è statodeterminante. […] Di scholae canto-rum, all’epoca, a Roma, ce n’erano di-verse; naturalmente la scholacantorum migliore era la mia. Devo
aggiungere che era la migliore nelsenso che alcuni compagni che hannoesercitato nella schola con me sonodiventati poi dei musicisti buoni omediocri, ma comunque musicisti.Questo vuol dire che le nostre basierano giuste, solide e buone”.
Goffredo Petrassi si diplomò in or-gano e composizione all’inizio deglianni Trenta. Dopo aver studiato alconservatorio di Roma, si mise in lucecome insegnante, come direttored’orchestra e soprattutto come com-positore di fertile originalità espres-siva, attentissimo all’evolversi dellinguaggio musicale e a tutti i fattidella cultura. Dopo un primo periodo,quello delle opere giovanili che na-scono sotto il segno di un neoclassi-
34
Pagella scolastica di 5° elementare dell’alunno Goffredo Petrassi a San Salvatore in Lauro
3 L’espressione “carissimi”, con cui erano co-nosciuti a Roma i Fratelli delle Scuole Cri-stiane, derivava dall’appellativo, Tres cherFrère, carissimo Fratello, usato dai Fratellifrancesi nel rivolgersi a un confratello.4 Come si vede, il Petrassi dà della parola unaspiegazione molto personale, anche se sug-gestiva; in realtà, scuole degli “Ignorantelli” èun’espressione che viene attribuita a Voltaire,motivata dal fatto che nei primi tempi dell’Isti-tuto, tra le discipline che insegnavano i Fratellinon figurava il latino, avendone avuto proibi-zione dal La Salle stesso.5 Sopranisti erano dei cantanti maschi adultiche per natura o per artificio (eunuchi o ca-strati) cantavano con voce di soprano.

ex-alunni famosi
cismo e rimandano ad autori comeIgor Stravinsky, Béla Bartók e PaulHindemith, Gian Francesco Malipieroe Alfredo Casella, dalla metà deglianni Trenta inizia la fase del cosid-detto barocco romano con opere qualiil Salmo lX, Magnificat e Quattro innisacri dove sono chiaramente riscon-trabili le riflessioni dell’autore sul-l’arte controriformista romana.
La produzione successiva, a partiredal Coro di morti su testo di GiacomoLeopardi, si distacca sempre di più daquesta estetica neoclassica e si in-cammina su una strada essenzial-mente libera e autonoma, che loporterà a risultati molto originali,come si vede negli otto Concerti perorchestra (tra il 1934 e il 1972). Fuestremamente prolifico anche con lacomposizione della musica da ca-mera, della musica corale e di quellaa tema sacro.
La sua curiosità intellettuale lospinse anche verso il teatro musicale.Compose: Il Cordovano (su testo diCervantes, tradotto da Eugenio Mon-tale) e Morte dell’aria, breve attounico e i balletti La follia d’Orlando eRitratto di Don Chisciotte.
Compose anche alcune colonne
sonore: Riso amaro e Non c’è pace tragli ulivi di Giuseppe De Santis, Cro-naca familiare di Valerio Zurlini e Lapattuglia sperduta di Piero Nelli.
Una delle sue ultime apparizionipubbliche la fece in occasione del bi-centenario della scuola Braschi
35
Nel 1869, con Pio IX, ebbe inizio la collaborazione stabile della schola cantorum di San Salvatore inLauro con la basilica vaticana, già avviata due anni prima in occasione del diciottesimo centenario delmartirio degli apostoli Pietro e Paolo. Nel 1908, i pueri cantores di san Salvatore in Lauro, furono inqua-drati nell’organico della Cappella Giulia e, sotto il pontificato di Benedetto XV (1914-1922), la Scholafu incorporata alla Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra. Con Fratel Pacifico la schola fece ancheuna tournée in Francia, cantò al Quirinale per le nozze della Principessa Jolanda di Savoia e diverse volteal Teatro dell’Opera. Per un secolo è stata in primo piano nel campo della musica sacra e profana. La di-ressero illustri maestri, quali Pietro Mascagni, Bernardino Molinari, Lorenzo Perosi, Raffaele Casimiri,Bonaventura Somma, Licinio Refice, Armando Antonelli, Remigio e Armando Renzi. Tra gli alunni, vi fu-rono insigni musicisti, tra cui: Giacomo Setaccioli, Bonaventura Somma, Bernardino Molinari, EnricoMorlacchi, Goffredo Petrassi, i fratelli Giuseppe e Guglielmo Morelli, Roman Vlad, i fratelli Fusco, Ar-mando Renzi, Bruno Nicolai, Giovanni Zammerini, Carlo Romano, Raffaello Tega, Luciano Pelosi… e moltialtri. Ha fornito anche illustri cantanti e validi coristi, come Alessandro Moreschi, Giuseppe De Luca,Salvatore Baccaloni, Ezio Di Cesare… che si sono esibiti in prestigiosi teatri. Ha dato anche un cardinale,Domenico Tardini, segretario di Stato di Giovanni XXIII, e dei buoni poeti romaneschi, come Giulio CesareSantini e Giulio Marchi.
(1993), quando a Villa Flaminia, nelprogramma musicale fu inseritoanche un suo brano. In quella circo-stanza e ogni volta che parlava deiFratelli, l’ex-alunno Petrassi ha avutosempre espressioni di alta gratitudinee di profondo rispetto. ◆
Chi desidera consultare i numeri precedenti di “Lasalliani in Italia”può entrare nel sito: www.lasalleitalia.net cliccando Pubblicazioni

testimonianze
36
Dal 19 al 22 marzo si è rinnovatocome di consueto l’appuntamentoche dà l’opportunità a tutti i giovanilasalliani di crescere, incontrarsi econfrontarsi a partire dal tema di Pa-storale“Costruire sulla roccia”.
L’incontro nazionale del Movi-mento Giovani Lasalliani si è svolto aRoma, in un percorso itinerante cheha visto i quasi cento partecipanti,provenienti da tutta Italia, accolti dadiverse comunità lasalliane (che rin-graziamo!) e che ha avuto inizio a Su-biaco, dal monastero di SanBenedetto costruito proprio sulla roc-cia. Siamo partiti da una domandaprecisa e provocatoria: “Perché con-tinuare a costruire?”. Ognuno dei ra-gazzi, durante l’emozionante cerchioiniziale attorno ai nostri cubi, ha con-diviso le sue motivazioni, mentre noidi ELP abbiamo messo in campo glielementi per noi irrinunciabili chesperiamo siano diventati di tutti.
Siamo partiti da immagini di di-struzione e dall’esperienza di spe-ranze e progetti spesso nonrealizzati... Cristo, infatti, non pro-mette che su una casa in costruzionenon cada mai un acquazzone. Nonpromette che un’onda rovinosa non
travolgerà ciò che per noi è più caro...non promette che venti impetuosinon porteranno via ciò che abbiamocostruito a volte a prezzo di enormisacrifici.
Il cammino proposto a Subiaco ciha da subito permesso di avvicinarcialla scelta di chi ha costruito la suavita nella roccia, trascorrendo unagiornata in cui abbattere i pregiudizie la paura di chi è diverso e lontanoda noi. È stata emozionante e rimarràdi sicuro nel cuore di tutti noi quella
lunga (e chiassosa!) giornata presso laComunità per minori “Le Colonned’Ercole”, voluta e gestita da Bam-bini+Diritti,Onlus nata anni fa proprioda alcuni membri del MGL e oggicomponente della grande rete lasal-liana Considera.
Il nostro cammino di condivisioneè stato, inoltre, impreziosito dalla pre-senza di tanti liceali romani chehanno trascorso con noi la giornataaperta del sabato e con il grande re-galo che ci hanno fatto Fr. Robert
Incontro MGL “costruire sulla roccia”

37
Schieler, Superiore Generale dei Fra-telli, e Fr. Jorge Gallardo, suo Vicario.
Non è da tutti avere amici comeloro, che ci stanno accanto e che ven-gono in aiuto anche quando non lo siè chiesto ed è motivo di onore e vantoper tutti noi che la loro prima visita“formale” in Italia sia stata proprio alMovimento Giovani Lasalliani.
La loro testimonianza ci ha portatioltre i confini delle nostre piccolecase, conoscendo alcune esperienzelasalliane sparse per il mondo in cuisi vive con passione e fraternità, se-guendo costantemente l’esempio delnostro Fondatore, ispirando altresì FrRobert la nostra azione pastorale conle indicazioni scaturenti dal 45° Ca-pitolo Generale.
Nel pomeriggio abbiamo costruito
testimonianze
di Cristo… non a caso il logo sceltoquest’anno, ovvero il cubo-roccia, sedestrutturato diventa una croce.
Alla fine di questo incontro pos-siamo sicuramente dire di aver co-munque scavato bene in profondità,di aver gettato solide fondamenta periniziare a costruire strade e ponti percollegare le nostre realtà e sostenercil’uno con l’altro.
Perché la città che costruiremoavrà sempre una periferia e ci saràsempre un confine che noi lasallianisaremo chiamati a superare... ma ungiorno questo confine non ci sarà piùperché questa città sarà la città del-l’intera umanità e, come diceva Paolo,Gesù Cristo sarà tutto in tutti. ◆
ELP - Equipe lasallianadi pastorale
in giro per Roma, guidati dalla per-fetta organizzazione dei ragazzi delMGL del De Merode, tra le tante atti-vità di servizio che vedono impegnatisettimanalmente (e forse troppo insordina) tanti giovani lasalliani... spe-riamo che queste esperienze gratuitedi servizio abbiano aggiunto mattonisolidi e colorati da portare nelle co-munità per ingrandirle e ampliarne gliorizzonti.
Ci siamo ritrovati, così, a pensareal nostro Movimento, come tante co-struzioni, alcune solide, altre appenanate, altre ancora da progettare.
Abbiamo però capito che costruiresulla roccia significa poter contaresulla consapevolezza che nei momentidifficili c’è una forza sicura su cui fareaffidamento e per noi questa è la croce
IN VETRINA
Claudio Alberto Andreoli, “24 Maggio, l’esercito marciava” - 1915L’Italia nella Prima Guerra Mondiale, RIG Edizioni, Vicenza 2015.
La passione per la storia il professor Claudio Andreoli riesce a comunicar-cela con straordinaria maestria e le sue pagine si leggono con la piacevo-lezza di un romanzo, non per nulla, nella sua personale bibliografia, oltrea saggi storici, ci sono anche diversi romanzi, tra l’altro vincitori di presti-giosi premi letterari. Con l’ultima sua fatica ha voluto ricordare il cente-nario della Prima Grande Guerra. Cosa portò l’Italia dalla neutralità allabelligeranza, dall’appartenenza prima alla Triplice Alleanza e poi alla Du-plice Intesa? Andreoli passa in rassegna, con la meticolosità di un cronista,gli eventi che dal Congresso di Vienna (1814-’15) e di Berlino (1878) por-tarono alla notte, tra il 23 e il 24 maggio 1915, in cui l’Italia entrò in guerraper completare il processo di unità nazionale e liberare il Trentino e laVenezia Giulia dal dominio austriaco. Il nostro esercito, nel marciare co-raggioso e silenzioso verso il fronte, passò sul fiume Piave che espresse
poeticamente la sua gioia con il tripudio delle onde. La canzone “La leggenda del Piave”, il cui autorenel testo e nella musica è E. A. Mario (Giovanni Ermete Gaeta - Napoli 1884/1961), ricorderà per sem-pre quella data fatidica.
M. Ch.Il Piave mormorava calmo e placido al passaggiodei primi fanti il ventiquattro maggio:l’Esercito marciava per raggiunger la frontiera,per far contro il nemico una barriera.

testimonianze
38
Nel 2014 i migranti (rifugiati, ri-chiedenti asilo e transitanti) sbarcativia mare in Italia sono stati 170.000,64.625 hanno fatto richiesta d’asilonel nostro paese, di questi 21.861hanno avuto una protezione interna-zionale e solo 3.649 persone hannoottenuto lo status ufficiale di rifu-giato.
Il regolamento di Dublino III im-pone che lo stato di “arrivo” sia anchequello in cui il migrante debba obbli-gatoriamente fare domanda d’asilo.La maggior parte delle persone chehanno chiesto asilo nel nostro paeseproviene da Nigeria (10.138), Mali(9.771), Gambia (8.556), Pakistan(7.191), Senegal (4.678) e Afghani-stan (3.180). Secondo le stime del-l’UNHCR (United Nations HighCommissioner for Refugees) fino alsettembre 2014 sono arrivati in Italia28.557 cittadini eritrei e 23.945 cit-tadini siriani, per lo più minori, ma se-condo il Ministero dell’Interno lerichieste di asilo presentate (nellostesso periodo di riferimento) da cit-tadini eritrei e siriani sono rispettiva-mente 367 e 405. Le personeprovenienti da questi paesi spessonon hanno intenzione di fermarsi inItalia, perché vogliono ricongiungersicon un familiare che vive in un altro
stato europeo o più semplicementesanno che se vengono identificati inItalia non potranno uscirne. Nono-stante questi siano numeri “ufficiali”,i conti non tornano.
Nel Lazio ci sono 8.490 posti di-sponibili nelle strutture di accoglienzatemporanee, centri d'accoglienza eSprar per i richiedenti asilo. Gli altri,quelli che non hanno vinto la rulettedi un posto allo Sprar e che non pos-sono più usufruire dell’accoglienzaperché la loro domanda è stata accet-tata, a Roma approdano in luoghi chesi chiamano Collatino, Ponte Mam-molo, via Curtatone e Selam Palace.Occupazioni “abusive” come li defini-scono le amministrazioni pubbliche,in realtà ghetti sotto gli occhi di tutti.
Via Curtatone, 8 piani a due passidalla stazione Termini, ex sede del-l’ISPRA, che “ospita” almeno 400 per-sone tra cui una ventina di bambini,la maggior parte di loro gode dellostatus di rifugiato. Palazzo Selamcirca 1.200 residenti stabili, fra cui 50bambini, per la quasi totalità titolaridi protezione internazionale, prove-nienti da Somalia, Eritrea, Sudan edEtiopia, in Italia da più di 5 anni. Col-latino, palazzo occupato da circa 300rifugiati per lo più eritrei. Queste per-sone vivono al di sotto perfino dellostandard in un campo per rifugiati,questi palazzi non sono nati per usoabitativo e sono stati riadattati dagliabitanti, in 2 edifici su 3 non c’èacqua né elettricità. Ponte Mammolouna baraccopoli nata 11 anni fa, tiratasu dai residenti con lamiere e mate-riali di scarto, in cui trovano rifugioalmeno 250 persone anche minori.
É in questi spazi che le comunitàresistono e sopravvivono. La man-canza di acqua, di corrente elettrica edi servizi igienici crea enormi pro-blemi soprattutto sanitari e l’assi-stenza medica (e sociale) offerta daassociazioni senza scopo di lucro,ONG o da comunità religiose nonbasta a fronteggiarli.
Molti problemi sono di ordine sa-nitario, come la diffusione di malattie
La solidarietà lasallianaè fatta anche di gocce

39
della pelle dovute a condizioni discarsa igiene: la scabbia. Infezioneche in Italia fino a qualche tempo faera un ricordo. Per questo abbiamoavviato un piccolo progetto per for-nire 400 kit alle religiose combonianee a un’associazione di volontariatoche già assistono queste persone.
Ogni kit composto da zainetto,
testimonianze
diverse, la Prima Media B e la Seconda MediaA, accompagnate da Fratel Mario hanno dedi-cato il loro tempo e la loro attenzione al servi-zio dei più bisognosi. Vorremmo ringraziarepersonalmente ognuno dei ragazzi che ha con-tribuito con il proprio impegno a rendere pos-sibile la riuscita di questo progetto.
Con questo esempio di solidarietà lasalliana,oggi, 400 rifugiati hanno il minimo indispen-sabile, 400 kit possono sembrare una piccolagoccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce.
Serena Pegorin
saponetta, spazzolino dadenti, dentifricio, asciu-gamano, calzini, bian-cheria intima e un rasoio(per gli uomini) è statoassemblato con cura dairagazzi della Scuola LaSalle di via GiambattistaPagano. In due mattine
Il 3 marzo del 1965 Paolo VI fecevisita all’Istituto Pio IX sull’Aventino.Era il pomeriggio del mercoledì delleceneri, l’inizio della Quaresima che aRoma, si sa, inizia a Santa Sabina, 500metri di distanza dal Pio IX. Per coloroche furono presenti, una esperienzaindimenticabile: il Papa fu disponibi-lissimo, affabile, e pronunciò un di-scorso a braccio commovente ebellissimo, di grande stima verso iFratelli. In effetti, lo ricordò lo stessoPontefice con grande simpatia, il gio-vane Montini frequentò il Pio IX di-cendovi Messa e confessandone glialunni tra il 1928 e il 1932.
Il 3 marzo del 1965 si era dapoco chiusa una sessione del Conci-lio Vaticano II, assise senza egualinella lunga storia della Chiesa, chesi concluderà l’8 dicembre di quel-l’anno: un momento storico moltoparticolare che qualcuno ha definitola primavera della Chiesa.
A cinquant’anni di distanza, nonsenza aver superato un periodo diquasi oblio, nell’ottobre del 2014,papa Francesco in San Pietro ha pro-clamato Paolo VI beato. Così la figuradi Paolo VI ha ricominciato a guada-gnare, presso il popolo cristiano, laluce che merita.
Considerando i due aspetti con-comitanti, è stata organizzata al PioIX una giornata dedicata a Paolo VIanzitutto in ricordo di quell’evento,di cui si conservano gelosamentesvariati documenti. In particolare siconserva il cortometraggio girato inquella circostanza: con l’occasionetutto è stato trasferito su un DVD,in modo da rendere fruibile a tuttiil prezioso documento visivo e so-noro. Ma anche per avvicinare glialunni e i loro genitori a una figuramaiuscola del cattolicesimo del XXsecolo che ha ancora tanto da inse-gnare a tutti noi.
La giornata è stata organizzata indue momenti distinti. In mattinatasono stati protagonisti attenti glialunni che hanno potuto visionare ilDVD, conoscere meglio la figura diPaolo VI vuoi (la scuola Primaria) at-traverso una ricerca sulla sua personaguidata da Fratel Fernando Venè, vuoi(per i più grandi) attraverso una pre-sentazione avvincente, curata e gui-data con grande passione da FratelEmanuele Costa. Una mostra nell’atrioideata dal Prof. Andrea Sallese ha con-sentito a tutti di ripercorrere pezzi distoria del Pio IX in particolare nei suoinumerosi contatti con la Santa Sede.
Nel pomeriggio, è stato organiz-zato un seminario di studio di ottimolivello con la presenza di sua Eccel-lenza Mons. Vincenzo Zani, Sottopre-fetto della Congregazione perl’Educazione Cattolica, il Vicario Ge-nerale dell’Istituto dei Fratelli delleScuole Cristiane, Fr. Jorge Gallardo, il
CINQUANTENARIO DELLA VISITA DEL PAPAPAOLO VI ALL’ISTITUTO PIO IXCINQUANTENARIO DELLA VISITA DEL PAPAPAOLO VI ALL’ISTITUTO PIO IX

40
Visitatore Provinciale e l’Ausiliare, iFratelli Achille e Bernardino, numerosiFratelli e un pubblico attento e inte-ressato. Il Cardinal Vicario AugustoVallini ha inviato un suo messaggio diadesione e molti messaggi di felicita-zioni sono giunti da studiosi e scuolelasalliane e non solo.
Per l’occasione sono stati invitatia parlare Don Angelo Maffeis, Presi-
dente dell’Istituto Paolo VI di Conce-sio (Brescia), che è oggi l’anima deglistudi montiniani nel mondo, e il ProfPhilippe Chenaux ordinario di storiadella Chiesa presso la Pontificia Uni-versità Lateranense e studioso delConcilio Vaticano II di fama mondiale.Gli interventi dei due importanti stu-diosi hanno delineato da par loro, lafigura di Paolo VI come educatore, il
primo, e il momento storico della vi-sita, il secondo. Molto vicina al sentiredei presenti, la relazione finale dellaDott.ssa Patrizia Moretti, studiosa diPaolo VI, che ha commentato il di-scorso tenuto dal Santo Padre nellacircostanza. Momenti di commozioneinfine per le brevi e significative te-stimonianze portate da testimonioculari della visita: Fratel Pio Rocca,il Prof. Armando Piaggesi e DinesioNuccitelli.
Oltre che per indubbia ricchezzadei contenuti (che si stanno racco-gliendo) il seminario si è fatto apprez-zare per la qualità degli intervenuti,per il rigoroso rispetto dei tempi, l’al-lestimento sobrio nel bell’atrio del-l’Istituto, lo stesso da dove parlò PaoloVI. Tutti alla fine sono usciti con laconsapevolezza che il Pio IX Aventino,50 anni fa fu onorato di accogliere unpapa, ma soprattutto un santo.
Gabriele Di Giovanni, Fscdirettore Ist. Pio IX
TRA STIPENDIO E DONO: IL LAVORO DELL’INSEGNANTETRA STIPENDIO E DONO: IL LAVORO DELL’INSEGNANTE
È risaputo: ogni lavoro merita un stipendio. È vero anchel’inverso: ogni stipendio presuppone un lavoro. Questo valeper tutti, compresi gli insegnanti. Come potremmo negarlo?Insegnare richiede tempo, competenza, impegno, costa faticae merita una retribuzione come qualsiasi attività che esigaqualità e sforzi analoghi. Come tutti i mestieri, insomma. È ilcaso di discutere, di avere dubbi? A rigor di logica no. Invecesì, avrebbe obiettato il La Salle, perché riducendo l’insegna-mento soltanto a un lavoro si rischia di cancellarne il valoreprofondo. E avrebbe aggiunto: certo, si tratta di un lavoro, maprima di tutto è una vocazione. Da questo punto di vista, qua-lunque sia la retribuzione, qualunque sia la competenza di-mostrata, quel che più conta è la qualità della relazione chesi instaura con i destinatari dell’insegnamento: cioè con i pro-pri alunni. Tutto ciò va ben oltre i criteri di pagamento. Si puòaffermare allora che la qualità di tale relazione rientra nel-l’ambito di un surplus personale dell’insegnante.
Come definirlo? Si può rispondere che tale surplus di-pende dall’abnegazione, dalla fede in certi valori, da una forteesemplarità: in altre parole, sarebbe la parte del dono. Laparte più bella, quindi, e la più importante. Molti obiette-ranno che questo discorso sulla gratuità possa sembrare ba-nale, se non addirittura ingenuo. Questi ultimi diranno: se
volete considerare il vostro mestiere come una vo-cazione sono affari vostri: ciò che conta non sono leparole edificanti sulla vocazione, ma un discorso rea-listico, cioè l’ottenimento di uno stipendio che si ri-tenga adeguato al costo della vita, nella visionecostituzionale che rientra nell’ambito della giustizia.

41
Esisterebbe dunque una dicotomiatra il lavoro stipendiato contrappostoalla vocazione, la giustizia contrap-posta al dono? Vorrei invece dimo-strare che è possibile uscire da questaconflittualità. Tanto per cominciarebisogna riaffermare una verità asso-luta: sì, insegnare è un lavoro chemerita uno stipendio secondo lanorma giuridica; sì, nell’insegna-mento vi è qualcosa che va al di làdella competenza tecnica e dellasemplice esecuzione materiale deicompiti assegnati. Non dobbiamo
tanto chiederci se scegliere tra giu-stizia e dono, ma piuttosto in checosa è diversa la relazione tra giusti-zia e dono nel caso dell’insegna-mento rispetto ad altre professioni. Inquesto senso, piuttosto che di stipen-dio dovremmo parlare di onorario, te-nendo presenti i valori morali chedebbono essere trasferiti agli alunninell’atto di insegnare, sia con i com-portamenti in classe che nella vitaprivata. Tale onorabilità è la primafonte di insegnamento per un bam-bino che osserva il proprio maestro enon potrà mai essere quantificata in
denaro. Insegnare vuol dire semprerispondere hic et nunc alle domandedegli alunni che ci guardano, che ciascoltano, che ci parlano. L’insegna-mento è dunque puro dono nelle suetre accezioni più alte: insegnarerientra nel campo della gratuita ge-nerosità, assume la forma dell’aiutoper chi ne ha bisogno e infine si tra-sforma in un riconoscimento reci-proco della bellezza e della gioia.Tale importanza è in rapporto allamissione specifica dell’insegnante checonsiste soprattutto nel trasmetterein modo sistematico e critico la cul-tura alla luce della fede e nell’educareal dinamismo delle virtù cristiane,promuovendo così la duplice sintesitra cultura e fede e tra fede e vita.Quindi possiamo concludere affer-mando che se il lavoro in generale èun diritto connaturato a dei doveri,nello specifico dell’insegnamento, talidoveri sono la parte preponderantedel nostro operato. ◆
Piergiorgio Lattanzidocente lasalliano
Alberto Castellani, Fscinsegnante
Tris da ombrelloneQualche utile consiglioper ridare vitaa verità geometrichee matematichespesso mummificate.
Ancora qualche giorno poi tuttiin libertà quasi vigilata. Iniziano tre-dici settimane di vacanze scolasti-che continuate. Primato europeo pergli studenti italiani, lettoni, lituani eturchi.
Il ministro del lavoro Poletti di-sapprova con due righe di matita blu
mentre il ministro del MIUR Gianninilavora al progetto La Buona Scuola.
I prof dissotterrano l’ascia di guerradello stipendio da terzo mondo o, perdirla con Crozza, inferiore alle pa-ghette dei loro alunni, ma gli studentiinneggiano comunque alla fine dellascuola, pur se con gli immancabili
“compiti per le vacanze”: analisi gram-maticale, equivalenze, peso lordo-tara-peso netto, base-per-altezza-diviso-due, addizioni-sottrazioni-moltiplica-zioni-divisioni…
Per andare oltre, come vitaminico,consiglio un tris di letture sotto l’om-brellone in riva al mare oppure in altaquota all’ombra di un faggio o di unabetulla. Sarà un modo semplice di ri-trovarsi a tu per tu con i grandi delmondo dei numeri o, se preferite, ri-dare vita alle mummie di verità geo-metriche e matematiche di un saperefin troppo formalizzato.
Tre libretti di matematica senza
Qualche utile consiglioper ridare vitaa verità geometrichee matematichespesso mummificate.
didattica
Tris da ombrellone

42
didattica
numeri e di geometria senza formule.Tre testi dove l’aridità degli algoritmilascia il posto alla fantasia e all’intuito.Anti sbadiglio, scorrevoli, divertenti,accattivanti. Sicuramente curativi perchi è affetto dalla sindrome dell’ominonero della matematica. Una flebo di-sintossicante per chi ha medie piutto-sto basse nel quaderno a quadri.
In questi volumetti i rigidi con-cetti scientifici, deposte le vesti del-l’ufficialità, indossano quelle di tuttii giorni: la figura geometrica del qua-drato diventa un mister, la nonna diPitagora insegna il teorema di suo ni-pote sferruzzando sui lati del trian-golo, i quadrati dei numeri diventanonumeri rapa, quelli triangolari si ma-terializzano quasi per incanto sottouna palma di noci di cocco.
Gli elementi della matematica edella geometria sono scovati nella re-altà e diventano digeribili e godibilianche per i poveri mortali: il trian-golo nel palazzetto tensostatico dellosport, il quadrato sulle sponde delNilo, la somma degli angoli negli esa-goni e nei pentagoni di un pallone dacalcio, la radice di due nelle matto-nelle del bagno di casa. Dice HansFreudental, scrittore, filosofo, storicodella didattica della matematica: “Lageometria può essere significativasolo se esprime le sue relazioni con lospazio dell’esperienza... essa e unadelle migliori opportunità per mate-matizzare la realtà”.
I numeri primi sono ribattezzatinumeri principi, le potenze in numerisaltellanti, gli irrazionali in irragione-voli, quelli di Fibonacci in bonaccioni,il triangolo di Tartaglia svela tutte lesue magie nelle sembianze di unvideo elettronico. Sono scritti in unostile semplice, quasi in lingua parlata,senza paroloni, con tanti dialoghi.
I disegni fanno capolino in moltepagine traducendo in colori e formesimpaticissime concetti e idee chepotrebbero restar sepolte sotto unlinguaggio tecnico fin troppo specia-listico: spiegano ciò che le parole nonriescono a spiegare.
La materia non è enunciata ma
raccontata da nonni e maghi che al-l’interesse per gli argomenti unisconola passione e l’arte di chi sa farsiascoltare dai più piccoli. Sogni, rac-conti, storia e storie mitologiche sirincorrono di notte e di giorno e titengono col fiato sospeso fino allaprossima puntata come in un giallodi Agatha Christie.
Perché, altro colpo di genio degli au-tori, tutto è proposto in forma di fiaba.Compare un omino che si dondola suuna foglia di acetosella, si finisce in unbosco di un gigante o in una grotta prei-storica le cui pareti si riempiono di mi-steriosi calcoli, ci si distende su unaspiaggia sotto un cielo ricoperto diun’infinità di numeri con iquali possono avere a chefare solo una bacchettamagica o una calcolatricesmisurata. Ci si ritrova inaula a bisticciare per lascelta del posto da variaredi giorno in giorno persfruttare tutte le possibilità.
Dalle cronache delpassato remoto e pros-simo emergono figure in3D come quelle di Pitagora che fascendere in campo la nonna, di Ar-chimede che scomoda sua sorellaIliada per trovare il volume dellasfera, di Cartesio ispirato da un pretenelle sue coordinate, di GiuseppePeano con i suoi simboli di logica e ditanti altri personaggi illustri delmondo dei numeri.
Onestamente, per i piccoli e nonsolo per loro, è difficile non lasciarsicoinvolgere e incantare. “Se mi diciuna cosa, posso dimenticarla. Se mela mostri, può darsi che me la ricordi.Ma se mi coinvolgi, nonla dimenticherò più”,concluderebbe Rabindra-nath Tagore, poeta,drammaturgo, musicistae filosofo indiano.Spero di aver suscitato lacuriosità di qualcuno, me-more di quanto pensava ilfilosofo Giambattista Vico:“La curiosità è figlia del-
l’ignoranza e madre della scienza, laquale partorisce la meraviglia”. Se nonaltro, la lettura di questi tre libri rialze-rebbe le quotazioni dei lettori italiani:sei su dieci, in un anno, non leggononeppure un libro.
Un tuffo nel mare della meravi-glia, della scoperta piacevole, del sa-pere cartaceo che ridiventa realtàsvelando i segreti, i misteri, i feno-meni scientifici: anche i ministri, dellavoro e della scuola, sarebbero con-tenti, oltre ai maestri e ai professori,lieti di scoprire tra i propri alunnilettori appassionati che sanno ge-stire il loro tempo libero in modo co-struttivo.
Felici vacanze dun-que con:
Mr Quadrato, aspasso nel meravigliosomondo della geometria,di Anna Cerasoli, do-cente di matematica permolti anni e autrice dinumerosi manuali pressola Sperling & Kupfer.
Il Mago dei nu-meri, da leggersiprima di addormen-tarsi, dedicato a chiha paura della mate-matica, di Hans M.Enzensberger, provo-cante e versatilescrittore tedesco deldopoguerra, con illu-strazioni di R. Su-sanne Berner editoda Einaudi Ragazzi.
La nonna di Pitagora,l’invenzione della matema-tica spiegata agli increduli,di Bruno D’Amore e MarthaIsabel Fandiño Pinilla, ma-tematici, PhD in Mathema-tics Education, impegnatiin master post laurea e neidottorati di ricerca in Di-dattica della matematica,edizioni Dedalo. ◆

L’amore ai giovaniIl sistema preventivoVerso la santità. Linee guida easpetti in comunedella pedagogiadei due Santi
approfondimenti
Venerdì 13 marzo, nel bicentena-rio della nascita di San GiovanniBosco (1815), il Prof. Don Ezio Risatti,salesiano, ha intrattenuto gli ex-al-lievi dell’Istituto La Salle di Torino, dicui pure è ex-allievo, su un temaquanto mai interessante: un originalee raro accostamento delle figure deidue grandi Fondatori dei Fratelli delleScuole Cristiane e dei Salesiani.
L’oratore ha voluto sottolineare trepunti in comune dei due santi, nono-stante la distanza nel tempo e il di-verso contesto sociale in cui essi sisono trovati a vivere. Al di là però deivari fattori contingenti, entrambi sisono perfettamente accordati nell’in-dicare agli educatori linee guida fon-damentali e valide oltre il tempo, nelcampo dell’educazione dei giovani1.
1. L’AMORE AI GIOVANI
La Salle e Don Bosco amavano igiovani. L’amore è il punto di par-tenza. Solo chi ama si accorge dellagioia come della sofferenza dell’altro
e vi partecipa sinceramente. Ilsoggetto se ne accorge edentra subito in sintonia conchi desidera partecipare al suomondo, soprattutto interiore.
Poi, ma in seconda istanza, arriva na-turalmente l’interesse per i bisognispecifici e concreti della persona.Prima il sorriso, poi l’elemosina. Peg-gio sarebbe una fredda elemosinasenza sorriso.
Chi invece non ama, non gioisce enon soffre per la persona che gli siedeaccanto, rimane insensibile e nonpotrà apportarle veri e significativibenefici.
Il Cuore trafitto di Gesù sulla croceè simbolo dell’amore infinito feritodalla malvagità degli uomini. Così LaSalle e Don Bosco nel profondo delloro cuore hanno sentito risuonare,facendola propria, la sofferenza deiragazzi emarginati, poveri, orfani so-prattutto nello spirito e dal punto divista psicologico, affettivo, culturale.
Poiché Dio Padre nei suoi miste-riosi disegni ha affidato l’umanitàall’umanità. Egli è sempre alla ricercadi persone disponibili a cooperare conLui per realizzare il suo piano di sal-vezza universale, per subito arricchirledei doni dello Spirito, cioè dei carismi
più opportuni: per La Salle e DonBosco il carisma di essere “padri deigiovani”.
Lo Spirito, come nella Pentecoste,è pronto a scendere su chi lo invoca.L’inghippo sta nel saperlo mante-nere. Significativo il paradossale pa-ragone di una persona che invita acasa sua un personaggio importante,per esempio… il Papa (!), lo fa acco-modare in salotto invitandolo ma-gari a guardare la TV ma poi, nondegnandolo di uno sguardo, se neesce per i fatti suoi! Di fronte a que-sto orribile sgarbo, al deluso ospitenon rimarrà che andarsene imme-diatamente.
Così una graziosa e pacifica co-
43
La Salle e Don Bosco:due Santi per i giovani
1 Nel 1950 San Giovanni Battista de La Salleè stato proclamato da Pio XII Patrono univer-sale degli educatori.

approfondimenti
lomba che al minimo cenno di peri-colo se ne vola via, è l’emblematica fi-gura dello Spirito che arriva con i suoidoni ma subito si ritira non appena sisente rifiutato e non ben accolto. Al-lora però si rimane soli e inconclu-denti. Se invece il dono dello Spiritorimane in noi, la vita in sé e negli altricambia profondamente crescendo ecreando opere meravigliose.
La Salle e Don Bosco, ad imita-zione del “Sì” irrevocabile di Maria,hanno messo la loro vita a completadisposizione di Dio con una fedeltàeroica senza ripensamenti e supe-rando tutti gli ostacoli lungo il per-corso.
La tentazione ricorrente per gio-vani e adulti è credere di perdere li-bertà e felicità rinunciando allapropria vita per dedicarla a Dio. Èvero il contrario: abbandonarsi confiducia a Dio significa valorizzare erealizzare in pienezza la propriavita.
2. IL SISTEMA PREVENTIVO
Entrambi i Fondatori erano con-vinti che nel campo dell’educazionefosse necessario giocare d’anticipo:prevenire i mali prima di intervenirequando forse è troppo tardi.
Davanti dunque a un giovane chesoffre non si può stare a guardare, li-mitandosi a poche e vuote parole dicompassione e di augurio. Questi at-teggiamenti non servono. Occorredarsi subito da fare, ma con metodo.
Il primo passo sarà instauraremolteplici e profonde relazioni congiovani di loro natura immaturi, conproblematiche assai diverse e relativea tutti gli aspetti della loro vita:corpo, psiche, spirito, anima.
Seguire il percorso indicato dal-l’educatore comporterà certo per lorofatica, ma il peso maggiore lo dovràsopportare l’educatore stesso che siarmerà di pazienza e fiducia, come unbuon padre di famiglia e come ilPadre celeste che chiede anche seve-ramente al figlio di crescere, assom-mando in sé, secondo le circostanze,la figura di Madre dolce e amabile.
A tal proposito viene ricor-dato il classico di FratelAgathon “Le dodicivirtù del buonmaestro” se-condo l’inse-gnamento diSan GiovanniBattista deLa Salle.
Si educad u n q u enella “rela-zione”, nonfacendo predi-che. Non è que-stione di cose dadire e da sapere chenon porterebbero agrandi risultati ma occorrerapportarsi concretamente ai bi-sogni profondi dei discepoli, com-preso quello della religione chefacilita la soluzione dei problemi.
3. VERSO LA SANTITÀ
È il terzo aspetto importante del-l’educazione.
Occorre chiarire subito a tutti,grandi e piccoli, che la santità non èun optional o peggio un monopolio dipreti, frati e suore, ma un preciso enormale dovere di tutti i cristiani.
Con l’aiuto della grazia si spie-gherà ai ragazzi che è facile percorrerela strada della santità che porta sem-pre alla felicità autentica che nessunopotrà loro rubare. La santità è bella,realizzabile, conveniente perché offrebeni duraturi e non piaceri effimeriche passano presto lasciando l’amaroin bocca. Molti giovani alla scuola delLa Salle e di Don Bosco l’hanno giàmeravigliosamente raggiunta e sonoquindi modelli che incoraggiano e acui potersi ispirare.
È importante far balenare ai ra-gazzi ideali grandi, impegnativi, entu-siasmanti in vista di una pienarealizzazione di sé e delle persone cheincontreranno nella vita. È abba-stanza facile percorrere con loro lastrada della santità mentre con gliadulti, con tutte le loro complicazioni,
ordinariamente è richiesta più fatica.Il difficile è aiutare tutti a rimanerefedeli nella via intrapresa e a rientrareprontamente in carreggiata dopo gliinevitabili sbandamenti.
Due episodi del Vangelo parlanochiaramente della bellezza della san-tità che consiste in fondo nello sco-prire quel tesoro nascosto che è Gesù:sul monte Tabor, davanti a un Gesùsfolgorante di luce, Pietro dice: “Bellacosa per noi è stare qui…” e sulla viadi Emmaus ai due discepoli “ardeva ilcuore” nel camminare con Gesù e nel-l’ascoltare le sue parole.
Per incoraggiarli occorrerà ricor-dare frequentemente ai giovani che“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi esempre!” (Eb 13,8) nonostante il mu-tare delle stagioni.
Alla prova dei fatti si constata chenell’ambito educativo lasalliano e sa-lesiano il trinomio “amore - preven-zione - santità” funziona e scorrendole storie delle due nobili Congrega-zioni se ne possono ammirare gli ab-bondanti frutti. ◆
Raffaele Norti, FscAssessore Ex Allievi
Istituto La Salle Torino
44

temi educativi
Trovandoci a giugno nonpossiamo ignorare cosa questo pe-riodo significhi per la comunità sco-lastica. Per gli insegnanti è tempo diesami o di scrutini per dare, primadella meritata pausa estiva, la propriavalutazione finale sul lavoro svoltodagli studenti. Per i genitori segnal’inizio di nuovi cambiamenti, dallatensione degli esami alle sorpresedella pagella che, a secondo degliesiti, possono generare impatti anchemolto significativi sull’andamento fa-miliare del periodo estivo.
“Last but not least” (noi di-remmo “ultimi ma non meno im-portanti”…) gli studenti che
vedono aumentare ulterior-mente il loro stress per la“prova delle prove”, ossial’esame di Stato, oppure peri risultati della pagella come
bilancio del proprio lavoro di nove mesi.Questa fase conclusiva porta alla
mente un concetto molto noto ai Me-dici e agli Psicologi rappresentato dalbinomio prevenzione/cura, oggiquanto mai difficile da equilibrare.
Ma per capirlo meglio occorre fareuna breve premessa.
L’esperienza professionale quoti-diana, arricchita da molti confronticon colleghi Psicologi che operanonella scuola, sta evidenziando una si-gnificativa inversione di tendenza nelcomportamento di genitori e figli.
Da un lato si assiste a una gra-duale riduzione del numero di genitoriche partecipano ai corsi di formazionesulla comunicazione a loro dedicati,dall’altro si evidenzia un notevole in-cremento degli studenti (a volteanche dalla prima media) che chie-dono ai genitori di essere aiutati daun professionista per risolvere le pro-prie difficoltà.
Entrambe le attività coinvolgonolo Psicologo ma con una sostanzialedifferenza: nel primo caso ci si occupadi prevenzione di potenziali problemimentre nel secondo caso di soluzionia problemi già in essere.
È ovvio che il comune buon senso,oltre ai vari codici etici e deontologici,imporrebbe in ogni campo di lavoraremolto più sulla prevenzione che sullarisoluzione di problemi ma sappiamoche tra teoria e pratica c’è una belladifferenza.
All’inizio dell’anno si parte contanti buoni propositi, speranze e aspi-razioni che ci aiutano ad affrontareun lungo percorso spesso denso di in-sidie, imprevisti o sorprese inaspet-tate.
Il cosiddetto “pensiero magico”, oun naturale fatalismo, ci spinge peròa volte a sottovalutare l’importanzadel nostro contributo rispetto aquanto ci accade nella vita quoti-diana.
Se ricordate nel numero di Lasal-liani n.42/2014 parlavamo del cosid-detto LOC (locus of control) ossia lanostra attitudine soggettiva a valu-tare i fattori causali di eventi, feno-meni, risultati o azioni in genere.
Guido Orsi,psicologo ex-alunno
PAGELLE ED ESAMI:È TEMPO DI BILANCI...
45

46
temi educativi
Questo costrutto può essereesterno o interno.
Facciamo un esempio: ho preso 4all’interrogazione di latino perché ilProfessore ce l’ha con me (LOCesterno) oppure perché ho studiatopochissimo (LOC interno).
Chiaro il concetto?Bene, quando iniziamo l’anno do-
vremmo orientarci molto più a un ap-proccio “interno” ossia al fatto chenulla osta a una nostra prestazioneeccellente se noi davvero vogliamoaverla e la cosa ci soddisfa quantodovrebbe.
Dico questo perché il “filmetto”cui assistiamo ogni fine anno è unfestival di LOC esterni della serie “mel’ha fatta pagare…” oppure “io equella di latino non ci siamo maiprese” o ancora “se non studi comevuole lui ti dà il debito”….e così al-l’infinito.
In parole povere, “la sfortuna èl’alibi perfetto per qualsiasi falli-mento”.
Molte volte mi sono trovato difronte a studenti (e purtroppo anchea genitori….) che erano ultra-convintiche non avrebbero MAI potuto pren-dere un 8 in greco o in matematica;la mia risposta/domanda, ovviamenteprovocatoria, era del tipo “bene, mistai dicendo quindi che hai dei deficitcognitivi?”.
A questo punto ogni studente eracostretto ad ammettere (sorri-dendo…) che il famoso MAI era le-gato solo a questioni di motivazionee di impegno.
Questo fenomeno, purtroppo oggisempre più diffuso, rimanda a un altrocostrutto psicologico ben identificato
gestire in modo efficace il proprio an-damento scolastico.
La pianificazione è, infatti, il gapche separa l’approccio “preventivo” daquello “riparativo”.
Per poter prevenire qualsiasi feno-meno ci si deve sedere a tavolino, ana-lizzare il problema e capire cosa si puòfare per poterne anticipare gli effetti.
Quindi, tornando al discorso ini-ziale, una grande partenza a settem-bre è la migliore prevenzione perevitare brutte sorprese a giugno.
Viceversa, un rush finale adaprile/maggio rischia di essere, salvorari casi, una “cura” palliativa a undisastro annunciato e ormai irrecu-perabile.
La bella pagella o il voto finale bril-lante s’impostano dall’inizio, si man-tengono nel prosieguo e si consolidanoalla fine del percorso di studi.
Questo approccio è auspicabile senon altro per prepararsi adeguata-mente al tuffo nell’oceano universi-tario dove non esistono professoriindulgenti, genitori in veste di avvo-cati difensori, corsi di recupero, debitida sanare, ecc.
Un esame universitario non supe-rato è un fallimento e basta; il profes-sore può essere apostrofato con tuttigli aggettivi possibili ma resta il giu-dice unico del nostro piano di studi.
Che ci piaccia o no, più si va avantinella vita, e più ci si accorge che ognisistema (scolastico, sociale, lavora-tivo, ecc.) ci ricambia in modo propor-zionale a quello che abbiamo offertocome nostro contributo. ◆
che va sotto il nome di “auto-effica-cia” ossia “le convinzioni circa le pro-prie capacità di organizzare edeseguire le sequenze di azioni neces-sarie per produrre determinati risul-tati” (Bandura, 2000); tradotto inparole semplici: ce la posso fare omeno.
In realtà, l’incapacità nativa a su-perare ostacoli è quanto di più falsoe fuorviante oggi si possa attribuire ainostri giovani.
I loro comportamenti sociali deno-tano che siamo di fronte a ragazzibrillanti, intelligenti e capaci; quelloche spesso manca è l’interesse, la mo-tivazione e la spinta ad affrontare lesfide che la vita ci propone.
Qui l’appello va ai genitori e agliinsegnanti affinché possano trasmet-tere ai ragazzi quel senso di respon-sabilità e di interesse nello studiocome condizioni di base per un futuroimpegno nella vita in genere.
Un’altra interessante tendenzache emerge dai miei colloqui quoti-diani con gli studenti è la scarsa abi-tudine alla pianificazione dellapropria attività di studio con tanto diobiettivi e piani di recupero.
In altre parole, non essendoci mo-tivi credibili per cui qualsiasi studentepossa escludere a priori una presta-zione eccellente, basterebbe farsi unpiccolo piano dell’anno per poter

Grafologia: un altro modo per conoscere l’uomo
esperienze
Qualcuno scambia ancora la gra-fologia con un metodo di indagineparascientifica adatto per maghi e in-dovini, per comporre oroscopi e pre-dire il futuro: niente di tutto questo.Ci siamo mai domandati perché nonè possibile trovare una scrittura per-fettamente uguale a un’altra? comenon è possibile trovare lineamenti ecaratteri in tutto identici tra loro?Come una certa mimica, le improntedigitali, un caratteristico modo dicamminare, di gestire e di atteggiarsiappartengono a noi e solo a noi, cosìuna scrittura, anche contraffatta,contiene dei segni inconfondibili diappartenenza al suo autore.
A scuola impariamo tutti lo stessomodello calligrafico, ma poi ognuno dinoi scrive in una maniera del tuttopersonale. Per questo non vi è legisla-zione che non riconosca a un auto-grafo il valore di prova sull’identità
personale di chi l’ha fatta. È difficilecredere però, ancora oggi, che la scrit-tura sia un mezzo idoneo a rivelare ilnostro carattere, la nostra intelligenzae la nostra personalità. Credo chevalga la pena sapere qualcosa di piùsu questa materia per conoscere più afondo noi stessi e gli altri.
La spiegazione neurofisiologicaLo scrivere, un atto che ci è così
familiare da apparirci banale, è in re-altà un’operazione estremamentecomplessa, perché il movimento delledita della mano, del polso, dell’avam-braccio, del braccio e della spalla haorigine dalla complessa attività delnostro cervello. Gli impulsi cerebrali,attraverso il midollo spinale e i nervi,permettono alla mano di scrivere inmodo ordinato o disordinato, calmo oveloce, tondo o spigoloso, fermo otremolante, grande o piccolo, con
maggiore o minore pressione, con piùo meno estensione nello spazio. Il si-stema nervoso centrale a sua volta èinfluenzato dalle emozioni e daglistati profondi e anche inconsci del-l’animo. Possiamo quindi considerarela scrittura di una persona come unelettroencefalogramma della psicheche ci consente di capire a fondo lanostra personalità.
Un po’ di storiaL’interesse verso il significato delle
grafie si è manifestato in India, inCina, nell’antica Grecia, e nella Romaimperiale. Di particolare importanzaci appare l’affermazione dello storicolatino Svetonio che, nel De vita Cae-sarum, ci dice che, dalla scritturadell’imperatore Augusto, si potevanocapire degli aspetti del suo carattere.
Dopo la lunga parentesi medie-vale, di spiccato interesse per la gra-fologia, viene considerata lapubblicazione da parte di CamilloBaldi, professore di Logica e Metafi-sica nell’università di Bologna di unsaggio dal titolo: Come da una letteramissiva si conoscano la natura e lequalità dello scrivente.
Però solo con l’inizio dell’Otto-cento sono sorte scuole grafologicheeuropee, rappresentative di un me-todo d’indagine basato su ricerche estudi sistematici. Il fondatore del me-todo grafologico può essere conside-
47
Giuseppe Eusepi,Fsc grafologo

esperienze
rato l’abate Jean-Hippolyte Michon,francese, che nel 1871 fonda la So-ciété de Graphologie e il famoso pe-riodico La Graphologie.
In Italia sono due le scuole grafo-logiche più autorevoli e rappresenta-tive: quella morettiana fondata daGirolamo Moretti (1878-1963) equella marchesaniana fondata daMarco Marchesan (1899-1991)
Gli aspetti che vengono analizzatia. Movimento
La prima cosa che si studia, nel-l’analisi della scrittura, sono i quattromovimenti, in avanti, all’indietro, inalto e in basso, che compiamo con lanostra penna sul foglio, che ci indi-cano come noi percepiamo la realtàcon la nostra intelligenza, con i nostrisentimenti, con la nostra volontà. Imovimenti che produciamo con la no-stra penna hanno lo stesso significato
di quelli che facciamo giornalmentecon tutto il nostro corpo per gestire inostri interessi, i nostri progetti, i no-stri incontri con gli altri.
b. PressioneÈ anche molto importante studiare
la pressione, con cui facciamo i nostrimovimenti quando scriviamo, perchéci rivela in maniera del tutto partico-lare, l’energia psicofisica che emet-tiamo con significati molto importanti
per la conoscenza della nostra perso-nalità.
c. FormaQuando scriviamo ognuno di noi
trasforma il modello delle lettere, ap-preso a scuola, secondo il propriomodo di vedere e agire nella vita, evi-denziando il proprio modo di essere edi rapportarsi con gli altri.
d. SpaziInfluenzati dalle nostre emozioni e
stati d’animo, lasciamo fra le parole, let-tere, righe, margini, spazi più o menoampi rivelando come gestiamo i nostrispazi personali nei rapporti con gli altri.
e. FirmaNella nostra firma mostriamo la no-
stra realtà più intima, il nostro io idealementre, nella produzione del testo, il no-stro comportamento nei riguardi del-l’ambiente. In essa hanno libero sfogo lemanifestazioni dell’inconscio. ◆
48
IN VETRINA
Mario Chiarapini, Il sigillo dello Spirito, Paoline, Milano 2015.
Il lavoro, strutturato in 28 incontri, nasce come sussidio per la prepa-razione dei ragazzi alla Cresima. Insieme ad alcune tematiche riguar-danti la fase della crescita e la ricerca della propria identità umana ecristiana, vengono toccati gli aspetti più importanti della religione, in-dispensabili prerequisiti per affrontare argomenti più specifici, dalmomento che la società in cui viviamo è alquanto scristianizzata epriva di quell’humus religioso presente invece nelle generazioni pas-sate. La preparazione al sacramento, così come inteso da Fratel Mario,prevede: un punto di partenza (l’esperienza), un punto di riferimentoe una bussola per il viaggio (la Parola di Dio), un punto di arrivo euna meta (la confessione della fede, celebrata nel mistero liturgico e vissutacon un progetto di vita); in poche parole, un cammino catecumenale,
durante il quale vengono percorse alcune tappe fondamentali, quali la scoperta dellaChiesa come comunità, la scoperta della propria identità cristiana, la scoperta della propria vocazionee missione, la scoperta del lavoro che si è chiamati a svolgere all’interno della comunità. Se ai cresi-mandi verrà assicurata una significativa e valida preparazione, il dopo-cresima sarà altrettanto validoe significativo. Il lavoro, nato sul campo, preparando dei gruppi alla Cresima, risponderà di sicuroalle aspettative dei catechisti e degli animatori.

49
(Omelia pronunciata durante la Messa)Cara Comunità degli Anziani e carissime Suore che, in questi ultimi anni, avete assistito FratelRiccardo con amore e dedizione, grazie di cuore da parte di tutta la Provincia dei Fratelli delleScuole Cristiane.
Carissimi Fratelli, cari parenti, ex-alunni e amici che avete conosciuto Fratel Riccardo,devo dire sinceramente che provo un grande imbarazzo nel fare questo mio intervento e, quando il Visitatore1 mi hachiesto di commemorare il Fratello, sono stato tentato di rinunciare. Ma non ho potuto. Tanti gli anni vissuti insieme alui, tante le esperienze che abbiamo condiviso! E poi, l’essere suo compaesano, e non ultimo, una certa parentela da partedi mio padre, mi ha incoraggiato a parlare.Ho accettato dunque e, dopo aver cercato di ordinare i pensieri e i sentimenti provati alla notizia della sua morte, hodeciso di rivolgermi a Fratel Riccardo con una lettera per sentirmi più a mio agio, riuscendo forse a svelarvi un po’ dellasua umanità fragile e sensibile, disarmata e disarmante, tuttavia sempre autentica, della sua semplicità e profonda bontà,del suo amore per il suo paese d’origine e per la sua vocazione.Normalmente, quando una persona lascia questa vita terrena per la nuova vita piena di luce, i nostri ricordi vanno allesituazioni più belle, ai momenti più lieti, anche se poi, doverli riassumere non è tanto facile. Francis Scott Fitzgerald af-fermava che “la felicità si può spiegare in due parole”, così come la vita di Fratel Riccardo, che è stato uno che amavavivere e sentirsi vivo, che ha amato la sua famiglia e la sua Congregazione, che ha amato ed è stato amato.
Caro Fratel Riccardo, o Corrado, come i tuoi parenti e la maggior parte dei nostri paesani ti ha sempre chiamato, sonocerto che mi stai ascoltando e che, seduto in un angolo, magari a uno degli ultimi posti di questa chiesa, stai sorridendo,schernendoti di dover stare oggi, tuo malgrado, al centro dell’attenzione, tu che hai sempre preferito stare dietro le quintecon modestia e discrezione, cercando di non essere invadente, quasi preoccupato di disturbare.Sei stato sempre legato alle piccole cose. Piccolo per te era sinonimo di bello, e lo era ancora di più ogni cosa che ti ri-cordava le tradizioni, certi luoghi della tua giovinezza e dei primi anni di insegnamento, alcune particolari situazioni e lepersone che hanno avuto un ruolo importante nella tua vita, come pure il calore di uno sguardo e di un sorriso.Ogni tanto sono venuto a farti visita, in questi ultimi anni, ma forse troppe poche volte, rispetto agli incontri settimanali
che ho avuto con te per circa vent’anni a Grottaferrata, quando venivoper animare i bambini del Coro. Un coro di cui eri molto orgoglioso, tuche amavi tanto la musica, tu che avevi frequentato per alcuni annil’Istituto di Musica Sacra, tu che negli anni di San Salvatore in Laurohai potuto seguire le vicende della gloriosa Cappella Giulia e che daragazzo hai suonato il flicorno sopranino in mi bemolle, nella bandamusicale del paese.Nei tuoi anni giovanili hai svolto la professione di maestro, quando in-segnare voleva dire soprattutto educare. I numerosi ex-alunni presentioggi e quelli che negli anni venivano regolarmente a trovarti sono latangibile dimostrazione che hai lasciato in ognuno di loro un’impronta. Dal 1947 al 1951, sei stato inviato a insegnare nell’Istituto BartoloLongo di Pompei. Comunità numerosa, tanti giovani Fratelli, entusia-smo delle prime esperienze di maestro e appassionate partite di calcio!Poi, un’esperienza pionieristica di appena un anno all’Istituto SacroCuore di Manfredonia con il nostro compaesano Fratel Pellegrino Chia-varelli e un Direttore che, a tuo dire, scherzando, mettevate sempre inminoranza, essendo solo in tre. In seguito, l’obbedienza ti ha portato a Roma, dapprima nella scuola AngeloBraschi, in San Salvatore in Lauro, dove sei rimasto per ben diciassette anni,di cui gli ultimi otto come Direttore e incaricato della Schola Cantorum,quindi, al Colle La Salle come direttore generale di tutta l’istituzione.
Una persona semplice e sensibile: Fratel RICCARDO BUCOSSIGradoli (VT) 10/06/1928 - Roma 17/02/2015
l’ultima campanella

50
Nel 1980, sei ritornato a dirigere la scuola Angelo Braschi che, nel frat-tempo, lasciata la sede romana, si era trasferita a Grottaferrata. Ed è lìche con le tue buone capacità comunicative ti sei circondato di ottimicollaboratori, tanto che la scuola ha goduto di un periodo in cui le classirigurgitavano di alunni. In quegli anni, esattamente nel 1993, hai avutoanche la soddisfazione di celebrare il bicentenario di fondazione dellascuola voluta dal papa Pio VI. Il gran raduno che, per la circostanza, ci fudi ex-alunni ti riempì il cuore di gioia. Quando ti venivo a trovare, anchenegli ultimi tempi, ricordavi ancora commosso e felice quel grande anni-versario. Per te è stato il sigillo dei lunghi anni dedicati alla scuola Braschi,alla quale con merito hai legato il tuo nome e contrassegnato un’epoca.Caro Fratel Riccardo, gli ultimi anni della tua vita, segnati dalla sofferenza,hanno avuto anche momenti di consolazione, grazie alle visite di coloroche ti hanno voluto bene e che per qualche momento riuscivano a fartirivivere le gioie del passato. Ora vivi nell’eternità e nella luce senza tramonto.Ora, come ci assicura la fede, la tua vita non è tolta ma trasformata;ora, hai la certezza di ciò che noi speriamo ancora; ora, le sofferenze che hai provato e che ti hanno purificato, sonoterminate e ti danno modo di presentarti libero e felice di fronte alla Bellezza eterna, alla fonte dell’Amore e della Fe-licità senza limiti.
E tu, caro Fratel Riccardo, con le parole di sant’Agostino ci puoi assicurare che: “La morte non è niente. Sono solamentepassato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che era-vamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlaminello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.Prega, sorridi, pensami!”.
Mario Chiarapini, Fsc
La testimonianza di una collaboratrice
Non me ne vogliano gli altri direttori che negli anni si sono succeduti a fratel Riccardo nella conduzione della ScuolaBraschi, però credo che nessuno prima e dopo di lui si sia sentito così tanto legato alla vita di quella Scuola. Aveva unacarica e un entusiasmo travolgenti, sembrava quasi che la Scuola fosse nata con lui duecento anni prima! Grazie al suozelo e al suo entusiasmo, la Scuola Braschi è sempre stata una vera comunità educante alla quale mi sono sempre sentitaprivilegiata di appartenere, prima come genitore e poi come segretaria.Guardato come un padre, con infinito affetto dai nostri ragazzi, fratel Riccardo ha insegnato anche a noi genitori. Ha sa-puto far emergere i talenti di ognuno di noi e ci ha insegnato a metterli a servizio degli altri. Al tempo stesso, ci haaiutato a riflettere e a riscoprire i valori veri, quei valori che ci hanno tenuto insieme per tanti anni, che ci hanno fattocrescere e lavorare insieme nell’ambito della Famiglia Lasalliana di Grottaferrata, spingendoci a mantenere vivi principidi fede, di elevatezza morale e di cultura .Ripensare a quegli anni, a quello che è stato il suo apporto alla Famiglia Lasalliana, rappresenta per me, ma credo di in-terpretare il pensiero di molti altri, un vissuto profondo, ricco di emozioni, di fatiche, di speranze, di soddisfazioni e,talvolta purtroppo anche di delusioni.
Loredana Sarrocco
l’ultima campanella
La rivista viene inviata gratuitamente.Chi desidera contribuire alle spese può servirsi del
C/c postale n. 52041001oppure con un bonifico tramite Iban IT27A02008 05020000005215702
Causale: Lasalliani in Italia

51
Forse ha ragione Blaise Pascal quando scrive che “tutta l’infelicità degliuomini proviene da una cosa sola: dal non saper restare tranquilli inuna camera”. Ma la felicità non dipende soltanto dalla nostra capacitàdi riflettere e meditare in solitudine, benché questo sia un ingredientefondamentale. La socialità, l’altruismo, i legami d’amore e di amiciziacontano altrettanto. La conquista della felicità è il nostro chiodo fisso,inutile negarlo. Solo che, come per un sortilegio, pare che siamo irre-sistibilmente orientati a cercarla dove non c’è. Armando Massarentisuggerisce una via per trovare, ognuno con i propri mezzi, l’equilibrionecessario. La scommessa di questo libro è mostrare che una formula,neppure tanto complicata, ce l’avevano proposta i filosofi antichi, ela-borando massime ed esercizi pratici che disegnavano stili di vita im-prontati alla saggezza e al buon vivere. E l’efficacia di tale formula è
oggi confermata dagli esperimenti e dalle nuove scoperte di neuroscienziati e psicologi morali: da qui la proposta di tornaread attingere a una fonte che i secoli non hanno affatto inaridito. Così, dall’eros all’amicizia, dalla politica alla conoscenza, dallabellezza alla morale, Platone e Aristotele, Eraclito e Democrito, Epitteto e Marco Aurelio, Epicuro e Lucrezio, Seneca e Ciceroneci insegnano ad abbandonare le vie sbagliate e gli errori più comuni per trasformarci in fortunati cercatori di felicità.
Ero felice e non lo sapevoArmando Massarenti
Istruzioni perrendersi felici
Guanda 2014,pp. 165, Euro 13,00
Quante parole può nascondere un silenzio? Moltissime, soprattutto quandoè d’autore, carico di significati che vanno oltre quelli veicolati dalla lingua.Bice Mortara Garavelli attraversa le pagine letterarie più note sul silenzio,dalla classicità greco-latina fino alla letteratura dei nostri giorni, lungo un per-corso che rivela ciò che l’assenza di parole può dire. Il silenzio personificatocome nell’Orlando furioso di Ariosto; il silenzio meravigliato del montanaroche – in una similitudine della Divina Commedia – ‘ammuta’ quando vedeper la prima volta la città; il religioso silenzio di Chiara d’Assisi e quello ‘sfa-villante’ che Elsa Morante coglie nello stupore infantile; il silenzio ‘di chiostroe di caserma’ di Gozzano e il silenzio ‘che tutto nega e tutto comprende’ diLalla Romano. Il silenzio come reazione all’indicibile crudeltà in Primo Levi.Cos’è, allora, il silenzio? “Un linguaggio - dice Bice Mortara Garavelli - cheprovoca e spinge a interpretare ciò che non dico. È dolore, ma è anche indif-ferenza. È estremo, comunica momenti estremi. È una colpa per chi non ha avuto il coraggio di parlare e di ribellarsi. È una di-menticanza. È ciò che non è bene rivelare. È un’arma a doppio taglio, è un anguilla che sfugge di mano. È la «taciturnitas»benedettina che significa silenzio, obbedienza, umiliazione ma anche parlare là dov’è utile e necessario, un equilibrio tra taceree dire, un volontario e virtuoso silenzio. Uno svuotamento di sé, diceva il cardinal Martini, per ritrovarsi più autentici di prima.”
Il tema del libro di Julia Kristeva, nota studiosa di semiotica e psicoanalista,è un tema classico della psicoanalisi. Esso si interroga sui rapporti tra questadisciplina e l’esperienza religiosa della fede. Su questo punto Freud aveva te-nuto una posizione priva di sfumature: la religione è una “nevrosi” o, ancorapeggio, un “delirio” dell’umanità. Il testo di Julia Kristeva non ricalca questoorientamento. Piuttosto, si impegna nella ricostruzione di una genealogiadella ragione psicoanalitica che non ha a che fare con cifre, numeri, quanti-ficazioni aride, ma con l’esercizio della parola e dell’ascolto. La decisione er-meneutica di Julia Kristeva consiste nel riaprire un possibile dialogo trapsicoanalisi e fede scegliendo la via dell’amore. Il transfert è infatti la formache l’amore assume nel vivo dell’esperienza analitica. Il soggetto della psi-coanalisi è innanzitutto «il soggetto di un discorso amoroso». Ecco di cosa sinutre la parola dell’analisi. Non di cifre, numeri, parametri quantitativi, com-parazioni statistiche, ma della potenza di Eros, della forza dell’amore. Il pri-
mato della parola, la fede nell’amore: è ciò che hanno in comune il credente che prega e il paziente che si affida all’analisi.
Il senso della vitaJulia Kristeva
In principio eral’amorePsicoanalisi e fede
Il Mulino, 2015pp. 112, Euro 11,00
Eloquenti silenziBice Mortara Garavelli
Silenzi d’autore
Laterza 2015,pp. 152, Euro 18,00
Consigli per la letturaa cura di Alberto Tornatora docente lasalliano
in libreria