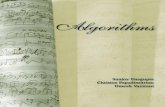3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
-
Upload
luiggilamantia -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
1/14
Tribunale di Milano, 27 marzo 2000 - DeLaurentiis e Filmauro s.r.l. c. CreditoSvizzero S.A., G.D. Fiecconi
Società di intermediazione mobiliare - Valo-re mobiliare - Definizione
Il legislatore del 1991, accedendo ad una nozio-ne aperta di «strumento finanziario» comprensi-va anche degli scambi su valute, rispetto alla de- finizione tradizionale di «valore mobiliare» chelo identificava con i titoli di massa, agganciati al
carattere della negoziabilità degli stessi, ha so-stituito una definizione di valore mobiliare nontenendo più conto della sua struttura o naturacartolare, bensì della finalità perseguita dalle parti, rilevando il carattere finanziario dellostrumento adoperato con caratteristiche tali da poter interferire sull’allocazione degli investi-menti e del risparmio. Nel concetto di valore mo-biliare ai fini dell’assoggettamento alla leggeSIM, pertanto, non rientra solamente il contrattodi swap come delineato dalla dottrina e dellagiurisprudenza, ma ogni contratto a termine cheoperi come strumento finanziario collegato a va-lori mobiliari, tassi di interesse o valute.
Società di intermediazione mobiliare - Valu-te - Scambi - Definizione
Se è vero che le valute sono in generale beni di-versi dai valori mobiliari, è anche vero che, per espressa disposizione della legge SIM, gli scam-bi su valute possono operare come «contratti atermine su strumenti finanziari e indici collegatia valori mobiliari, tassi di interesse e valute».
Società di intermediazione mobiliare - Com-pravendita di valute - Contratto di swap - Na-tura
Nel caso di operazioni di compravendita di valu-te, mai portate a termine alla data di scadenza,ma sempre chiuse con operazioni speculari di se-gno opposto, il cui regolamento si concretizzi conl’addebito/accredito dei flussi in valuta appog-giati su una coppia di conti correnti, di cui uno inlire e uno in valuta, che mantengano un saldo perfettamente nullo nel periodo di interesse, sì daavere un ruolo di transito fittizio, e ove sindall’inizio sia mancato lo scambio della res (va-luta), ci si trova di fronte ad una fattispecie so-stanzialmente unitaria ed assimilabile al contrat-to di swap, non tanto nella struttura formale, ma
attraverso la finalità perseguita, ove i trasferi-
menti di capitale sono «poste» puramente forma-li rispetto all’ordine di compravendita, in cui, insostanza, il pagamento delle differenze costitui-sce l’oggetto immediato e unico del contratto sti- pulato inter partes, sia all’atto della stipulazionedel contratto sia alla scadenza.
Svolgimento del processo
1. Il presente giudizio fa seguito ad un procedi-mento d’urgenza ex art. 700 Codice di proceduracivile (R.G. N. 1587/95) promosso dal dott. Au-relio De Laurentiis (di seguito denominato «De
Laurentiis» nei confronti del Credito Svizzeros.a. (di seguito denominato «Credito Svizzero»),a conclusione del quale, in data 3 gennaio 1996,il Giudicante, accogliendo le tesi espostedall’odierno attore, ha così disposto:«1) sussistendo il «fumus boni iuris» e il «periculumin mora», in accoglimento del ricorso, ordina alCredito Svizzero, di astenersi da ogni atto di escus-sione del pegno costituito dal ricorrente De Lauren-tiis a garanzia dell’apertura di credito concessa dalCredito Svizzero a Filmauro s.r.l. con lettera 29 ot-tobre 1993, sui titoli meglio indicati in ricorso, sel’esecuzione è da correlarsi alle operazioni di«compravendita a termine di valuta estera» meglioindicate e specificate nel ricorso introduttivo; 2) dispone che il Credito Svizzero restituisca alricorrente De Laurentiis i predetti titoli costituitiin pegno, se non trattenuti per altro e diverso ti-tolo da quello dedotto in giudizio; 3) visto l’art. 669-undecies Codice di proceduracivile, impone al ricorrente De Laurentiis che, en-tro 40 giorni, venga rilasciata fideiussione a pron-ta richiesta, per l’importo di Lire 3.000.000.000,da parte di primario istituto di credito, in favoredella parte resistente, come cauzione per l’even-tuale risarcimento dei danni in caso di soccom-benza nel giudizio di merito; 4) fissa il termine di 30 giorni per l’instaurazio-ne del giudizio di merito».
(è allegato agli atti il fascicolo di parte depositatonel procedimento d’urgenza con il provvedimen-to integrale reso dal G.D.).1.1. Nei termini assegnati con il provvedimentocitato, il De Laurentiis notificava al Credito Sviz-zero atto di citazione, con iscrizione a ruolo dellacausa in data 6 febbraio 1996.Successivamente anche la Filmauro, con atto dicitazione notificato in data 23 aprile 1996, citavain giudizio il Credito Svizzero. Alla prima udien-za del primo giudizio, su richiesta concorde delleparti, il G.I. dott.ssa Pizzi disponeva la riunionecon il secondo giudizio. Alla stessa udienza ilG.I. provvedeva a nominare il C.T.U. nella perso-
na del prof. Stefano Preda.
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
777 I CONTRATTI n. 8-9/2000
Contratti in generale
IL NEGOZIO INDIRETTO APPLICATO AL CONTRATTO DI SWAP
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
2/14
All’udienza successiva, in data 12 febbraio 1997,a seguito del fallito tentativo di conciliazione del-le parti comparse personalmente, il G.I. ordinavaal Credito Svizzero la esibizione della seguentedocumentazione:(i) copia dei contratti di conto corrente intercorsitra le parti;(ii) contratti quadro richiesti dalla normativa di
settore;(iii) contratti di swap con relative fiches;(iv) contabili/ordini relative alle operazioni per cui è causa.Il G.I. rinviava quindi le parti all’udienza del 18febbraio 1997.A tale udienza il Credito Svizzero depositava unfascicolo contenente solo una parte della docu-mentazione di cui era stata ordinata l’esibizione(in particolare non veniva prodotta alcuna copiadei presunti contratti di conto corrente che si as-sume ex adverso essere intercorsi tra le parti, nécopia dei contratti richiesti dalla normativa di set-tore), mentre dichiarava la propria disponibilità a
consentire l’accesso al C.T.U. ai locali del Credi-to Svizzero in Milano.Alla udienza i Consulenti Tecnici prof. StefanoPreda e prof. Ignazio Basile prestavano giura-mento. Gli attori nominavano quale ConsulenteTecnico di parte il prof. Luigi Buzzacchi, mentreil Credito Svizzero riservava la nomina all’iniziodelle operazioni peritali (poi nominando Consu-lente Tecnico di parte il prof. Roberto Ruozi).Il G.I. formulava, quindi, i seguenti quesiti:«1. Dica il C.T.U. se ed attraverso quali forma-lità risultano documentati i contratti intercorsitra le parti, indicando altresì in quale schemacontrattuale sono classificabili. 2. Dica il C.T.U. se detti contratti risultanoadempiuti in conformità agli accordi intercorsitra le parti. 3. In ipotesi, quantifichi il C.T.U. l’eventuale ina-dempimento da parte della convenuta».L’inizio delle operazioni peritali veniva fissatoper il 4 marzo 1997.Alla successiva udienza del 24 settembre 1997, ilG.I., dopo aver nuovamente invitato le parti a tro-vare un accordo transattivo, fissava l’udienza per la precisazione delle conclusioni al 13 maggio1998. A quest’ultima udienza, tuttavia, il CreditoSvizzero depositava un parere pro veritate, conconseguente richiesta di termine per esame daparte degli attori.Alla successiva udienza del 14 ottobre 1998 leparti precisavano le conclusioni.
Motivi della decisione
Le domande attoree sono sostanzialmente fonda-te.Sostengono gli attori che, sin dall’inizio del1993, la Filmauro s.r.l. e, in epoca di poco suc-cessiva, il De Laurentiis (noto produttore cine-matografico, nonché amministratore delegato eprincipale azionista della Filmauro s.r.l.) venneroindotti dai responsabili del Credito Svizzero s.a.ad effettuare una serie di operazioni d’investi-mento con il medesimo istituto, attraverso la sti-
pulazione di contratti di compravendita a termine
di valuta e che, nella prospettazione fornita aiclienti, il rischio di tali operazioni fosse statosempre descritto come assolutamente contenuto econ promettenti possibilità di rendimento.Il De Laurentiis, sempre nel quadro dei rapportiche si andavano instaurando, fu indotto a stipula-re un contratto di gestione di patrimonio mobilia-re (cointestato alla propria coniuge Jaqueline
Baudit - v. doc. 15 fasc. provv. urg.), a fronte del-le assicurazioni dei funzionari della banca sullepromettenti aspettative di reddito correlate a unrischio molto contenuto, se non quasi nullo: nellagestione patrimoniale vennero conferiti circa L.4.700.000.000 nel periodo marzo-giugno 1993, eL. 1.000.000.000 nel periodo luglio-settembre1993.Nella fase iniziale del rapporto, instauratosi tra leparti come proposto dalla banca (compravenditaa termine di valuta), il De Laurentiis e la Filmau-ro, per loro stessa ammissione, dalle operazionisu valuta conseguirono effettivamente i marginidi profitto prospettati; a partire dalla seconda
metà del 1994, tuttavia, i contratti in essere ini-ziarono a generare ingentissime perdite, pari a L.2.001.686.020 nel 1994 e a L. 2.754.000.000 nel1995 per il De Laurentiis, e pari a L.2.499.989.474 per la Filmauro.Stando all’assunto degli attori, le modalità segui-te dalle parti per la conclusione delle singole ope-razioni erano le seguenti:1) i rapporti tra le parti di compravendita a termi-ne di valuta estera non erano regolati da alcuncontratto scritto, se si eccettua il contratto relati-vo al solo conto corrente n. 10/80745, intestatoalla Filmauro. L’unica documentazione esistenteè nella forma di estratti conto, relativi a quattroconti correnti, due dei quali, uno in lire e l’altro invaluta, intestati alla Filmauro, e gli altri due (dicui uno sempre in lire e l’altro in valuta) intestatial De Laurentiis;2) La Filmauro e il De Laurentiis acquistavano ovendevano una determinata quantià di valuta atermine. Le operazioni così aperte, di regola, nonvenivano portate a termine, ma venivano pareg-giate con un’operazione speculare di segno oppo-sto anteriormente alla scadenza dell’operazioneiniziale: le operazioni si chiudevano con il saldodelle differenze, accreditando o addebitando alconto corrente in lire la sola differenza tra i dueflussi in valuta alla data di scadenza delle opera-zioni a termine;3) oltre a non essere mai stato stipulato con ilcliente un contratto scritto avente per oggetto lanatura e le modalità di svolgimento dei servizi re-si dalla banca al cliente, non erano stati mai co-municati al cliente la natura e i rischi che le ope-razioni su titoli mobiliari atipici comportavano;4) inoltre, erano state concluse dalla banca opera-zioni in conflitto d’interesse con il cliente senzache il Credito Svizzero avesse comunicato per iscritto la natura e l’estensione del suo interesseal De Laurentiis e senza che quest’ultimo accon-sentisse, in via preventiva ed espressamente per iscritto, all’effettuazione di ciascuna operazione.Sul presupposto che, oggetto dello scambio tra le
parti, non era la valuta, il cui transito sui conti
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
778 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
3/14
correnti era puramente fittizio, bensì il differen-ziale, espresso in lire, tra le attività sottostanti(nel caso di specie le valute), gli attori ravvisava-no nelle suddette operazioni una serie di contrat-ti di swap, nell’accezione dottrinale, oramai ac-creditata anche dalla recente giurisprudenza, chesi realizza allorquando le parti concordano di ef-fettuare un solo pagamento pari alla differenza
(espressa in lire) tra il valore futuro delle due di-vise (cfr. Cass. 14 novembre 1997, n. 11279).Data la sua natura di strumento finanziario, assi-milato ai valori mobiliari, la conclusione del con-tratto di swap, secondo l’assunto degli attori, do-veva essere assoggettata alla disciplina di cui allalegge n. 1 del 2 gennaio 1991 e, in particolare, airequisiti di forma previsti dall’art. 6, 1 e 2 com-ma: in proposito venivano richiamate le pronun-ce più recenti della giurisprudenza, nonché l’or-dinanza dell’organo giudicante che aveva esami-nato la medesima questione nella fase cautelare(v. Trib. Milano, ord. 11 maggio 1995, in Foro It. Rep. 1996, voce valori Mobiliari, n. 54; Trib. Mi-
lano, ord. 3 gennaio 1996, in Foro It. Rep. 1996,voce valori mobiliari, n. 45; Collegio ArbitraleMilano 26 marzo 1996, Foro Italiano Rep. 1997,voce cit., n. 88; Trib. Milano, 20 febbraio 1997,in Giur. Milanese, 1997, 9, 1155), con le quali èstata sancita la nullità dei rapporti sui c.d. «titoliderivati», se non conformi ai requisiti di formaprevisti dalla predetta legge a tutela della traspa-renza del mercato dei c.d. valori mobiliari.La parte convenuta, di contro, sosteneva che leoperazioni poste in essere dalla Filmauro e dalDe Laurentiis non fossero state altro che compra-vendite a termine di valuta, a un prezzo predeter-minato al momento della stipulazione con conse-gna ad una data futura, eseguito con le seguentimodalità:1) gli attori vendevano o acquistavano a termineuna certa somma in valuta estera, a un prezzoprestabilito. Alla scadenza del termine il contrat-to veniva eseguito mediante la consegna della va-luta; nel caso in cui lo stesso operatore avessevenduto «allo scoperto», per non avere la dispo-nibilità materiale della valuta, quest’ultima veni-va reperita sul mercato;2) quando il prezzo della valuta sul mercato - iltasso di cambio - era diverso da quello predeter-minato, l’operatore traeva dal negozio una perdi-ta o un utile, pari alla differenza tra il tasso dicambio rilevato alla data di scadenza dell’opera-zione e quello predeterminato all’inizio dellastessa;3) l’operatore, alla scadenza, poteva poi decideredi rinnovare il contratto, liquidando immediata-mente la differenza determinata dal tasso di cam-bio, ed assumendo come base il tasso di mercatoal momento del rinnovo dell’operazione (rinnovoche nella prassi è chiamato riporto, da nonconfondersi con l’omonimo contratto di borsa).La tesi della convenuta, secondo cui i suddetti ne-gozi di compravendita a termine di valuta nonpotevano essere inquadrati nel concetto di swap,trova apparentemente conforto nelle direttiveemesse dalla Consob in materia di scambi di va-
luta, che saranno prese in considerazione più in-
nanzi, laddove si sancisce che la compravendita atermine di valuta non rientra nel concetto discambi di valori mobiliari ai fini della legge«SIM».Questo Giudice, tuttavia, ritiene che il caso inesame, prima di ricevere una classificazioneall’interno dell’una o dell’altra categoria nego-ziale, debba essere analizzato nel suo concreto
operare. Sicché, è necessario considerare la fatti-specie in esame in raffronto con gli schemi con-trattuali che si sono da tempo affacciati sullo sce-nario del mercato mobiliare, tenendo presenteche la legge Sim (legge n. 1/1991) di recente in-trodotta dal legislatore è nata dall’esigenza di ga-rantire la trasparenza degli scambi sui valori mo-biliari e di tutelare gli investitori i quali, muoven-dosi all’interno di un mercato ove notevoli sono irischi e la volatilità dei profitti, per quanto esper-ti, risultano comunque i contraenti più deboli.Non vi è dubbio che il caso in esame esige unconfronto diretto con il negozio di swap, il qualerientra nel concetto di «valore mobiliare» ogget-
to della tutela della predetta legge.In linea con quanto già ampiamente argomentatonell’ordinanza del 3 gennaio 1996, emessa nellafase cautelare del presente giudizio, nel contrattodi swap - richiamato dagli attori ai fini della qua-lificazione del rapporto instaurato tra le parti - siravvisa essenzialmente un contratto aleatorio me-diante il quale due parti si obbligano, l’una conl’altra, a corrispondere alla scadenza di un termi-ne, convenzionalmente stabilito, una somma didanaro (in valuta nazionale o estera) quale diffe-renza tra il valore (espresso in lire) di una sommain valuta estera al tempo della conclusione delcontratto e il valore della medesima valuta esteraal momento della scadenza del termine stabilito:trattandosi di un contratto a termine su valori mo-biliari, esso è soggetto alla disciplina della leggen. 1/1991 e, come tale, è da considerarsi validosolo se stipulato in forma scritta e se contienel’indicazione della natura dei servizi forniti, dellemodalità di svolgimento dei servizi stessi edell’entità e dei criteri di calcolo della loro remu-nerazione.In forza del suddetto principio, la giurisprudenzaha di recente dichiarato la nullità, ai sensi dell’art.6, lettera c), della legge n. 1/1991, delle confermedi esecuzione di singole operazioni di acquisto diswaps, sottoscritte dal cliente per accettazione, inassenza dell’accordo-quadro contenente le indica-zioni prescritte dalla norma nel primo e secondocomma (v. Tribunale di Milano, 20 febbraio 1997,in Giur. Milanese 1997, 9, 115; Tribunale di Tori-no, 10 aprile 1998, in Giur. Milanese; Corte diCassazione, sez. I civile, n. 11279-1997; Corted’appello di Milano, sez. I, 26 gennaio 1999, inGiur. Milanese n. 8-9, 1999, 257).Ciò posto, nella presente controversia, pur essen-do dati per pacifici i principi sopra richiamati inmateria di stipulazione di contratti di swap, risul-ta controversa la qualificazione della fattispecieconcreta entro la cornice dei negozi di swap. AiConsulenti Tecnici nominati dal Giudice, Prof. S.Preda e I. Basile, difatti, sono stati posti i seguen-
ti quesiti in relazione alla vicenda in esame:
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
779 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
4/14
1) se ed attraverso quali formalità risultano docu-mentati i contratti intercorsi tra le parti, indivi-duando altresì in quale schema contrattuale sianoriclassificabili;2) se detti contratti risultano adempiuti in confor-mità agli accordi intercorsi tra le parti.I CTU, Prof. Stefano Preda e Prof. Ignazio Basi-le, dopo avere ricostruito ed analizzato le opera-
zioni bancarie svolte dalle parti (v. rel. peritale,pp 1-20), hanno inquadrato i suddetti rapporti discambio di valori tra le operazioni a pronti e a ter-mine (secco o riporto in cambi), ritenendo che es-si non potessero essere classificati come opera-zioni derivate, nè del tipo «Domestic CurrencySwap» (DCS = contratto di swap tra residenti,con regolamento in lire italiane), nè del tipo Cur-rency swap (DS = contratto di swap avente per oggetto lo scambio di specifici ammontari, di va-lore attuale netto equivalente, relativi ad attività epassività espresse in valute diverse) (v. rel. peri-tale, p. 20).Per escludere la classificazione delle operazioni
nella categoria dei Domestic Currency Swaps, iconsulenti hanno ritenuto che concorressero i se-guenti requisiti:
– i DCS vengono utilizzati con finalità di coper-tura, mentre in questo caso la finalità delle partiera pacificamente speculativa;
– la maggior parte delle posizioni aperte a termi-ne, veniva chiusa con altre operazioni a termine,a differenza di quanto accade nei DCS, ove loscambio di valute si attua sul differenziale dei va-lori nel termine predeterminato. Difatti, il risulta-to economico delle operazioni era parti alla diffe-renza fra due tassi di cambio a termine e non aldifferenziale tra il tasso di cambio contrattuale eil tasso a pronti a scadenza;
– il risultato economico nasceva dalla combina-zione di più operazioni accese in tempi diversi enon da un’operazione unitaria quale il contrattodi swap, ove la durata delle operazioni viene pre-definita al momento della conclusione del con-tratto;
– i DCS non danno luogo alla rilevazione di mo-vimenti in conto capitale, ma solo del differen-ziale fra cambio a pronti a scadenza e cambio atermine, calcolato sul capitale di riferimento «no-zionale», mentre i contratti in cambi fra le partirisultano contabilizzati negli estratti conto secon-do le normali prassi bancarie. Di riflesso, il profi-lo finanziario si caratterizza per un’unica presta-zione a carico di uno dei due contraenti che è de-finita nel suo effettivo ammontare solo alla sca-denza, mentre - nel caso specifico - i rinnovi deicontratti e lo slittamento delle scadenze venivanodecisi di volta in volta e i conti correnti in lira e invaluta erano stati aperti in relazione alle opera-zioni in cambi e la dinamica delle operazioniconfigurava operazioni chiuse con acquisti e ven-dite contrapposte di valuta.I distinguo operati dai CTU sono apprezzabili aifini dell’individuazione delle diverse tipologiedei negozi di confronto e dell’inquadramentodella fattispecie nel suo concreto operare; questoGiudice, peraltro, prima di giungere a conclusio-
ni sulla qualificazione della fattispecie, ritiene
che debba essere presa in considerazione la rela-zione peritale anche nella parte in cui descrive ilcomportamento della banca nell’acquisto di valu-ta per conto dei clienti, la quale ha applicato laseguente procedura.In particolare, risulta che sono stati aperti alcuniconti correnti di appoggio in lire e in valuta inte-stati a De Laurentiis e a Filmauro e, a detta dei
CTU e delle parti, le operazioni svolte originava-no da conversazioni e ordini telefonici, operati-vità che è tipica dei clienti abituali della banca (v.rel. CTU, p. 26). Le operazioni in cambi eranodocumentate dall’emissione di apposite fiches eda comunicazioni di conferma dell’operazione daparte della banca al cliente, controfirmate in co-pia da quest’ultimo; gli estratti conto in lire e invaluta riportavano le registrazioni delle operazio-ni svolte.Le operazioni a termine della Filmauro iniziaro-no contestualmente alla concessione di una lineadi credito di 23 milioni di dollari concessa dalCredito Svizzero in data 8 gennaio 1993, con sca-
denza 7 giugno 1993; a garanzia delle obbliga-zioni derivanti dall’utilizzo della linea di credito,Filmauro aveva costituito in pegno, alla stessadata, tutti i crediti nei confronti di CS Finanzia-ria, ricollegabili a un finanziamento di 7 miliardicon scadenza 7 giugno 1993, concesso da Fil-mauro a favore di CS Finanziaria: mentre nonesiste agli atti una traccia formale del rinnovodella linea di credito, i CTU hanno espressamen-te riferito che il rinnovo si deduce dal fatto che al-la scadenza è stato rinnovato il contratto di pegnooriginario e che la linea di credito non è stata re-vocata sino al 26 giugno 1993.Le operazioni a termine effettuate dal De Lauren-tiis nel proprio interesse non possono invece es-sere ricondotte alla apertura di una linea di credi-to, in quanto - stando ai rilievi dei CTU svolti nelcontraddittorio delle parti - era prassi del CreditoSvizzero operare in cambi con la clientela priva-ta senza la preventiva concessione di una linea difido e tali operazioni non erano assistite da alcu-na garanzia.È stata prodotta, in merito alle operazioni svolte,la trascrizione di una sola conversazione telefoni-ca, dalla quale i CTU hanno dedotto che il DeLaurentiis aveva una buona conoscenza tecnicadelle operazioni in esame, era informato sullecondizioni praticate da banche concorrenti e avo-cava a se stesso la decisione finale di operare omeno. Dalla suddetta trascrizione, tuttavia, è im-possibile accertare se l’iniziativa fosse stata presadalla banca o dal cliente. Per quanto attiene allatrascrizione delle altre conversazioni telefoniche,i CTU Prof. Stefano Preda e Prof. Ignazio Basileriportavano che, a dire della banca, se ne era per-sa ogni traccia, dal momento che è prassi dellabanca conservarle per pochi mesi, per poter riuti-lizzare i nastri di registrazione.La ricostruzione delle operazioni svolte dallabanca è efficacemente riportata alle pp. 35-39della relazione dei Ctu nominati (cui questo giu-dice si riporta integralmente quanto alla parte ri-costruttiva dei rapporti), ove il De Laurentiis ri-
sulta avere operato sempre come unico interlocu-
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
780 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
5/14
tore della banca anche per conto della Filmauro.Tutte le operazioni svolte risultano documentatenegli estratti conto, nelle fiches e nelle Comuni-cazioni Valutarie Statistiche. In tutto, le operazio-ni in cambi svolte sono state pari a 66 per Fil-mauro e a 41 per De Laurentiis.In particolare, per Filmauro si rilevano 10 opera-zioni di chiusura di posizioni di valuta contro lire
precedentemente aperte nell’arco di un periodoche inizia con la prima operazione il 19 febbraio1993 e si conclude con l’ultima operazione il 4febbraio 1994. Le operazioni che si concludonocon un utile per il cliente sono 9. Un’unica opera-zione si è conclusa con una perdita per il cliente(F42 chiusa con F44) e tali operazioni hanno de-terminato un utile complessivo di L. 701.900.000lire. Inoltre, si rilevano 20 operazioni di chiusuradi posizioni valuta contro valuta precedentemen-te aperte nell’arco di un periodo che inizia con laprima operazione il 5 febbraio 1993 e si concludecon l’ultima operazione il 12 agosto 1994. Traqueste, 19 si concludono con un utile per il clien-
te e un’unica operazione determina una perditaper il cliente (F66): il bilancio va in perdita per ilcliente per la cifra di 3.201.889.508 lire.Per il De Laurentiis, complessivamente, si rileva-no 11 operazioni di chiusura di posizioni valutacontro lire precedentemente aperte nell’arco diun periodo che inizia con la prima operazione il10 agosto 1993 e si conclude con l’ultima opera-zione il 29 marzo 1995. Le operazioni che si con-cludono con un utile per il cliente sono 5 e quelleche si concludono con una perdita sono 6. Talioperazioni determinano una perdita complessivadi L. 3.556.435.000.Per il De Laurentiis, si rilevano 6 operazioni dichiusura di posizioni valuta contro valuta per unperiodo che va dal 30 agosto 1993 e si concludecon l’ultima operazione il 12 agosto 1994. Leoperazioni che chiudono con un utile per il clien-te sono 3 e altrettante tre si chiudono con una per-dita. La perdita complessiva ammonta in L.1.058.008.281 lire.Come ben sottolineato dai CTU, Prof. Preda eProf. Basile, l’operatività era continua e per im-porti rilevanti e ha dato luogo a singoli risultatieconomici per circa due anni, di cui alcuni in uti-le e altri in perdita: inoltre, non risulta agli attiche siano state contestate inadempienze rispetto atutte le operazioni svolte prima delle ultime, chehanno dato luogo alle perdite più rilevanti.Per la Filmauro, le contestazioni muovono a par-tire con le operazioni di acquisto a termine di 10milioni di USD (dollari statunitensi) contro DEM(marchi tedeschi) con valuta 16 agosto ad unprezzo di 1,7726, cui sono seguite ulteriori ope-razioni di acquisto a termine di USD contro DEMper la stessa scadenza del 16 agosto 1994 (F59-F65). Tutte queste operazioni sono chiuse il 12agosto 1994 con un’unica operazione di vendita apronti di 24 milioni di USD contro DEM ad unprezzo unitario di 1, 5554 che interrompe l’interasequenza di operazioni in cambi, determinandouna perdita di L. 4.907.521.520.L’attore Filmauro contestava formalmente e per
iscritto l’iniziativa della banca relativamente a ta-
le operazione di chiusura per le modalità irritualiseguite dalla banca, perché le operazioni non ve-nivano mai portate a termine alla scadenza, mavenivano sempre chiuse con operazioni specularidi segno opposto prima della scadenza e il rego-lamento dei rapporti si concretizzava con l’adde-bito/accredito dei flussi in valuta, appoggiati suuna coppia di conti corrente, di cui uno in lire e
l’altro in valuta (v. allegati della rel. Buzzacchi;di parte attrice).Nell’espletamento dei negozi di compravendita,tutti i conti corrente in valuta avevano sempremantenuto un saldo perfettamente nullo nel pe-riodo di interesse, il che consente di affermareche essi avessero un ruolo di transito fittizio ai fi-ni dell’intermediario, considerazione confermataanche dall’essenza di qualsiasi onere di manteni-mento a carico dei clienti della banca.I CTU, inoltre, hanno osservato che la banca, per tutelarsi dell’assenza di adeguate garanzie, in unasituazione di perdite latenti per i clienti, avessedeciso unilateralmente di non prorogare le posi-
zioni aperte da Filmauro/De Lautentiis, determi-nando per questi ultimi la realizzazione di consi-stenti perdite, non altrimenti ripianabili.A parere dei CTU, la Filmauro e il De Laurentiisin proprio, avrebbero potuto procedere al rinviodella chiusura definitiva della posizione attraver-so operazioni di riporto in cambi; tuttavia, ciònon avrebbe cancellato la perdita, ma avrebberinviato la sua quantificazione definitiva nel tem-po, rinviando contestualmente la posizione di ri-schio, che avrebbe potuto aggravarsi o migliora-re in modo non prevedibile a priori (v. rel. CTU,pp. 37-38).Altra alternativa alla chiusura dell’operazione sa-rebbe stata il ritiro, da parte di Filmauro e di DeLaurentiis, del capitale nominale investito e ilcontestuale pagamento del controvalore in lire; laperdita, difatti, esisteva indipendentemente dalladecisione di chiudere l’operazione per il «sempli-ce fatto che il prezzo a pronti del cambio risulta-va inferiore ai prezzi di acquisto a termine» (v.rel. CTU, p. 37). Tuttavia, i CTU osservavanoche «non è nella logica di queste operazioni pro-cedere alla consegna degli ammontari in lire o invaluta, bensì di regolarle per differenza, comed’altronde era successo in questo rapporto trabanca e clienti in tutte le operazioni precedenti»(v. rel. CTU, p. 37).Questo Giudice, dall’esame dell’andamento deirapporti intrattenuti dalle parti come efficacemen-te ricostruiti dai CTU nominati, ritiene di poteretrarre conclusioni diverse da quelle dei periti no-minati dall’Ufficio, che hanno escluso analogiecon i contratti di swap. Il fatto che la documenta-zione fornita dal Credito Svizzero classifichi leoperazioni come semplici compravendite a termi-ne di valuta, e non come swap, non è in alcun sen-so probante; né è possibile comprendere la naturadelle operazioni bancarie poste in essere, se non siverificano gli intenti per i quali le posizioni veni-vano aperte, eventualmente riportate e chiuse.Nelle attività speculative appoggiate dalla banca,è indiscutibile che gli attori non intrattenevano
presso il Credito Svizzero alcuna attività reale
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
781 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
6/14
(commerciale o industriale) in valuta e che non viera alcuna giustificazione diretta nel ritenere ope-ratori qualificati i due soggetti ordinanti le opera-zioni di cui sopra, né vi era alcuna funzione di co-pertura dai rischi di cambio dell’attività di com-pravendita di valuta a termine. Non vi era, so-prattutto, alcun intento di spostamento di capita-li, che in genere giustifica la compravendita a ter-
mine di valuta: d’altro canto, i successivi riportidelle operazioni in perdita, sia nel caso Filmauro,sia nel caso De Laurentiis, erano tentativi di rien-trare da perdite speculative, piuttosto che scienti-fiche applicazioni di tecniche di copertura.Ciò che si coglie nell’andamento dei rapporti èche, nella vicenda esaminata, il Credito Svizzero,pur essendo stato il soggetto che ha inizialmenteproposto gli investimenti, concedendo anche unaconsistente linea di credito ai propri clienti, nonha poi svolto un ruolo in termini di servizio pro-fessionale di consulenza e di tutela a supportodell’attività finanziaria di De Laurentiis-Filmau-ro, tant’è che si è semplicemente rifiutato di
adempiere gli ordini del 26 agosto 1994, quandosi era verificata una perdita secca per i propriclienti a causa del rialzo del marco tedesco sullavaluta nazionale.L’attività svolta dalla banca, di propria iniziativao su impulso dei clienti, in ogni caso, ha portatoad esposizioni di assoluto rilievo, sia in termini dientità, sia di rischio, senza che da parte del Cre-dito Svizzero fosse stata previamente fornital’informativa necessaria per garantirsi la pienaconsapevolezza dell’investitore.I consulenti, peraltro, non hanno potuto appurare,mancandone la necessaria documentazione, se ilCredito Svizzero avesse operato in conflitto d’in-teresse con i propri clienti (come denunciato da-gli attori), poiché le modalità di copertura delleoperazioni a termine effettuate dal Credito Sviz-zero sono rimaste oscure: la banca, difatti, trasfe-riva le operazioni ad altre filiali estere del gruppo(CS di Londra e CS New York), di cui non si co-noscono le operazioni di segno contrario, e cosìfacendo risultava quale semplice intermediariadelle operazioni sui cambi.Il CT di parte attrice faceva notare che le opera-zioni di apertura e chiusura delle operazioni piùrilevanti fossero avvenute sempre in corrispon-denza di punti di massimo e di minimo relativo,nei quali anche più elevata era la «volatilità» deicambi: il che - diversamente da quanto sostenutodai CTU - denota segnali alquanto espliciti disprovvedutezza che non giustificano un tratta-mento da «operatori qualificati» ed esperti di DeLaurentiis e Filmauro (v. rel. Luigi Buzzacchi).Difatti, alla chiusura dell’operazione DL41(quella che ha comportato le più elevate perdite eche ha avuto luogo al momento della massimaquotazione del marco), il De Laurentiis dimostra-va di non aver compreso i meccanismi di funzio-namento dei mercati derivati, lamentando comel’operazione fosse stata chiusa con due giorni dianticipo rispetto alla scadenza, causando con ciòperdite ingenti (v. carteggio allegato alla relazio-ne del CT Buzzacchi).
A parere del Giudice, come ben delineato nel pa-
rere pro veritate del Prof. Guido Rossi, deposita-to dalla convenuta, rispetto agli swaps, le opera-zioni in cambi poste in essere con intento specu-lativo si differenziano, sia perché non hannostruttura unitaria e derivata, sia per la causa. Di-fatti, la causa della compravendita a termine divaluta è lo scambio di una res (la valuta) contro ilpagamento di un prezzo. Se poi, prima della de-
correnza del termine il cliente decide, anziché dieseguire direttamente il pagamento, di compen-sarlo o di riportarlo con un’altra operazione, que-sta procedura potrà essere dettata anche da una fi-nalità speculativa, ma certo non incide sulloschema causale del negozio.Ciò che, però, non si coglie nel parere pro verita-te del Prof. Guido Rossi è che nelle operazioni incambi effettuate realmente dalle parti è mancatosin dall’inizio lo scambio della res, essendo stataun’operazione meramente nominale apposta suconti correnti di transito fittizio, con ciò inciden-do sullo schema causale del negozio. Non si puòsostenere, infatti, che nelle operazioni in cambi
sia mancato un pur minimo elemento di deriva-zione (il c.d. strumento finanziario, che è elemen-to qualificante della fattispecie di cui all’art. 1,comma 2, della legge 1791), senza il quale il con-tratto a termine non può essere assimilato ai valo-ri mobiliari.La relazione dei CTU, Prof. Preda e Basile, nellaparte relativa alla ricostruzione dei rapporti inter-corsi dalle parti, permette di mettere in luce lacausa dei contratti conclusi dalle parti, che risie-de nel finanziamento concesso dalla banca alcliente a fronte di un pegno di crediti per la Fil-mauro e nella fiducia accordata al cliente per ilDe Laurentiis personalmente: la linea di creditoaccordata, infatti, non trova la sua causa nel con-tratto di mutuo (contratto con il quale una parteconsegna all’altra una determinata quantità di da-naro o di cose fungibili e l’altra si obbliga a resti-tuire cose della medesima specie e qualità, ex art.1813 Codice civile), ma in un contratto con ilquale le parti hanno in qualche modo scommessosul rapporto di cambio tra la valuta originaria-mente erogata (dollari) e quella restituita (mar-chi): prova di ciò è la indisponibilità pressochétotale delle somme impropriamente definite co-me finanziamenti ma, in realtà, utilizzate comepuro riferimento dei negozi aleatori realizzati.In linea con quanto sopra, non è importante rile-vare in questa sede se alla perdita da parte degliattori sia corrisposto un effettivo guadagno daparte della banca: quest’ultima, infatti, ha chiusoin breve tempo le operazioni valutarie e, comehanno riferito i CTU, almeno sulla carta, non ap-pare aver lucrato l’intera differenza di cambi rea-lizzata nel periodo di durata dei contratti. Ciò cheè doveroso segnalare è la natura in sé e per séspeculativa delle operazioni intercorse tra le par-ti e la sua assimilabilità ad una transazione sustrumenti finanziari.La Corte di Cassazione, invero, ha affrontato ilcaso in cui i rapporti tra banca e cliente erano re-golati da un finanziamento colegato ad un pegnodi somme di danaro e di titoli di Stato specifica-
mente acquistati su incarico dei clienti; in tale ca-
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
782 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
7/14
so, per regolare il finanziamento - da corrispon-dere solo alla sua scadenza - tra l’importo finan-ziato espresso in moneta italiana alla data dellastipula e a quella della scadenza stessa, era statoconcluso un accordo di swap, ove il capitale eraragguagliato al valore convenzionale di marchitedeschi a un determinato tasso di cambio in lire,e i contraenti si impegnavano a versare la diffe-
renza alla controparte ove il controvalore in liredi tale importo fosse - alla scadenza - ad esso in-feriore o superiore (restando obbligati, nel primocaso, la banca e, nel secondo caso, i clienti).In tutte le operazioni eseguite dalla banca per conto dei clienti, la Suprema Corte ha ravvisatoun rapporto complesso da considerarsi unitaria-mente e, come tale, includibile nella categoria divalore mobiliare, come qualificato dall’art. 1 del-la legge 1/1991, sul presupposto che la natura delrapporto fosse costituita dalla negoziazione di«strumenti finanziari», ove per tali s’intendono icontratti a termine su strumenti finanziari colle-gati a valori mobiliari, tassi d’interesse e valute,
ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su ta-li valori mobiliari, tassi d’interesse e valute(Cass. n. 11279/1997).Ai fini della presente decisione, assume rilievo ilfatto che la Corte Suprema abbia considerato uni-tariamente i rapporti bancari collegati ad un inte-resse di speculazione, giudicando che la bancaavesse eseguito operazioni d’intermediazione divalori mobiliari, omettendo di sottoporre ai clien-ti un contratto avente le caratteristiche e i requisi-ti di cui all’art. 6, lett. c, della suddetta legge. Inparticolare, questo precedente giurisprudenzialeha sancito che l’accordo, complessivamente inte-so, avesse ad oggetto la parametrazione in valutedel flusso differenziale restitutorio previsto, efosse interamente riconducibile nella categoriadel Domestic Currency Swap per l’assimilabilitàdella causa negoziale atipica allo strumento fi-nanziario ampiamente recepito nella prassi deimercati finanziari europei e nazionali.Tale impostazione interpretativa si pone in lineacon quella offerta dall’ordinanza del 3 gennaio1996 da questo stesso Giudice, togliendo ogni ri-levanza alla difficoltà concettuale di operareun’assimilazione tra strumenti di investimento econtratti a termine su valute, e fornendo elementidi migliore comprensione della lettera della nor-ma, che fa oggetto dell’assimilazione ai valorimobiliari i «contratti a termine su strumenti fi-nanziari», da intendersi unicamente come «glistrumenti finanziari costituiti dai contratti a ter-mine collegati a...» (v. Cass. n. 11279/1997).Come già sancito all’interno del provvedimentodi cui all’art. 700 Codice di procedura civile del 3gennaio 1996, nel caso concreto, i contratti di fi-nanziamento e di compravendita a termine di va-luta sono stati essi stessi «strumenti finanziari»collegati a valute e come tali, risultano assimila-bili ai valori mobiliari assoggettati alla disciplinadelle SIM. Al di là delle espressioni usate dalleparti e di un approccio interpretativo esclusiva-mente formalistico, nel caso di specie ci si trovadi fronte a una fattispecie sostanzialmente unita-
ria ed assimilabile al contratto di swap, non tanto
nella struttura formale, ma attraverso la finalitàperseguita, ove i trasferimenti di capitali sono«poste» puramente formali rispetto all’ordine dicompravendita, in cui, in sostanza, il pagamentodelle differenze costituisce l’oggetto immediato eunico del contratto stipulato inter partes, siaall’atto della stipulazione del contratto, sia allascadenza.
L’elemento discretivo, dunque, di valore mobilia-re assoggettabile alla disciplina della legge SIM,non si ravvisa tanto nell’intento speculativodell’operazione (comunque presente nei rapportiintercorsi), ma nella struttura unitaria dell’opera-zione speculativa, anche se parcellizzata in sin-gole operazioni a termine, ove apparentementel’oggetto dello scambio sarebbe la valuta ma, inrealtà, sin dal suo momento genetico, è il diffe-renziale sugli scambi (per un’analisi dell’evolu-zione del concetto di «valore mobiliare» si rinviaall’ampia motivazione del provvedimento emes-so da questo Giudice nella fase cautelare).Le sottili distinzioni, di carattere puramente no-
zionistico e formale, delineate dai CTU, dal CTdi parte convenuta Prof. Ruozi e dal Prof. GuidoRossi nel parere pro veritate prodotto, per quantopregevoli da un punto di vista dottrinale, noncontribuiscono a individuare la funzione reale as-solta dai rapporti di compravendita a termine divaluta intrattenuti dalle parti con la banca, e ciòin base al presunto «spezzettamento» nel tempodelle operazioni svolte, a fronte di una strutturale«unitarietà» (data dalla contestualità degli scam-bi di valute) delle operazioni di swap.Nel contratto di swap, in effetti, si individua unacquisto a pronti di valuta contro lire e una ven-dita a termine di divise contro lire: si tratta, dun-que, di due operazioni distinte e contestuali che,in vista degli scopi perseguiti dalle parti, vengo-no riunite in un unico schema e, quindi, conside-rate come un unico contratto.Come sottolineato dai difensori degli attori, nonsi vede perché nel caso di specie, vista la medesi-ma finalità perseguita dalle parti, attraverso il fi-nanziamento (o il credito) concesso dalla bancaai clienti al fine di compiere operazioni di scam-bio di valute, non si possano considerare unitaria-mente, in maniera altrettanto convenzionale, an-che i rapporti intrattenuti tra le parti a partire dal-la data della prima operazione di acquisto a pron-ti e sino alla data di chiusura con versamento deldifferenziale, come è stato accertato dagli stessiCTU (v. comparsa conclusionale attorea, p. 48).Non tenendo conto dell’andamento dei rapportitra le parti, e affermando solamente che «anchequando ad una prima operazione se ne fa seguirein un momento successivo una seconda, al fine dicompensare o riportare il pagamento, oggettodel contratto a termine rimarrebbe la compra-vendita o lo scambio di valute» (v. parere pro ve-ritate del Prof. Guido Rossi), ci si soffermerebbesu una pura affermazione di principio che nontrova alcunché ed omette l’analisi del concretoatteggiarsi delle operazioni in esame.D’altra parte, il legislatore del 1991, accedendo auna nozione aperta di «strumento finanziario»
comprensiva anche degli scambi su valute, ri-
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
783 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
8/14
spetto alla definizione tradizionale di «valoremobiliare» che lo identifica con i titoli di massa,agganciati al carattere della negoziabilità deglistessi, ha sostituito una definizione di valore mo-biliare non tenendo più conto della sua struttura onatura cartolare, bensì della finalità perseguitadalle parti, rilevando il carattere finanziario dellostrumento operato con caratteristiche tali da pote-
re interferire sull’allocazione degli investimenti edel risparmio.Il concetto di valore mobiliare ai fini dell’assog-gettamento alle garanzie della legge «SIM», per-tanto, non rientra solamente il contratto di swapcome delineato dalla dottrina e dalla giurispru-denza, ma ogni contratto a termine che operi co-me strumento finanziario collegato a valori mo-biliari, tassi d’interesse o valute. Rammenta,inoltre, che l’art. 1 del Decreto legislativo 23 lu-glio 1996, n. 415 definisce tra gli strumenti fi-nanziari, alla lettera h), «i contratti a termine col-legati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, avalute, a merci e ai relativi indici, anche quando
l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento didifferenziali in contanti».Ciò che rileva, ai fini della presente decisione, èche, in pratica, gli attori hanno solo convenzio-nalmente ricevuto dalla banca dollari e hanno re-stituito marchi, realizzando una perdita in lire sul-la transazione. Nella sostanza, la banca e i clientihanno concluso un accordo nel quale la causa nonera il mutuo, ma un contratto in cui le parti hannoscommesso sul rapporto di cambio tra la valutaoriginariamente erogata e quella restituita. Provadi ciò è la disponibilità totale, al di fuori del sud-detto schema negoziale, delle somme definite co-me finanziamenti, ma in realtà utilizzate comepuro riferimento del negozio aleatorio.Ai fini della qualificazione del suddetto rapporto,infine, non rileva il fatto che la Consob abbia da-to direttive che stridono con l’interpretazione so-pra offerta, sancendo che le valute non costitui-scono valori mobiliari e che, pertanto, l’interme-diazione avente ad oggetto le valute stesse nonrientra tra le attività riservate alla società d’inter-mediazione, ma alle banche (v. ComunicazioneConsob 9 marzo 1995, n. DAL/RM/95001970, inBollettino Consob 1995, n. 3, p. 47). Se è vero,infatti, che le valute sono in generale beni diversidai valori mobiliari, è anche vero che, per espres-sa disposizione della medesima legge «SIM», gliscambi su valute possono operare come «contrat-ti a termine su strumenti finanziari e indici colle-gati a valori mobiliari, tassi d’interesse e valute»,come è avvenuto nel caso di specie, ove le com-pravendite a termine di valute non sono statel’oggetto e immediato del contratto posto in esse-re dalle parti, ma si sono rese strumento diun’unica operazione di scambio di differenzialisvolta a fini speculativi tra le parti.Contrariamente a quanto sostenuto dalla parteconvenuta, seguendo la menzionata linea interpre-tativa, non viene intaccato il ruolo istituzionale eregolamentare della Consob, nonché il valore pre-cettivo e l’indirizzo delle «Comunicazioni» prove-nienti da quest’organo di controllo per l’interpreta-
zione e l’applicazione corretta delle leggi e dei re-
golamenti che disciplinano i mercati mobiliari. Sa-rebbe errato sostenere che il giudice, come si è ve-rificato nel caso preso in esame dalla SupremaCorte nella citata decisione, solo per questo avreb-be dovuto giungere, motivando la sua decisione, adisapplicare» una direttiva della Consob dichia-randola illegittima perché contra legem.Come si è visto, le compravendite a termine di
valuta, nel caso in esame, si sono inserite in unoschema negoziale più ampio e complesso, ove labanca ha agito come intermediaria di strumentifinanziari nella forma di contratti a termine su va-lute, operando in sostanza come intermediaria divalori assimilabili ai valori mobiliari.La Comunicazione Consob citata dalla convenu-ta, in effetti, riguarda una fattispecie più sempli-ce di quella in esame, trattandosi di un contrattodi acquisto e di vendita di valuta, con fissazionedel prezzo di acquisto all’atto della conclusionedel contratto e consegna della valuta alla scaden-za di un termine non inferiore a venti giorni(DI/98001951, 14 gennaio 1998). In realtà, ana-
lizzando il contenuto delle comunicazioni dellaConsob, è agevole rilevare che esse non fannoche statuire in via generale che le operazioni dicompravendita a termine in valuta non rientranonella previsione della legge 1/1991, senza, peral-tro, arrischiarsi mai a dare una definizione di«compravendita a termine di valuta» in generale,e tantomeno a porgere una definizione in con-trapposto a quella di swap.Le comunicazioni Consob, a parere di questogiudice, rispetto al problema in esame, si tengonoa valle, perché la loro applicabilità presuppone lagià avvenuta soluzione al problema principale,ove è dirimente la qualificazione di una serie dioperazioni combinate tra di loro che non dannomai luogo a movimentazione reale di valuta, masolo a regolamentazioni «scritturali» di importiespressi in valuta estera (dollari contro marchi),con contestuale pagamento tra le parti in lire delsolo differenziale previsto dalla regolamentazio-ne delle operazioni stesse. In tale contesto, per-tanto, il rapporto non può essere qualificato sem-plicisticamente come una serie di negozi di com-pravendita a termine di valuta e, in quanto tale, ir-rilevante ai fini della legge posta a tutela degli in-vestimenti in valori mobiliari.L’attività svolta dalla banca sui differenziali deicambi di valute al di fuori delle garanzie sancitedalla legge SIM, e con le modalità sopra espresse,non merita tutela, se la si valuta sotto il profilo del-la legge n. 1/1991. Difatti, deve dichiararsi la nul-lità voluta dei rapporti di scambio di valuta attra-verso i differenziali sui cambi alla stregua delle de-cisioni giurisprudenziali più recenti che ravvisano,nelle norme che pongono la preventiva formascritta dei contratti-quadro (entro i quali svolgerele operazioni speculative), dei precetti imperativila cui violazione comporta la nullità voluta dei ne-gozi stessi, anche se formalmente non prevista co-me sanzione dal legislatore (Tribunale di Milano,6 febbraio 1997, Sofipa c. Hoare Govett, est. B.Marescotti, in Contratti 1997, I, 292 e seg.; Corted’Appello di Milano, n. 1735/1999 Fioroni c. Cre-
dito Italiano, Pres. Estensore M. Novità).
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
784 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
9/14
L’affermazione della convenuta, secondo la qua-le, sia il De Laurentiis e che la Filmauro, non me-riterebbero tutela giuridica in quanto, a loro vol-ta, avrebbero «tentato di arricchirsi medianteoperazioni speculative», non rilevano ai fini diuna corretta interpretazione della normativa inmateria.Lo scopo perseguito dal legislatore con la legge n.
1/1991 e con la successiva legislazione in materia(il c.d. Decreto Eurosim e il Decreto Draghi), èquello di fornire un’adeguata tutela dell’investito-re, che si ottiene con il garantire al soggetto «de-bole» del rapporto (e tale è da considerarsi anchese non si pone come uno sprovveduto) un maggior numero possibile d’informazioni dal soggetto«forte» del rapporto (banca o società d’interme-diazione mobiliare). La tutela accordata dal legi-slatore è talmente forte che lo stesso Tribunale diMilano, nella citata sentenza del 6 febbraio 1997,giudice est. M. Marescotti, ha ritenuto che sia ri-chiesta a pena di nullità la forma scritta per il con-ferimento dell’incarico ad operare sul mercato
mobiliare di cui alla legge n. 1/1991, anche neirapporti tra intermediari autorizzati ed operatoriqualificati ex art. 13, regolamento Consob n. 5387(quale non è, contrariamente a quanto sostenutodalla convenuta, il De Laurentiis).La finalità precipua dell’investitore, sia essa spe-culativa o d’investimento del risparmio, è del tut-to indifferente di fronte al dovere di carattere im-perativo, posto in capo all’intermediario, d’infor-mare adeguatamente l’investitore stesso, innanzi-tutto mediatne la consegna di un contratto scritto,ma anche a quello di fornire informazioni relati-ve al rischio connesso ad ogni singola operazio-ne, e di agire con la dovuta correttezza. Le normedi cui alla legge n. 1/1991, alla stregua di quantosopra, non devono essere degradate a meri princi-pi di correttezza e direttive valevoli solo nel mo-mento dell’esecuzione delle operazioni d’investi-mento, piuttosto che all’atto della stipulazionedelle stesse, come asserito dalla convenuta.La stessa lettera della legge esclude una siffattainterpretazione: si richiamano, in particolare, lelettere b) c) e d) dell’art. 6 (relativi alla formascritta e agli oneri di informazione sui rischi inrelazione alla situazione finanziaria del cliente),le quali contengono norme predisposte specifica-mente per la tutela dell’investitore al momentodella tipula del contratto. Difatti, è decisivo ilmomento in cui l’investitore decide se e quantoinvestire, posto che tale decisione è destinata ainfluenzare le successive singole operazioni svol-te nella fase esecutiva del mandato professionale.Il Credito Svizzero, muovendosi all’interno di uncampo normativo posto a tutela dell’investitore,non solo ha omesso di rispettarne i più elementa-ri precetti al momento della stipulazione del con-tratto, ma ha tenuto un comportamento reticenteanche nel prosieguo del rapporto, non fornendoagli attori le informazioni utili sugli altri rischiche stavano correndo nel momento in cui veniva-no proposti o accettati i rinnnovi delle operazionisui cambi di valuta: in merito, rileva il fatto che labanca abbia lateralmente deciso di non dar corso
ad ulteriori ordini dei clienti, quando le perdite si
erano già verificate e le garanzie dei clienti ri-schiavano di non essere più sufficienti a coprirle,dimostrando di avere percepito solo il rischiogravante su se stessa.Il suddetto comportamento è da censurare per-ché assunto in assoluto spregio della normativacitata: sin dal momento genetico del rapporto, leoperazioni speculative di compravendita a ter-
mine di valuta sono state operate liberamentetramite il finanziamento della banca alla Fil-mauro e con l’affidamento dato al De Laurentiispersonalmente, e hanno comportato per i dueclienti, in ragione della entità degli investimentie degli scambi di valute, le perdite - al netto de-gli ricavi conseguiti - rispettivamente di L.2.499.989.474 e di L. 4.614.443.281 (come ac-certato dai CTU), senza che fossero stati previa-mente concordati o indicati i rischi normali del-le operazioni da svolgere.Per quanto riguarda il rapporto di gestione patri-moniale, stipulato dal De Laurentiis e dalla pro-pria consorte con la banca, invece, deve rilevarsi
che i CTU hanno riscontrato che la perdita di po-co più di L. 200.000.000 a carico del De Lauren-tiis e della propria consorte, è stata subita in rela-zione a un rapporto regolarmente costituito informa scritta e in seguito all’espletamento di ope-razioni finanziarie di acquisto di «warrants - Cre-dito Svizzero SES call 550», rientranti nel rischionormale del negozio stipulato.Posto che è stata prospettata la violazione dell’art.6, lettera g) della legge SIM, che detta alle societàdi intermediazione mobiliare di agire con un inte-resse direttamente o indirettamente confliggentecon quello del cliente, a meno che il cliente nonabbia previamente ed espressamente acconsentitoper iscritto all’effettuazione dell’operazione, aconforto della tesi della banca convenuta, giova ri-scontrare che a norma dell’art. 9 del contratto-qua-dro stipulato dalle parti, il Credito Svizzero si eraimpegnato a non acquistare per conto del clientevalori emessi dallo stesso e da società o enti appar-tenenti al medesimo gruppo cui il CS appartiene,in quantità superiore alla quantità del controvalorecomplessivo del patrimonio in gestione (ammon-tante in L. 4.700.000.000) e che il valore degli ac-quisti di warrants del gruppo bancario ammontas-se a duecento milioni di lire circa.Conseguentemente, viene accolta la domanda de-gli attori in relazione alle prime due perdite, per-ché relative ad operazioni di carattere speculativosvolte al di fuori delle garanzie di cui alla legge n.1/1991, mentre viene respinta la domanda riguar-dante la statituzione di quanto perso dal De Lau-rentiis personalmente in forza del rapporto di ge-stione patrimoniale.Essendo stata accolta la domanda principale degliattori (azione di nullità dei rapporti posti in essere),i convenuti sono condannati a restituire agli attorile somme versate dagli stessi per ripianare le per-dite, oltre agli interessi al tasso legale decorrentidal giorno della domanda al saldo (data di messa inmora per l’illecito contrattuale; cfr. ss. 96/637). Ladomanda di condanna al risarcimento del dannoderivante da svalutazione monetaria, viceversa,
non può essere accolta, posto che gli attori non
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
785 I CONTRATTI n. 8-9/2000
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
10/14
hanno dato prova di avere subito, in concreto, unulteriore danno a causa della perdita di opportunitàd’investimenti nel mercato in cui operano (art.1224, I comma Codice civile e cfr. Cass. n.1986/742 e S.U. Cass. n. 1986/2368).Per contro, viene respinta la doman da della ban-ca convenuta, volta ad ottenere il pieno soddisfa-cimento del preteso credito di L. 2.750.268.437
nei confronti del De Laurentiis, per l’operazioneconclusasi in data 30 marzo 1995.Le spese della presente controversia, conseguen-temente, sono poste a carico della parte convenu-ta, sostanzialmente soccombente, e vengono li-quidate in favore degli attori (… omissis…).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione VII civile:
1) in accoglimento parziale delle domande at-toree, dichiara la nullità dei negozi di compra-vendita a termine di valuta e, per l’effetto, con-danna la convenuta a restituire agli attori quan-to effettivamente versato in relazione alla per-dita netta di L. 2.499.989.474 subita dalla Fil-mauro s.r.l. e alla perdita netta di L.4.614.443.281 subita da Aurelio De Laurentiis,
oltre agli interessi legali dalla domanda al sal-do.2) respinge le ulteriori domande degli attori;3) respinge la domanda riconvenzionale dellaparte convenuta;4) condanna la parte convenuta (Credito Svizze-ro) al pagamento delle spese processuali in favo-re delle parti attrici, (… omissis…).;5) sentenza provvisoriamente esecutiva.
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
786 I CONTRATTI n. 8-9/2000
IL COMMENTOdi Emilio Girino
Per quanto recenti, paiono per la verità quasi lontani i tempinei quali si disquisiva ancorasulla natura del contratto diswap e sulla sua assimilabilità omeno alla scommessa.Fatta giustizia di questa abnor-me lettura, la giurisprudenzapiù recente ha raffinato l’inda-gine, orientandosi verso la solu-zione di problemi più complessiche coinvolgono questa tipolo-gia di strumento finanziario.Uno, in particolare.La sentenza in commento, in-fatti, offre lo spunto per una ri-flessione, e fors’anche traccia ilpercorso per una definitiva so-luzione, in ordine all’annosoproblema del distinguo fra ope-razioni di compravendita valu-tarie e contratti di currency odomestic currency swap.Il problema, come noto si posegià all’indomani dell’approva-zione della legge Sim. La solu-zione si rinviene in alcune co-municazioni Consob, nelle qualila Commissione affermò ripetu-tamente che l’intermediazioneavente ad oggetto le valute, nonessendo queste valori mobiliari,non rientrava fra le attività riser-vate agli intermediari abilitati(1), mentre l’operazione che sitraducesse in una intermediazio-ne su strumenti derivati era daconsiderarsi senz’altro assog-gettata alla riserva di legge e al-la relativa regolamentazione (2).Tale distinguo non apparve tut-tavia sufficiente ad esaurire il
problema. Se è nitido il confine
fra la vendita di valuta e il deri-vato in valuta, la demarcazionetende a sbiadire qualora piùoperazioni in valuta venganoopportunamente collegate conil proposito di conseguire glistessi effetti di un derivato valu-tario.Né sarebbe possibile ascriverepuramente le operazioni incro-ciate su valute al genus dei con-tratti sintetici, argomentandodal fatto che l’»effetto deriva-to» non sarebbe che una conse-guenza della sommatoria finan-ziaria di unità viceversa piena-mente distinte sotto il profilogiuridico.Una simile conclusione pecche-rebbe di semplicismo oltre cherisultare viziata da un errore diqualificazione.Il titolo sintetico presuppone in-fatti due operazioni, due con-tratti finanziari di diversa tipo-logia, dalla cui combinazioneconsegue un determinato effettodi natura, però, esclusivamentefinanziaria. Nella compravendi-ta valutaria incrociata assistia-mo, invece, alla sovrapposizio-ne di due identiche operazioniche si distinguono solo per il se-gno.Il problema si conchiude, dun-que, in un semplice quesito: èconcepibile uno swap indirettorealizzato mediante la conte-stuale stipulazione e la conte-stuale esecuzione a scadenza didue operazioni di compravendi-ta valutaria?
In tema di negozio indiretto si è
formata nel tempo un’ampia,complessa e talora contradditto-ria dottrina. Non è questa la se-de per una disamina approfon-dita delle varie posizioni. Alnostro scopo, sarà sufficientetracciare i confini minimi di ta-le fattispecie astratta, nei termi-ni in cui esiste un consenso dif-fuso, per poi comprendere se ein che limiti la stessa possaadattarsi al caso che ci occupa.Notoriamente si ha negozio in-diretto quando per il raggiungi-mento di uno scopo pratico si fauso di una via traversa e cioè diun negozio (o di una combina-zione di diversi negozi tra lorocollegati) preordinato dalla leg-ge al perseguimento di obiettividiversi da quelli realmente vo-luti dai contraenti (3).La fattispecie può configurarsiovviamente solo là dove esistaun negozio tipizzato dall’ordi-namento, dove insomma esistauna figura tipica che consenta(o che vieti) di pervenire ad undato risultato che, invece, il ne-gozio impropriamente utilizza-to permette di raggiungere, ap-punto, indirettamente (come neicasi manualistici della vendita a
Note:
(1) Comunicazione n. 91007445 del18 dicembre 91; comunicazione n.95001970 del 9 marzo 1995.
(2) Comunicazione. n. 91007444 del18 dicembre 91.
(3) Di Paolo, Negozio indiretto , in Di- gesto civile , XII, 1995, 125.
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
11/14
prezzo vile stipulata per conse-guire l’effetto giuridico tipicodi una donazione o della vendi-ta a scopo di garanzia, conclusaper eludere il divieto di pattocommissorio).Il negozio indiretto ha sempre,come fine, l’elusione di una o
più norme applicabili al model-lo contrattuale indirettamenterealizzato. Se così non fosse, lastessa stipulazione indiretta nonavrebbe senso alcuno, non es-sendovi ragione di ricorrere aduno strumento «trasversale», diregola più laborioso e insicuro,ove esista uno strumento giuri-dico che direttamente e linear-mente consenta di conseguire loscopo desiderato.Tuttavia, la sanzione che l’ordi-namento giuridico commina al
negozio indiretto non è necessa-riamente l’invalidazione. Oc-corre quivi distinguere fra i ne-gozi indiretti aventi quale unicofine l’elusione di norme impe-rative che vietino il consegui-mento di un certo risultato(coincidente con quello effetti-vamente voluto dalle parti) e inegozi che, viceversa, realizzi-no lo stesso effetto di un nego-zio diretto, la cui disciplina diriferimento venga, per tale via,disapplicata.Nel primo caso, si è in presenzadi un negozio in frode alla leggeche, ai sensi dell’art. 1344 Co-dice civile, produce l’illiceitàdella causa e con essa la nullitàdel contratto (4).Nel secondo caso, l’ordinamen-to reagisce non già con la san-zione di nullità, bensì con la ri-qualificazione del negozio: os-sia, l’interprete (il giudice) rico-struisce l’effettiva volontà delleparti ed applica al negozio indi-retto la disciplina del negoziotipico indirettamente realizzato(5).Preliminarmente, occorre dun-que domandarsi se gli swap,colti nel loro momento geneticodi taglio eminentemente nego-ziale, possano o meno qualifi-carsi come negozi tipici.Anche in questo caso senza ec-cessivamente addentrarci in unacomplessa disamina astratta,possiamo concordare sulla cir-costanza che un contratto è tipi-co quando è sufficientementedefinito e disciplinato dall’ordi-
namento giuridico. Ora, come è
ben noto, l’option, il future o loswap o.t.c. vengono menzionatie definiti nel T.u.f. ma non rice-vono una compiuta disciplinanel nostro ordinamento.Tuttavia, è innegabile che, al dilà della ridotta normazione, det-ti contratti assumano connotati
ormai ben definiti, corrisponda-no cioè se non proprio a model-li tipici, quanto meno a formuletipizzate e che il loro riconosci-mento legislativo sia propria-mente diretto a sottoporli allanormativa sull’intermediazionemobiliare. In breve, dunque, illegislatore conosce i contrattiderivati, li definisce sufficiente-mente e, se da un lato, li legitti-ma, dall’altro opera tale legitti-mazione al prioritario fine disottoporli ad una disciplina spe-
cifica e cogente.Ciò premesso, appare dunqueastrattamente possibile l’evoca-zione della fattispecie del nego-zio indiretto anche con riferi-mento a stipulazioni finalizzateal conseguimento del risultatotipico di un negozio derivato.Si supponga, ad esempio, chedue parti A e B stipulino und.c.s. lira/dollaro in cui A si im-pegni a corrispondere a B il dif-ferenziale fra gli importi ottenu-ti applicando al capitale con-venzionale il cambio precon-cordato ove, alla scadenza, ilcambio a pronti del dollaro siamaggiore di quello concordato.Ora, se A e B stipulassero dueacquisti di valuta a termine in-crociati e coerenti per importi etassi a quelli poc’anzi indicaticon l’accordo di liquidarsi ilsemplice differenziale in lire, difatto essi realizzerebbero lostesso risultato che avrebberopotuto conseguire mediante unastipulazione diretta del d.c.s.A differenza di quanto accadenel negozio che conduce allaformazione di un titolo sinteti-co, nel caso poc’anzi descrittol’intento delle parti non consistesemplicemente nel consegui-mento di tale risultato, bensìnella «fusione» dei segmenticontrattuali che compongono lafattispecie. Le parti cioè stipu-lano due negozi giuridici miran-do ad ottenere gli effetti tipici diun contratto di swap (6).Il Tribunale di Milano in unapronuncia di qualche anno fa,
affrontando una fattispecie pro-
priamente conforme a quellaquivi ipotizzata, ha conclusonel senso dell’assimilazione disiffatta operazione ad un con-tratto di domestic currencyswap (7).Il caso merita un breve richia-mo, data la sua forte assonanza
con la fattispecie risolta dallasentenza in commento.L’intermediario aveva mutuato15.000.000 DM da altro interme-diario trasferendo detto importoal cliente al controvalore di18.555.000.000. Il cliente scam-biava gli stessi DM con l’inter-mediario con lire 15.801.000.000e ciò in adempimento di un sepa-rato contratto a termine e versan-do la differenza di 2.754.000.000.Nella sostanza, dunque, l’opera-zione si concludeva in uno scam-
bio a pronti e a termine di valuta,ancorché formalmente scissa indue distinte operazioni.Il magistrato privilegia la so-stanza alla forma, concludendoin termini inequivoci: «nell’am-bito del concetto di valore mo-
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
787 I CONTRATTI n. 8-9/2000
Note:
(4) Cass. 8 maggio 1984, n. 2795, inForo it. Mass., 1984.
(5) «Nel caso di negozio indiretto, che ricorre quando le parti utilizzino una
fattispecie negoziale tipica, e la pon- gano effettivamente in essere, ma per conseguire, oltre agli scopi ad essa propri, anche ulteriori scopi propri di un diverso negozio tipico, trovano ap- plicazione le norme del negozio im- piegato, per quanto riguarda struttura,forma ed elementi costitutivi, mentre le norme di quel diverso negozio sono operanti nella parte in cui si limitino a regolarne il risultato, indipendente- mente dallo strumento adoperato per il suo raggiungimento » (Cass. 21 di-cembre 1984, n. 6650, in Foro it.Mass. 1984).
(6) Il che non accade, invece, nell’am-bito della stipulazione di una c.d.synthetic option , che si realizza me-diante la stipulazione di un contrattodi opzione e la contestuale compra-vendita (di segno contrario a quellodell’opzione) dello strumento sotto-stante (per una maggior approfondi-mento sia consentito rinviare al mioOpzioni sintetiche , in Amm. & Fin.,1993, 13, 836). Le parti, con tale ope-razione, intendono propriamente sti-pulare un’opzione ed acquistare unostrumento finanziario, mantenendoformalmente distinti i due negozi edambendo unicamente all’attenuazio-ne o all’esaltazione dell’effetto specu-lativo derivante dall’operazione.
(7) Trib. Milano 3 gennaio 1996, inBanca, borsa e tit. credito, 1996, 550.
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
12/14
biliare di cui all’art. 1, comma 2° , l. n. 1 del 1991, dovrà ne-cessariamente essere ricompre-so non solo ciò che tradizional-mente è considerato «valoremobiliare», ma, cambiandol’angolo di prospettiva dell’in-terpretazione della norma, an-
che tutto ciò che sia utilizzato per attività di investimento, ri-levando precipuamente il carat-tere finanziario dello strumentoadoperato» (8).L’accento quindi cadde oppor-tunamente sull’elemento finali-stico sotteso dall’operazione.La pronuncia in commento rac-coglie questo insegnamento e losviluppa in termini ancor piùespliciti, giungendo alla defini-zione di alcuni indici di ricono-scimento dell’operazione di
swap indiretta.Nel caso di specie, l’operazioneera così configurata:1) fra le parti non era stato sti-pulato alcun contratto scritto;2) la documentazione rinvenutaconsisteva negli estratti conto diquattro conti correnti, dei qualidue in lire intestati ad uno degliattori e gli altri due, l’uno in liree l’altro in valuta, intestatiall’altra parte attrice;3) le operazioni di compraven-dita in valuta, pur implicandol’effettivo obbligo di compra-vendere divisa, in realtà non ve-nivano mai portate ad esecuzio-ne, bensì chiuse anticipatamen-te mediante la stipulazione dioperazioni di segno contrariocon conseguente addebito, suiconti dei clienti, dei differenzia-li negativi o positivi rivenientidalla compensazione dei risul-tati fra le due operazioni di (ap-parente) compravendita valuta-ria;4) l’operazione veniva infineassistita dall’apertura di una li-nea di credito garantita dalla co-stituzione in pegno, da parte delcliente, di crediti verso terzi.Nel ricostruire e riqualificare lafattispecie, il giudice milaneseenuclea alcuni profili, che pos-sono identificarsi come altret-tanti indici di unitarietà e distrumentalità dell’operazione.Il primo significativo rilievoconcerne i conti correnti che,per un verso, avevano mantenu-to un saldo perfettamente nullonel periodo di esecuzione, e, per
altro verso, non avevano com-
portato l’addebito di alcun one-re a carico dei clienti. Ciò con-sente al giudice di concludereche il conto corrente aveva una funzione meramente fittizia, ri-ducendosi ad un mero strumen-to di transito dei risultati delleoperazioni.
Il secondo rilievo è ancor piùpuntuale e costituisce l’elemen-to indiziario prioritariamenteassunto a base della decisionenonché, ai nostri fini, probabil-mente la chiave di soluzione delproblema.Il principale elemento discretivofra derivato e compravendita va-lutaria risiede nella causa del ne-gozio che, nel derivato, consistenel puro scambio del differen-ziale (il c.d. «scambio in sé»(9)), mentre, nella seconda ope-
razione, si sostanzia nello scam-bio di una res (la valuta, appun-to) contro il pagamento di unprezzo. Così causalmente rico-struito il negozio, la circostanzache l’esecuzione dell’operazio-ne comporti, per libera scelta deicontraenti, non già la consegnadella res e il pagamento del cor-rispettivo, bensì il suo «riporto»ovvero la sua compensazionecon altra operazione di segnocontrario, non è di per sé idoneaad incidere sulla causa del con-tratto, che pur sempre si sostan-zia nello scambio di un benecontro prezzo.Siffatta ineccepibile ricostru-zione mal s’attaglia, tuttavia, alcaso di specie. Il Tribunale rile-va che, nel caso in parola, man-cava, sin dall’inizio, lo scambiodella res, essendosi il negozioridotto ad «un’operazione me-ramente nominale apposta suconti correnti di transito fittizio». Dunque, a nulla rilevala configurazione astratta delnegozio, se poi in concreto laconvenzione fra le parti escludeche l’accordo persegua il suoeffetto tipico. Lo svuotamentodi tipicità del negozio assurge,dunque, nella valutazione delgiudice ad indice preminente diuna volontà negoziale contrariaall’apparente contenuto del pat-to.Sotto un terzo profilo, la diver-sa configurazione causale ipo-tizzata non appare rinvenibileneppure nel correlato contrattodi apertura di credito, a sua vol-
ta astrattamente riconducibile al
contratto di mutuo, posto che,anche in questo caso il negozio«trova la sua causa …in uncontratto con il quale le partihanno in qualche modo scom-messo sul rapporto di cambiotra la valuta originariamenteerogata (dollari) e quella resti-
tuita (marchi): prova di ciò è laindisponibilità pressoché totaledelle somme impropriamentedefinite come finanziamenti ma,in realtà, utilizzate come puroriferimento dei negozi aleatorirealizzati».Infine sotto un quarto profilo,non assume rilievo la circostan-za che l’operazione sia stata«parcellizzata» in singole ope-razioni a termine. Nel caso dispecie l’operazione, attuata me-diante la contestualità degli
scambi, era da considerarsi so-stanzialmente unitaria e ad ave-va ad oggetto solo apparente-mente lo scambio della valuta,il vero fine perseguito dalle par-ti consistendo in realtà nelloscambio, ab origine, del solodifferenziale sui cambi.Per pervenire a questa conclu-sione la sentenza opera unascomposizione degli elementicostitutivi la fattispecie del do-mestic swap, correttamente rin-venendoli a) in un acquisto atermine di valuta contro lire; b)in una vendita a termine di lirecontro valuta; c) nella ricon-giunzione delle due unità ele-
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
788 I CONTRATTI n. 8-9/2000
Note:
(8) Trib. Milano, 3 gennaio 1996, loc.ult. cit.
(9) La tesi venne da noi anticipata allacomparsa degli swap sul mercato ita-liano (Girino - Vecchio, Future, option,swap, commercial papers - Aspetti fi- nanziari, contrattuali e giuridici , Mila-no, 1988, 112), sostenuta all’epoca
da un’isolata dottrina (Cavallo Borgia,Nuove operazioni dirette all’elimina- zione del rischio di cambio , in Contrat- to e Impresa , 1988, 406) e quindi ab-bracciata dalla dottrina successiva(Caputo Nassetti, Profili legali degli in- terest rate swap e degli interest rate and currency swap , 1992, in Dir.Comm. Internaz., 91; Preite, Recenti sviluppi in tema di contratti differen- ziali semplici (in particolare caps,floors, swap, index future) , ivi , 1992,184; Rossi, Profili giuridici del merca- to degli swap di interessi e di divise in Italia , in Banca, borsa, tit. cred,, 1993,I, 613; Giuliani, I «titoli sintetici» tra operazioni differenziali e realità del ri- porto , in Dir. Prat. Tribut., 1992, I,
883).
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
13/14
mentari in un unico contratto,volutamente così stipulato alpreciso fine di non già di assi-curare lo scambio effettivo del-le valute, bensì di permettere al-le parti di lucrare sulle oscilla-zioni dei corsi delle divise di ri-ferimento.
Ma se questa è, come indubita-bilmente è, la funzione del do-mestic currency swap, alloranon v’è ragione per non ricono-scerne gli stessi contorni inun’operazione quale quella inparola, in cui, al di là dell’ap-proccio nominalistico e dell’ar-tificio consistente nello «spez-zettamento» formale delle sin-gole unità elementari, l’oggettodell’intesa è comunque loscambio del differenziale suicambi. Da qui, dunque, il prin-
cipio enucleato nella massima,per il quale «nel concetto di va-lore mobiliare ai fini dell’as-soggettamento alla legge SIM … non rientra solamente il con-tratto di swap come delineatodalla dottrina e della giurispru-denza, ma ogni contratto a ter-mine che operi come strumento finanziario collegato a valorimobiliari, tassi di interesse ovalute».Rispetto alla pronuncia del1996 dianzi menzionata, la sen-tenza in commento rappresentaun significativo contributo allacompilazione, sul piano dogma-tico, della nozione di swap (epiù in generale di derivato) in-diretto. La tesi finalistica vienerecuperata e sviluppata, attra-verso un aperto e convincenteconfronto con gli elementi diforma e di sostanza che conno-tano le due tipologie di negozio.In tal senso la sentenza, comepure la motivazione si fa pre-mura di rilevare, non contraddi-ce affatto l’impostazione datadalla Consob e il distinguo fraswap valutari e negoziazioni invaluta. Essa semmai coglie il li-mite di quel distinguo, che si èformato dando per presuppostigli elementi costitutivi delle duetipologie, ma, si legge nellapronuncia, senza «arrischiarsia dare una definizione di «com- pravendita a termine di valuta»in generale, e tanto meno a por-gere una definizione in contrap- posto di swap».La distinzione viene dunque
confermata, ma, nel contempo,
viene dato rilievo alla sin quisfumata linea di demarcazionefra le due fattispecie, attraversouna loro definizione in positivo.Lo scopo della riqualificazioneè propriamente quello di evitareche, per via indiretta e con for-mule composite, si pervenga al-
chemicamente alla creazione distrumenti derivati senza che imedesimi vengano sottopostialla disciplina vincolistica di ri-ferimento. Con ciò, inoltre, lapronuncia sancisce definitiva-mente la tipizzazione delloswap, la sua riconduzione cioèad una fattispecie positivamen-te definita e come tale ricono-scibile nonché sottoposta aduna disciplina imperativa: dun-que non eludibile attraverso ilricorso trasversale alla negozia-
zione indiretta (10).L’ineccepibile conclusione cuiperviene la sentenza appare delresto coerente con lo schema le-gislativo oggi delineato nel Te-sto Unico della finanza. Il deri-vato non si riconnette solo agliarchetipi ormai noti e ricondu-cibili ai modelli di future, op-tion e swap, ben potendo mani-festarsi in ulteriori ed impreve-dibili forme, frutto della combi-nazione di uno più modelli ov-vero di loro versioni più specifi-che e «raffinate». Il principio èstato prudentemente affermatoall’art. 1, secondo comma, lett.
j) del T.U., là dove si affermache fra i derivati rientrano an-che «le combinazioni di con-tratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere».Ne consegue, pertanto, che an-che la stipulazione indiretta che«combini» i singoli elementifondamentali, siano essi titoli ocontratti, può generare la pro-duzione di un derivato come ta-le unitariamente ed autonoma-mente considerabile e qualifica-bile.Pare dunque lecito concludereritenendo applicabile la disci-plina di cui sopra anche alleoperazioni che, mediante solu-zioni contrattuali indirette, rea-lizzino risultati, finanziari egiuridici, corrispondenti a quel-li conseguibili attraverso i deri-vati «tipizzati» dall’ordinamen-to.Affermata l’assimilabilità, sulpiano giuridico, dei «derivati
indiretti» a quelli ordinariamen-
te e direttamente stipulati, si po-ne il problema di stabilire conquali criteri si possa o si debbapervenire alla individuazione ealla riqualificazione di siffatteoperazioni.Da quanto sopra esposto apparedel tutto evidente che non esi-
stono strumenti predefiniti o ri-ferimenti assoluti e oggettiva-mente riconoscibili che consen-tano una qualificazione certa. Ilprincipio finalistico, che presie-de alla ricostruzione, fa sì chenon si possa stabilire con esat-tezza e aprioristicamente quan-do l’incrocio di una o più opera-zioni sia mirata alla creazioneindiretta di un derivato.Occorre dunque procedere em-piricamente, distinguendo anzi-tutto le fattispecie più evidenti e
formulando una serie di ipoteti-ci indici di riconoscimento.Esistono indubbiamente casinei quali la stipulazione indiret-ta si appalesa in tutta evidenza.Così, ad esempio, una vendita atermine di valuta senza predefi-nizione del tasso, cui si aggiun-ga un impegno di riacquisto adun tasso predeterminato, in unocon l’impegno di operare una li-quidazione del solo differenzia-le (fra la prima vendita el’eventuale riacquisto) esprimetipicamente il meccanismo co-struttivo di un d.c.s.Tale esempio costituisce un casoclassico di stipulazione indiretta.Gli indici di riconoscimento che
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
789 I CONTRATTI n. 8-9/2000
Nota:
(10) Intermedia alla due pronunce èpoi la disposizione di cui al provvedi-mento Isvap del 19 luglio 1996 in te-ma di impiego dei derivati da partedelle imprese di assicurazione. Il se-condo comma dell’art. 1 del provvedi-mento testualmente dispone: «Ai fini
del presente provvedimento sono as- similati agli strumenti derivati tutti i contratti che, a prescindere dalla ter- minologia adottata, presentino carat- teristiche tecnico-finanziarie assimila- bili a quelle di alcuno dei contratti pre- cedentemente indicati, quali ad esem- pio i contratti di compravendita di va- luta a termine ». Il problema non veni-va con ciò propriamente risolto, ma dicerto correttamente impostato sul pia-no del metodo. Del resto, in un prov-vedimento di ordine generale, unmaggior grado di dettaglio, spinto sinoal punto di definire analiticamente iparametri di riconoscimento diun’operazione indiretta, sarebbe statoeccessivo e inopportuno, introducen-
do il rischio di un’agevole elusione.
-
8/17/2019 3301468_cntr_2000_00_00_8-9_COM_777_00777
14/14
possono desumersi, anche allastregua degli insegnamenti dellapronuncia in commento, sonodunque i seguenti:a) l’omogeneità, nominativa equantitativa, dei valori scam-biati;b) la contestualità delle opera-
zioni;c) l’assenza dello scambio ef-fettivo della res; e quindid) la previsione di un criterio diliquidazione del solo differen-ziale.Ciò non significa che la ricor-renza di detti indici equivalganecessariamente a prova dellanatura indiretta del negozio de-
rivato. L’interprete dovrà pur sempre valutare, caso per caso,la finalità specifica dell’opera-zione, riconoscendovi una sti-pulazione indiretta solo quandosia evidente l’intento di perve-nire ad un risultato identico aquello assicurato da uno stru-
mento derivato, sì che non pos-sa altrimenti giustificarsi il ri-corso ad una frantumazione delcontratto in singoli negozi indi-viduali di diversa natura.In tale opera ermeneutica, l’in-terprete potrà avvalersi anche diulteriori elementi di natura indi-ziaria, come ad esempio, nel ca-so esaminato, l’impiego fittizio
di contratti di conto corrente ol’indisponibilità delle somme diuna correlata apertura di linea dicredito, ma sempre con quellanecessaria serenità e prudenzache deve presiedere alla lettura ealla qualificazione del volere deicontraenti. La valutazione dei
parametri di riconoscimento re-sta dunque affidata alla sensibi-lità dell’interprete, il cui criterioguida rimane quello della ricercadella finalità della stipulazione,essenzialmente rivelata dalla so-stanziale unitarietà dei negozi.Lo stesso criterio, cioè, che pre-cisamente ha informato questapregevole pronuncia.
GPARTE PRIMAGIURISPRUDENZA
790 I CONTRATTI n. 8-9/2000
Ho deciso di aderire all’AIRC come:
Socio aggregato da L. 6.000 Socio ordinario da L. 50.000 Socio a ff il ia to da L. 10.000 Socio sostenitore da L. 500.000 Socio animatore da L. 25.000
e ho versato
sul c/c postale 307272 con assegno bancario allegatoÈ inteso che come socio ho diritto alla tessera di iscrizione e al notiziario mensile
cognome
nome
via n.
cap. località prov.
Tagliare e spedire in busta chiusa a: AIRC - via Corridoni 7 - 20122 Milano
AIUTACI AD AIUTARTICosì abbiamo speso i tuoi aiuti negli ultimi tre anni:40 miliardi a Istituti e Laboratori di tutta Italia specializzati in Oncologia,
oltre 300 Borse di Studio per ricerche in Italia e all’estero.1/3 della Ricerca Nazionale dipende dalla nostra forza. Grazie a te!
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
20122 Milano - Via Corridoni, 7 - Conto Corrente Postale 307272
✂